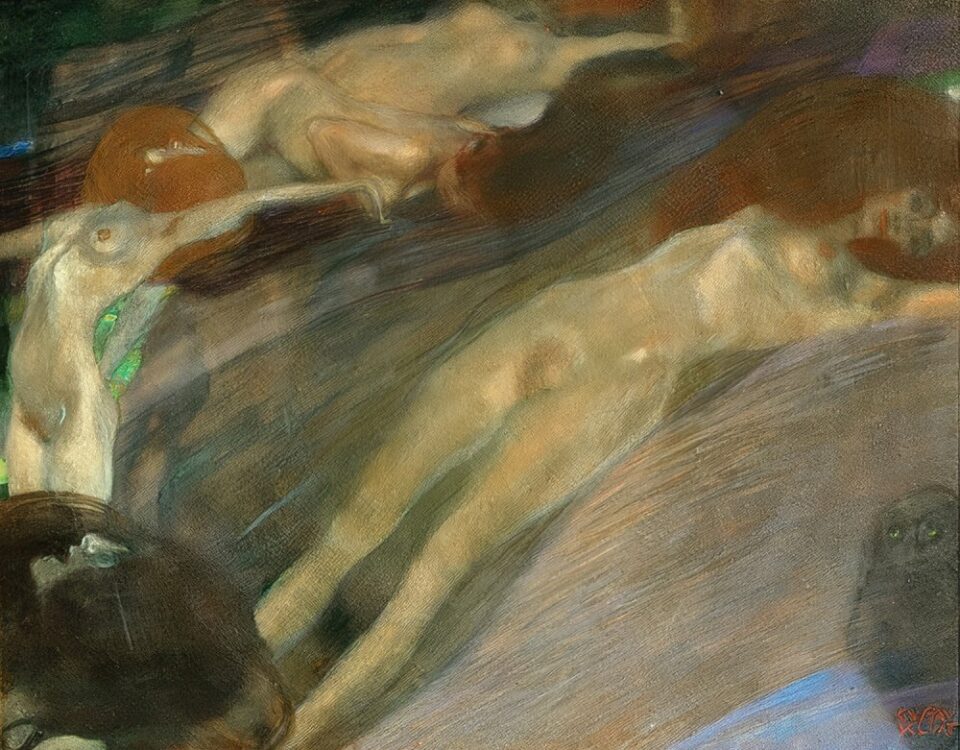La cucina alchemica di Leonora Carrington
16 Novembre 2025
E il Cristo di Renan scatenò una guerra
16 Novembre 2025
di VINCENZO TRIONE
Il Pantheon di Mimmo Paladino. Oltre a scrittori (Omero, Dante, Ariosto, Marco Polo, Cervantes, Collodi, Pound, Sanguineti), vi confluiscono tanti artisti. Da Leonardo a Piero della Francesca, da Klee a Chagall, a Licini. Momento centrale, in questa sorta di museo immaginario, è Beato Angelico, al quale Paladino ha idealmente dedicato la sua ampia antologica, curata da Costantino D’Orazio e da Aurora Roscini Vitali, ospitata in diverse sedi museali umbre: la Galleria nazionale dell’Umbria di Perugia, la Rocca Albornoz di Spoleto e Palazzo Ducale di Gubbio.
Una mostra-labirinto, che conduce dai dipinti astratti alle incursioni nell’ambiente, dai monocromi segnati da trasparenze e da densità agli esercizi mistici, dai monumentali lavori degli anni Settanta e Ottanta, realizzati durante la feconda stagione della Transavanguardia, caratterizzati da un espressionismo attraversato da episodi materici, alle sculture che indicano il bisogno di uscire dal quadro (a Perugia). Passaggio ulteriore: le installazioni con frammenti combusti, galleggianti nel vuoto, simili a relitti di una mareggiata; i «dormienti» rannicchiati e silenti, che evocano i calchi pompeiani (a Spoleto). E la scala d’impronta poverista fatta di carte con teste e volti piegati e incastrati (a Gubbio). Infine, le opere più recenti: una grande tela abitata da corpi, da numeri e da rami; tre «porte», con una silhouette umana nera su fondo d’oro (sempre a Palazzo Ducale). E, a Perugia, alcuni inediti interventi urbani (dalla fine di giugno, sulla facciata di Palazzo Baldeschi, Concerto in piazza, omaggio alle tradizioni umbre rilette in chiave contemporanea; e, nel periodo natalizio, le luminarie d’artista che accenderanno corso Vannucci).
Il cuore di questo viaggio è D’apres Beato Angelico (nella Sala 10 della Galleria nazionale). In assenza dei pannelli che compongono il Polittico Guidalotti (esposto nella grande mostra su Beato Angelico a Palazzo Strozzi di Firenze), Paladino ha riscritto questo capolavoro: ha ripensato il motivo della cornice e il tema dell’icona sacra; e, in chiave attuale, ha reinventato gli abiti dei santi, i paesaggi della predella, i dettagli degli scomparti laterali. Un modo originale di fare un tributo a un maestro abile, come aveva ricordato Giulio Carlo Argan, nel combinare la filosofia tomista con quella neo-platonica; sapiente nel farsi interprete di una conoscenza fondata su ragioni umane e su intenzioni divine.
Paladino si lascia sedurre da questo «soprannaturalismo» (per dirla con Roberto Longhi), suggerendo una ripetizione differente. Attraverso sentieri laterali, si confronta con la predella di Beato Angelico, che definisce uno spazio metafisico destinato all’intensità della contemplazione. Dopo avere assunto la «fonte», la emancipa dall’identità in cui l’erudizione e la filologia tendono a inchiodarla. La tratta come materia bruciante. Ne coglie tensioni implicite. La interiorizza, avviando un dialogo visionario. Con un obiettivo: liberare ciò che, in essa, è movimento, ritmo, tensione, vita sotterranea, significato non ancora espresso.
Quasi un remake, affidato al legno e alla tela grezza. Una disinvolta scorribanda poetica. Per visualizzare situazioni, personaggi e luoghi fermati da Beato Angelico, Paladino ne decostruisce le impaginazioni auree. Officiante e sciamano, usa suggestioni visive tratte dal suo «modello». Ne estrae passaggi, cromie, artifici. Predispone un galateo di gesti, combinando eterogenee assonanze: memorie antiche, medievali e rinascimentali, affioramenti autobiografici, figure antropomorfe, tracce naturalistiche.
Paladino considera quel «testo» visivo remoto come un soggetto da riattivare. Non lo costringe a una «deposizione» univoca. Lo interroga. Lo usa come punto di partenza. Lo pasticcia. Lo profana, fino a renderlo irriconoscibile. Lo tradisce, arricchendolo di altre presenze. Se ne serve per un autentico flusso di coscienza. In questo modo ne accresce l’aura.
Ecco che cosa è diventata la drammaturgia di Beato Angelico, nelle sue mani. Icone concrete e imprendibili. Maschere ermetiche. Barlumi densi o rarefatti. Simboli, archetipi. Paesaggi vagamente giotteschi. Geometrie un po’ alla Klee. Una moltitudine che, senza lasciarsi ingabbiare dalla camicia di forza della sintesi, è tenuta insieme dall’oro della pala.
Ma, forse, la mostra umbra di Paladino è anche altro. Si dà come indiretta riflessione su un’epoca lontana eppure di stringente attualità: l’Umanesimo. Età dominata, come ha sottolineato Massimo Cacciari (La mente inquieta, Einaudi), da aspre lotte tra opzioni differenti; fase in cui si studia il passato per progettare il futuro; teatro costellato di sfide e di tormenti intellettuali, di emozioni esasperate e di scontri tra concezioni del mondo antitetiche; periodo «oscillante tra memoria e oscuri presagi, crudo scetticismo e audaci idee di riforma»; tempo di crisi, di violente passioni, di drammatiche disperazioni. Paladino sembra dire: l’Umanesimo è ancora qui, ora. Beato Angelico, nostro contemporaneo.