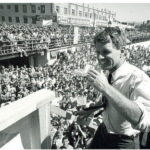Troppe voci si sono espresse sugli aspetti fiscali della manovra di bilancio, voci non basate su una conoscenza storica, tecnica e politica di questo non facile tema. Le uniche analisi serie sono state quelle di Banca d’Italia, della Corte dei Conti, dell’Istat e dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio. Quest’ultimo organismo ha calcolato che la riduzione dell’aliquota Irpef dal 35 per cento al 33 per cento per la fascia di reddito da 28.000 euro a 50.000 euro porta benefici assai modesti ai diversi percettori di reddito.
Su base annua il beneficio è di 23 euro per gli operai, 123 euro per gli impiegati, 55 euro per i pensionati e 408 euro per i dirigenti. Il beneficio massimo è comunque di 440 euro di cui possono godere anche i redditi superiori a 50.000 euro ma che in percentuale sul reddito totale rappresentano un valore sempre più basso: 0,88 per cento su un reddito di 50.000 euro, 0,44 per cento su un reddito di 100.000 euro e 0,22 per cento per un reddito di 200.000 euro.
Nella sostanza si vede innanzitutto che si tratta di benefici minimi che non migliorano l’economia delle famiglie italiane. Evidentemente si tratta ancora una volta di un provvedimento che non ha come scopo principale il bene dei cittadini ma la ricerca del consenso elettorale, come del resto la rottamazione delle cartelle esattoriali e la flat tax. Un governo che agisse veramente per il benessere dei cittadini dovrebbe innanzitutto disegnare il piano degli investimenti per la formazione, la salute, la ricerca, l’innovazione e altre spese per l’anno o gli anni successivi e sulla base di questi fissare la politica fiscale necessaria al relativo gettito senza penalizzare o favorire alcuna categoria di contribuenti.
In parte questo è avvenuto dalla fine della seconda guerra mondiale fino alla fine degli anni settanta del secolo scorso.
In quegli anni si creò il welfare dei paesi occidentali grazie alle politiche liberali di Keynes e Beveridge e si seguirono certi principi etici nella redistribuzione della ricchezza. In quegli anni anche la politica fiscale seguiva una certa etica. In Italia la parte di reddito delle persone fisiche che superava i 550 milioni veniva tassata al 70 per cento e in Gran Bretagna alla parte di reddito che superava le 200.000 sterline si applicava l’imposta del 83 per cento.
L’economia cresceva e questa tassazione così progressiva era accettata. Poi nei primi anni ottanta arrivarono Margaret Thatcher e Ronald Regan e fu il disastro.
Per sostenere l’economia che cominciava dopo 35 anni a dare segni di flessione questi due statisti si inventarono una ricetta basata sul liberismo, cioè su un mercato libero che doveva regolarsi da solo senza più l’intervento dello stato e la riduzione delle imposte.
Questa strada ha portato alla riduzione della spesa per il welfare, a un poco significativo aumento dei consumi, all’aumento delle disuguaglianze sociali e al dominio della finanza, soprattutto quella speculativa che ci portò alla grave crisi del 2007 e 2008 che si ricorda per il fallimento della Enron e della Lehman Brothers. Purtroppo i modesti tentativi di sanzionare la finanza speculativa non hanno avuto successo e la politica non si è neppure accorta che l’aumento delle disuguaglianze sociali rappresentano un grave vulnus per l’economia perché riducono progressivamente i consumi.
È forse il momento di ritornare all’etica economica di 50 anni fa. Innanzitutto non è più accettabile che alti dirigenti di banche e imprese abbiano emolumenti annui pari a 700 volte lo stipendio di un impiegato e compensi di liquidazione di 20 o più milioni di euro dopo pochi anni di servizio. Negli anni Settanta del secolo scorso Adriano Olivetti sosteneva il principio etico che la remunerazione degli alti dirigenti non doveva superare di 10 volte quella dell’ultimo operaio.
Poi si dovrebbe rivedere la politica fiscale basandola davvero su una progressività – come richiesto dall’articolo 53 della nostra Costituzione – che possa arrivare almeno a un’aliquota del 60 o 65 per cento. Bisognerebbe poi assoggettare alle stesse aliquote tutti i redditi prodotti: di lavoro, di capitale, di interessi e immobiliari evitando così i privilegi di alcune categorie di contribuenti. In questo caso non ci sarebbe bisogno di un’imposta patrimoniale.
Da come Giorgetti difende la sua manovra, anche a dispetto delle critiche di Banca d’Italia e altri, sembra che i suoi studi alla Bocconi siano stati dimenticati o cancellati da esigenze di misera politica dalle quali un serio ministro dell’economia non dovrebbe mai lasciarsi condizionare.