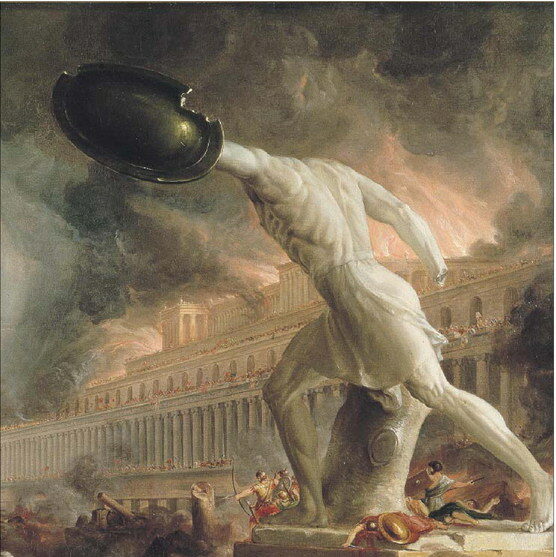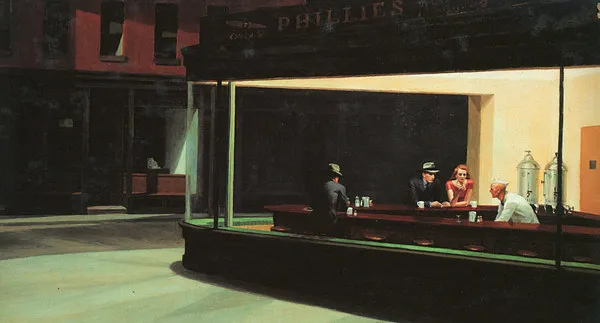La delega alla felicità e il vuoto della politica: la speranza che manca
21 Novembre 2025
DIGEST STRATEGICO – Sabato 22 novembre 2025
22 Novembre 2025Siena, l’arte in subappalto?
Autonomia culturale, privati dominanti e la sindrome della “succursale”
di Pierluigi Piccini
C’è un punto che dobbiamo affrontare con franchezza: Siena rischia di diventare la succursale culturale di altri. La retrospettiva dedicata ad Armando Testa al Palazzo delle Papesse restituisce esattamente questa impressione. Un progetto nato altrove, cresciuto altrove e giunto in città già confezionato, come uno di quei “grandi eventi” che si espongono più che si pensano.
Non è in discussione la qualità: Testa è una figura centrale della cultura visiva italiana e la mostra è ricca, scenografica, piena di materiali preziosi. Ma la questione decisiva riguarda l’autonomia. Prima di arrivare a Siena, il percorso critico su Testa era già stato elaborato a San Gimignano, nel 2020 con Le Sirene di Armando Testa e nel 2024 con Lord Finger. Quelle mostre avevano già esplorato in profondità l’immaginario dell’artista, sperimentandone linguaggi e soluzioni. La retrospettiva delle Papesse non nasce da un’elaborazione cittadina: si presenta come la terza tappa di un processo che altrove ha già trovato una sua forma. A Siena si amplifica, si riorganizza, ma non si reinventa.
È naturale che un archivio d’autore orienti materiali, prestiti e apparati. Ma proprio per questo una città dovrebbe interrogarsi su quale sia la lettura che giustifica una nuova mostra. Perché riproporre un progetto già esposto? Per quale motivo rimettere in scena qualcosa che altrove ha trovato una sua compiutezza critica? La sola estensione dimensionale non è una motivazione sufficiente. Un’esposizione ha senso quando porta uno sguardo nuovo, quando nasce da un’identità territoriale, quando offre una prospettiva che altrove non è emersa. Oggi questa specificità non si vede.
Il Palazzo delle Papesse non è più un’istituzione pubblica. È uno spazio privato, e questo dato, spesso eluso, spiega molte cose. La programmazione culturale pubblica, quella che dovrebbe indicare una direzione e assumersi responsabilità, sembra evaporata. Non c’è una regia, non c’è un disegno, non c’è un’idea coerente di città.
Ma il problema non riguarda solo le istituzioni. Riguarda soprattutto il pubblico cittadino, totalmente estromesso dal processo culturale. La comunità non partecipa, non è chiamata a discutere, non contribuisce alla definizione delle priorità. La cultura raggiunge Siena già compiuta, chiusa e immodificabile, senza che chi abita la città possa riconoscervisi o sentirla parte del proprio orizzonte. È questo scollamento a impedire la nascita di un ecosistema vivo. Quando cittadini, studenti, operatori, scuole, università non sono coinvolti, il territorio non cresce: semplicemente ospita ciò che altri decidono.
La mostra su Vecchietta, annunciata e mai realizzata, è un caso esemplare. Rivela quanto sia fragile il sistema quando manca una guida e quando il coinvolgimento della città non è parte integrante della progettazione culturale. Nel vuoto che si crea, il privato avanza e definisce contenuti, tempi, linguaggi, perfino le priorità narrative. Ma non perché sia troppo forte: perché non trova un interlocutore all’altezza.
In un sistema equilibrato, la dialettica tra pubblico e privato è una ricchezza. Il privato porta dinamismo, reti, capacità produttive; il pubblico garantisce continuità, visione, responsabilità sociale. Quando queste due energie si confrontano e si integrano, il territorio si sviluppa. Quando una delle due manca, l’intero sistema si deforma e diventa dipendente da un’unica fonte di iniziativa.
Oggi Siena si trova esattamente in questa condizione: un privato attivo, un pubblico istituzionale debole, un pubblico cittadino invisibile. Il risultato è un ecosistema monocorde, dove la città riceve cultura invece di produrla, e dove le mostre, pur belle e ben allestite, non lasciano radici né generano crescita.
Non è questo il destino che Siena merita. E non è per questo che è stato riaperto il Palazzo delle Papesse, un luogo che avevo immaginato come spazio di produzione, confronto, rischio. Accettare di essere l’ultima fermata di un circuito pensato altrove significa rinunciare alla propria identità.
Collaborare è necessario. Accontentarsi, no.
Se Siena vuole tornare a essere protagonista, deve ricostruire una programmazione pubblica forte, responsabile, capace di coinvolgere la comunità e di dialogare con il privato da una posizione autonoma. Solo così la cultura potrà generare valore, riconoscimento e futuro. Non altrove, ma qui. Non per altri, ma per la città e per chi la vive.