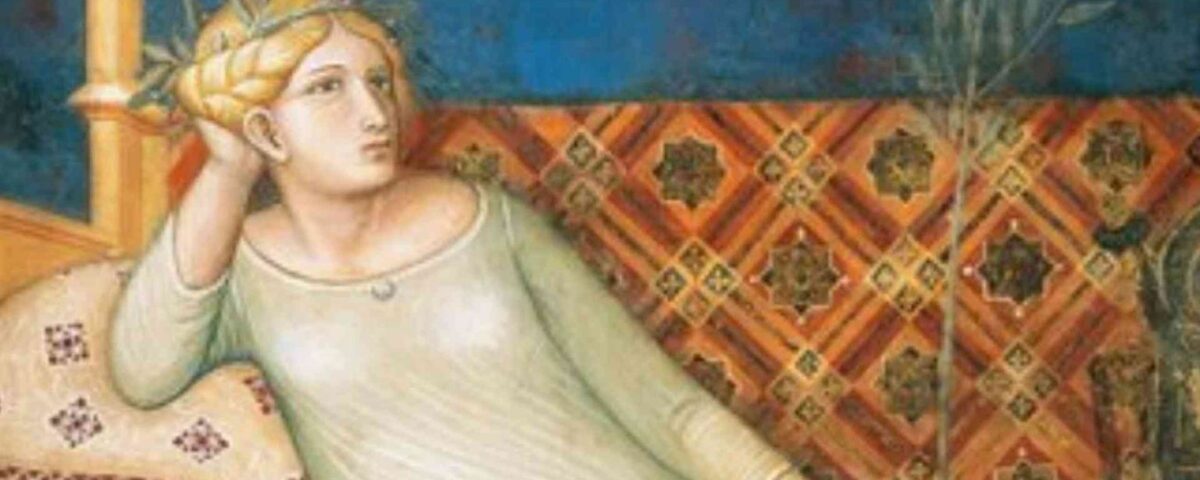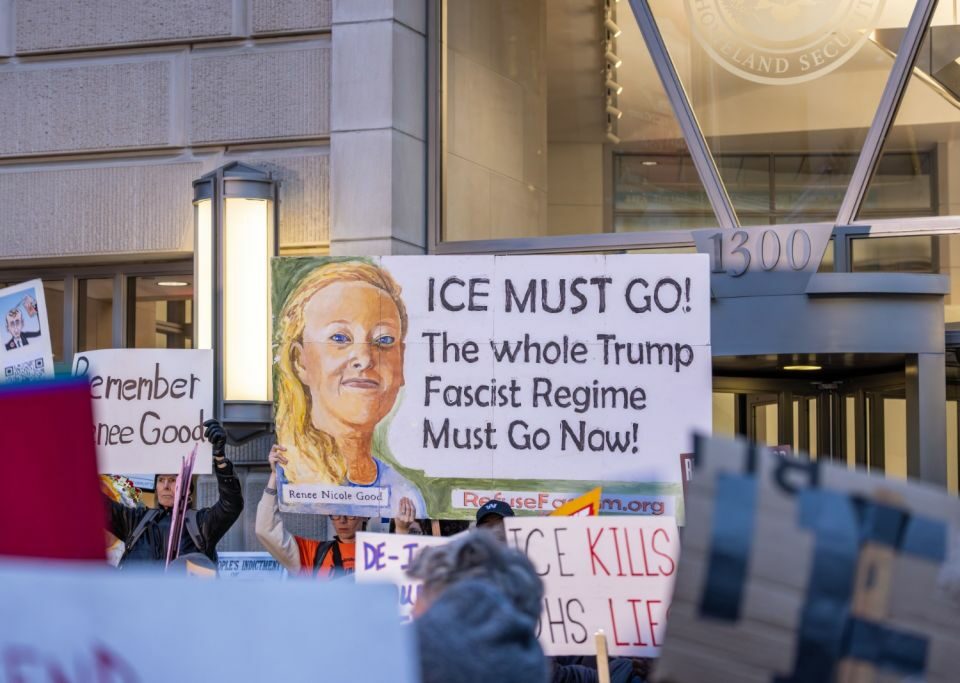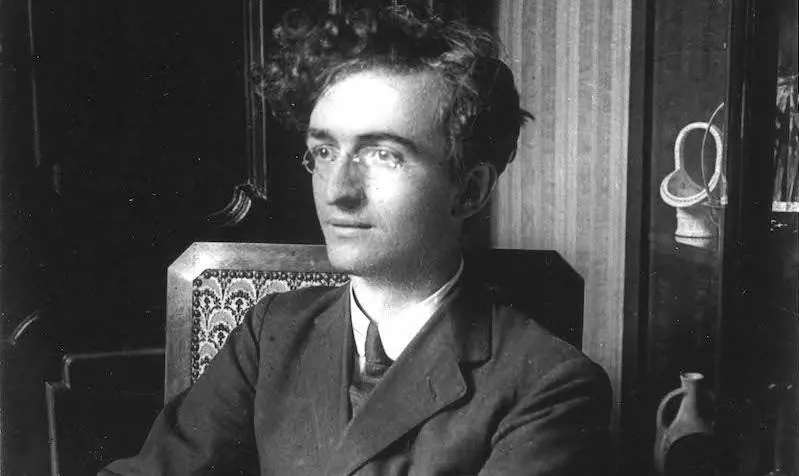Un timbro sensuale che stregava i grandi autori
22 Novembre 2025
La guerra che c’è, la casa comune che non c’era
22 Novembre 2025
Il piano che dà ragione alla forza è frutto di un errore: accettare la logica delle armi
Il “Piano Trump” per mettere fine alla guerra in Ucraina appare, purtroppo, quale frutto avvelenato del modo in cui la crisi ucraina è stata affrontata sin dall’inizio. Aver pensato — come molti continuano a pensare — che alla forza si dovesse rispondere soltanto con la forza, conduce ora inevitabilmente non a dare forza a chi ha ragione, bensì a dare ragione alla forza, e quindi a far sì che venga presentato un piano “di pace” che appare come l’ennesima riproposizione del discorso che gli Ateniesi fecero ai Meli durante la Guerra del Peloponneso, il cui succo era questo: «per legge di natura, i forti comandano e i deboli ubbidiscono». A differenza di quanto molti semplificatori del dibattito pubblico hanno ripetuto e continuano ancora a ripetere, rifiutare la logica delle armi non voleva affatto dire essere codardi o addirittura essere alleati dell’aggressore. Voleva dire invece mettere in atto quei passaggi e quegli strumenti che oggi vengono completamente calpestati anche nell’ipotesi di pace che è stata appena presentata. Non si tratta soltanto della tanto vilipesa opera della diplomazia, ma di molte altre cose che vale la pena di richiamare: una pressione vera, condivisa con le potenze emergenti, per il rispetto del diritto internazionale, mettendo in campo e legittimando il più possibile il ruolo delle Nazioni Unite; la tolleranza zero nei confronti degli autori di crimini di guerra, favorendo, e non ostacolando, il lavoro della Corte Penale Internazionale; l’insistenza su sanzioni mirate e sempre più pesanti, al fine di far sì che si potesse creare un fronte interno di opposizione nei confronti di chi aveva deciso l’aggressione; la valorizzazione massima del principio di autodeterminazione dei popoli, da applicare innanzitutto con riguardo alle regioni contese, realizzando delle consultazioni libere e garantite, e pretendendo il rispetto dei diritti delle minoranze; infine, l’invio di forze di interposizione capaci di porre un argine fisico all’avanzata delle truppe dello stato invasore.
Poiché, come ha spiegato Hans Kelsen — il più grande giurista e teorico del diritto del XX secolo —, è sempre e comunque la comunità internazionale ad autorizzare la risposta bellica all’aggressione, era il caso che essa esercitasse la propria responsabilità in modo da evitare le morti, la distruzione e la devastazione, che sempre si accompagnano ad ogni guerra, e in maniera tale da confermare l’irrinunciabilità dei princìpi giuridici, facendo sì che essi non finissero stritolati nel tritacarne della forza.
Questo importante chiarimento ha a che fare con il ruolo che l’Europa può e deve svolgere anche in futuro. La decisione di procedere ad un corposo riarmo deriva infatti dall’aver individuato nella Russia di Vladimir Putin un “oggettivo” motivo di pericolo, proprio in considerazione di quanto avvenuto in Ucraina. Anche stavolta, chi è contrario a questa scelta viene trattato o come un ingenuo, che non capisce il pericolo nel quale si trova, oppure come un utopista, convinto che la pace possa essere garantita da qualcosa di diverso rispetto all’equilibrio delle forze (cioè, delle armi). È solo la deterrenza ad essere considerata efficace, sulla scia del sempiterno «si vis pacem para bellum» . Un argomento, questo, che anche molti appartenenti al mondo cattolico hanno fatto proprio e difendono convintamente, spesso sulla scia di quanto Emmanuel Mounier aveva scritto a proposito di Hitler durante la Seconda guerra mondiale. Lo spettro di Monaco — non si sa quanto appropriatamente, ma in ogni caso ricorrentemente — aleggia sulle scelte del nostro tempo. Ebbene, se l’Europa vuole avere il ruolo attivo che rivendica anche con riguardo alla soluzione della crisi ucraina, deve avere il coraggio di compiere quella “mossa del cavallo” che nel gioco degli scacchi permette di uscire dalle contrapposizioni tra i pezzi della scacchiera, aprendo scenari nuovi e inaspettati.
Abbandonarsi al gioco delle forze non può che vederci perdenti, così come perdente sarebbe in generale l’umanità se dovesse cominciare una stagione vissuta all’ombra del terrore atomico.
Ciò che serve non è affatto mostrare i muscoli, bensì un rilancio dell’Unione che ne rafforzi il ruolo di “potenza civile” anziché militare, con un consolidamento dei meccanismi democratici interni, compreso il superamento del principio dell’unanimità; così come serve il rifiuto di legittimare le autocrazie, non accettando mai di barattare i valori con gli interessi del momento.
Serve, in altre parole, che l’Europa rimanga fedele alla sua origine, confermando quella scelta pacifista che ha come punto fondante la rinuncia alla logica assoluta e assolutista della sovranità armata. Si tratta, quindi, di mettersi alla testa di una visione alternativa del sistema internazionale, nel quale si possa dare il massimo spazio possibile a rapporti di fiducia, sulla scia del principio «si vis pacem, para pacem» , e che possa al contempo rispondere alla eventuale rottura di questa fiducia attraverso azioni che non passino dall’uso delle armi.
L’efficacia delle scelte che vengono effettuate dipende in gran parte dalla legittimità e dal prestigio che riconosciamo loro. L’impressione (ma è molto più che un’impressione) è che il discorso pubblico internazionale si sia ormai addensato intorno al ruolo della forza e delle armi, disconoscendo ogni altra via e ogni altra possibilità. Forse vale per il nostro tempo ciò che scriveva John Ruskin a proposito degli inglesi ne Le pietre di Venezia: il nostro amore per la perfezione è tale che preferiamo una perfezione nelle opere più basse, piuttosto che qualcosa di meno perfetto nelle opere più alte. Ma le opere delle armi possono mai essere perfette? La celebrazione dei diritti della forza, che emerge dal “Piano Trump”, viene a confermarci che no, non possono mai esserlo.
Professore ordinario di Filosofia del diritto, Università di Pisa