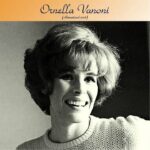
Senza Fine
22 Novembre 2025
L’Amiata e l’idea di ZES: ambizione alta, terreno ancora da preparare
22 Novembre 2025
di Pierluigi Piccini
La vicenda delle 478 opere donate al Comune di Siena nel 2019 si chiude con un epilogo che era facilmente prevedibile. Non serviva alcuna particolare capacità divinatoria: bastava osservare con attenzione la fragilità dell’impianto su cui l’operazione era stata costruita. Oggi quelle opere tornano alla proprietaria e il Comune paga un risarcimento per i danni riscontrati al momento della restituzione. Una cifra contenuta, ma sufficiente a dare la misura di un percorso che non ha mai trovato una direzione credibile.
Per comprendere davvero come si è arrivati a questo esito, occorre ricordare che l’idea non nasce con la giunta De Mossi. Affiora negli ultimi anni della precedente amministrazione, quando la direzione del Santa Maria della Scala era affidata a Daniele Pitteri. Fu in quel periodo che si iniziò a valutare l’ingresso della collezione: un insieme ampio, eterogeneo nelle tecniche e nei valori, complesso da trattare e ancora più difficile da esporre in una forma coerente. La proposta rimase sospesa, forse anche perché la struttura museale non sembrava in grado di accogliere una simile operazione senza snaturare la propria identità.
Quando la giunta successiva decise di riprenderla in mano, la trasformò in un gesto politico, attribuendole il valore di un segno di discontinuità. L’entusiasmo sostituì l’analisi: le condizioni poste dalla donatrice – esposizione permanente, presenza obbligatoria del curatore da lei scelto, un calendario di iniziative predefinito – vennero accettate senza considerare le implicazioni sul funzionamento del complesso museale. Un museo non è un contenitore neutro; vive di flessibilità, programmazione, dialogo con la città. Inserirlo dentro una gabbia contrattuale significava sottrargli respiro.
Nel luglio del 2019, come gruppo consiliare di “Per Siena”, chiedemmo semplicemente che si facesse ciò che qualunque amministrazione dovrebbe fare davanti a un impegno di questa portata: valutare con precisione il valore delle opere, verificarne lo stato di conservazione, stimare i costi di assicurazione e deposito, e soprattutto comprendere che cosa avrebbe significato, per il Santa Maria, vincolarsi a un allestimento permanente di centinaia di lavori. Non era una battaglia politica, ma una richiesta di trasparenza e di metodo. Venimmo liquidati come frenatori, come se il rispetto delle procedure fosse un lusso che Siena non poteva permettersi.
Gli anni seguenti hanno mostrato quanto quelle domande fossero fondate. Le opere, invece di trovare spazio nel complesso museale, finirono nel caveau Mps di San Miniato, dove sono rimaste custodite per anni. Nel frattempo il Comune ha sostenuto premi assicurativi, incarichi professionali e costi vari, senza ottenere alcun beneficio culturale. Nessuna mostra, nessun progetto, nessuna ricaduta per la città.
La giunta Fabio, chiamata a chiudere la partita, ha dovuto prendere atto che quelle condizioni erano inapplicabili. La donazione è stata sciolta consensualmente e le opere restituite alla proprietaria. Restavano però le conseguenze materiali del tempo trascorso: spese legali già rimborsate e, alla fine, un risarcimento per danni rilevati al momento della riconsegna. Un epilogo modesto solo in apparenza, perché simbolicamente dice tutto.
Non è questione di criticare a posteriori. La verità è che questa storia sarebbe potuta finire diversamente se si fosse avuto il coraggio di affrontarla con rigore fin dall’inizio. Il Santa Maria della Scala, che sotto la direzione Pitteri aveva già attraversato una fase complessa, avrebbe meritato un percorso più solido, meno legato alla ricerca del gesto e più alla costruzione di una visione duratura.
La cultura non vive di scorciatoie. Chiede cura, responsabilità, continuità. Nel 2019 chiedevamo esattamente questo, senza toni polemici e senza secondi fini. Oggi resta un’unica lezione: una donazione non è mai solo un atto di generosità. Diventa, se gestita male, un impegno costoso per la comunità. Siena ha pagato per capirlo. Meglio sarebbe stato evitarlo.




