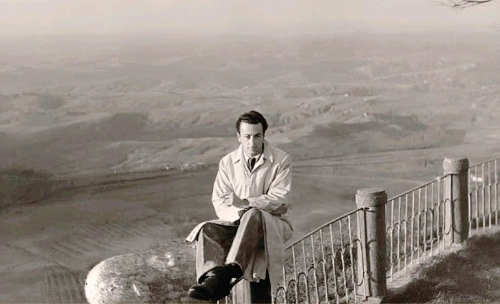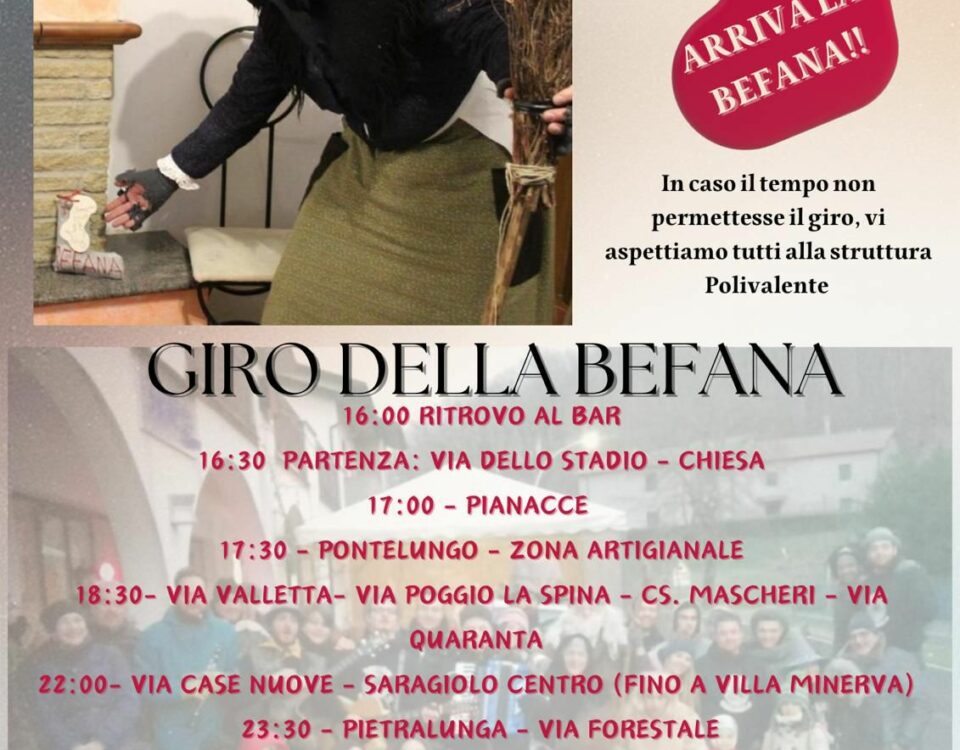Un’icona senza tempo
23 Novembre 2025
Provenzano e il silenzio della morte: una bellezza che custodisce la continuità
23 Novembre 2025di Pierluigi Piccini
Carlo Sama è una figura che attraversa uno dei capitoli più delicati dell’economia e della storia giudiziaria italiana. Dirigente di primo piano del gruppo Ferruzzi-Gardini, fu tra i protagonisti della stagione che portò alla nascita di Enimont e poi al suo crollo, diventando uno dei volti più esposti nel caso esploso con Mani Pulite. Affrontò centinaia di capi d’imputazione, anni di processi, una condanna e la successiva riabilitazione. Il suo nome resta legato all’epopea industriale Ferruzzi-Montedison così come alla stagione delle grandi inchieste degli anni Novanta.
Non ero presente alla presentazione del suo libro a palazzo Patrizi, organizzata da Azzurro Donna e Forza Italia. Ho letto però il resoconto della Nazione, e da quella cronaca ho cercato di capire il senso dell’iniziativa. La domanda che mi sono posto riguarda soprattutto l’intreccio tra memoria personale, narrazione pubblica e rilettura politica di una storia che non appartiene solo alla famiglia Sama, ma al Paese.
Il racconto riportato dal giornale si muove su tre piani. Il primo è quello affettivo, con l’autore che dedica il libro al nipote per consegnargli una memoria familiare non mediata dai motori di ricerca. Il secondo è il registro epico dell’impresa Ferruzzi: l’ascesa, la visione industriale, la figura di Serafino, la traiettoria di Gardini. Il terzo è la lettura politica della stagione di Mani Pulite, presentata come un’onda che travolse tutto, priva di responsabilità strutturali e mossa più dalla paura che da un disegno ordinato.
Questo intreccio produce un effetto particolare. Da una parte l’intenzione privata e affettiva può essere sincera; dall’altra la sua funzione pubblica appare orientata a ridisegnare i contorni di una vicenda complessa, smussandone gli aspetti più problematici. Il racconto finisce così per assumere il carattere di un’operazione di ri-legittimazione: una memoria resa più compatta, più indulgente, più facilmente condivisibile, soprattutto in un contesto politico benevolo.
È questo che mi sono chiesto leggendo l’articolo della Nazione: dove finisce la memoria familiare e dove comincia la riscrittura? Nella presentazione, almeno per come è stata raccontata, le due dimensioni sembrano sovrapporsi senza davvero chiarire il punto. Una storia che riguarda l’Italia meriterebbe, forse, un’analisi più profonda e meno conciliativa.