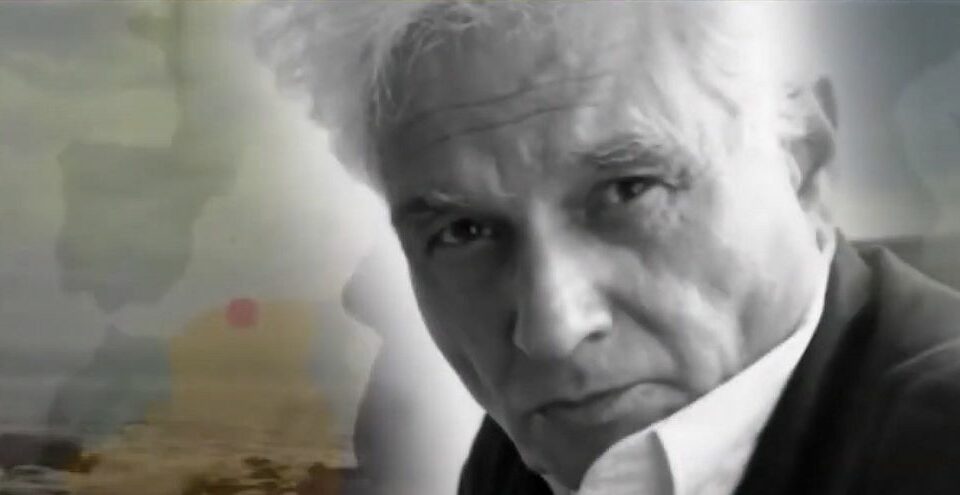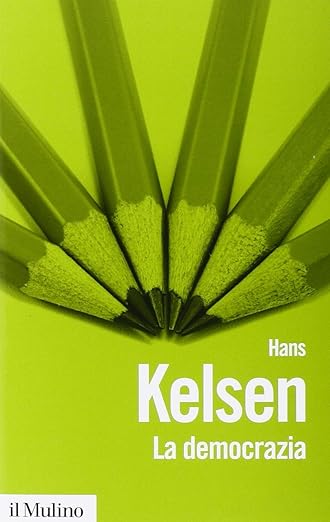La normalizzazione dell’eccezione: da Schmitt ad Agamben
6 Febbraio 2026di Pierluigi Piccini
Le democrazie non arretrano quasi mai all’improvviso. Non esiste un giorno preciso in cui ci si sveglia meno liberi. Il cambiamento avviene per scarti successivi, spesso giustificati da buone ragioni — la sicurezza, l’ordine pubblico, la tutela delle istituzioni. È così che l’eccezione, lentamente, si abitua a diventare regola.
Il nuovo pacchetto sicurezza del governo si colloca esattamente su questo crinale. Il fermo preventivo fino a dodici ore — cioè la possibilità di limitare la libertà personale non per ciò che si è fatto ma per ciò che si potrebbe fare — segna un passaggio politico prima ancora che giuridico. Non è una misura qualsiasi: è un cambio di paradigma nel rapporto tra Stato e cittadino.
Ignazio La Russa non ha dubbi. Parla di una tensione che alcuni tentano di trasformare in disordine, di un attacco allo Stato che renderebbe “improvvido non agire”. Giorgia Meloni rivendica uno Stato che “difende chi ci difende”. Carlo Nordio respinge l’idea di uno scudo penale. Matteo Piantedosi assicura che non siamo di fronte a norme liberticide.
Ma nelle democrazie le parole del potere non sono mai neutrali. Preparano il terreno.
La domanda vera non è se lo Stato debba garantire sicurezza — è ovvio che debba farlo — bensì quale idea di cittadino stia emergendo. Perché quando si introduce una misura preventiva, il cittadino non è più soltanto un titolare di diritti: diventa un sospetto potenziale.
È un passaggio sottile, ma decisivo.
Si evocano gli anni di piombo, salvo poi riconoscere che non siamo davanti a una minaccia paragonabile. Ed è proprio questo il punto che inquieta. Le democrazie ricorrono a strumenti straordinari quando esiste una straordinarietà. Se la straordinarietà non c’è, resta solo l’espansione del potere pubblico.
La sicurezza, allora, rischia di trasformarsi in una grammatica della paura.
Non si tratta di minimizzare la violenza — l’aggressione al poliziotto di Torino è un fatto grave, inaccettabile — né di indulgere verso chi scambia la piazza per un campo di battaglia. Lo Stato deve essere fermo, e la violenza va isolata senza ambiguità.
Ma la fermezza non coincide con l’anticipazione del controllo.
La storia costituzionale europea ci ha insegnato una lezione semplice: la libertà personale è il confine più sensibile del potere. Ogni volta che lo si oltrepassa in nome della prevenzione, si apre una porta che difficilmente si richiude.
Il punto non è soltanto l’abuso — che pure è sempre possibile — ma la cultura politica che si consolida. Quando l’orizzonte diventa la sicurezza assoluta, il rischio è una società sorvegliata, non una società più giusta.
Colpisce anche il riaccendersi dello scontro tra politica e magistratura dopo la scarcerazione dei fermati di Torino. Parlare di un “pezzo della filiera che si ferma” significa insinuare che le garanzie siano un intralcio. È un linguaggio pericoloso, perché nelle democrazie liberali i controlli non rallentano lo Stato: lo legittimano.
Uno Stato che non accetta limiti smette di essere forte. Diventa soltanto più pesante.
C’è poi un paradosso che attraversa tutta questa vicenda. Più la politica insiste sulla sicurezza come emergenza permanente, più contribuisce a diffondere insicurezza nella percezione collettiva. È una dinamica ben nota: la paura è una delle più potenti risorse di consenso.
Ma governare la paura non significa governare un Paese.
Le forze dell’ordine meritano rispetto, tutele, investimenti, stipendi adeguati, strumenti moderni. Nessuna democrazia può permettersi di lasciarle sole. Tuttavia proteggerle non può voler dire ridurre lo spazio delle libertà: se accade, il prezzo lo pagano tutti, anche chi è chiamato a garantire l’ordine.
Sicurezza e libertà non sono poli opposti. Sono l’una la condizione dell’altra. Quando vengono separate, entrambe si indeboliscono.
Intanto la politica si muove. La frattura aperta dalla fuoriuscita di Roberto Vannacci dalla Lega segnala che il baricentro del dibattito pubblico si sta spostando ancora più a destra, lungo l’asse identità-sicurezza-autorità. È un terreno scivoloso, perché la competizione su chi appare più duro raramente produce equilibrio: produce escalation. Matteo Renzi ha già fiutato l’odore della competizione e si muove di conseguenza. Del resto, nella politica italiana la sicurezza è spesso meno una responsabilità condivisa che un titolo negoziabile sul mercato del consenso.
E nelle escalation la moderazione diventa sospetta, la prudenza viene scambiata per debolezza, il garantismo per complicità.
È così che le democrazie si irrigidiscono.
Il vero banco di prova non sarà l’approvazione del decreto, ma il clima culturale che lo accompagnerà. Una democrazia sicura non è quella che teme il dissenso, ma quella che lo regge senza criminalizzarlo. Non è quella che moltiplica i poteri preventivi, ma quella che rafforza la fiducia tra istituzioni e cittadini.
Perché alla fine la questione è tutta qui: che Stato vogliamo essere?
Uno Stato che presume la responsabilità dei cittadini o uno Stato che ne teme la libertà?
La sicurezza è un bene essenziale. Ma quando diventa l’argomento che giustifica tutto, smette di proteggere la democrazia e comincia, lentamente, a restringerla.
Le società davvero libere non sono quelle in cui nessuno disturba l’ordine. Sono quelle in cui l’ordine non ha paura della libertà.