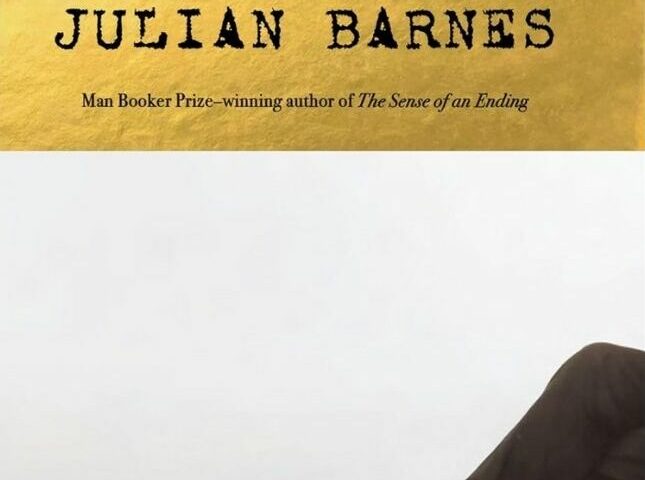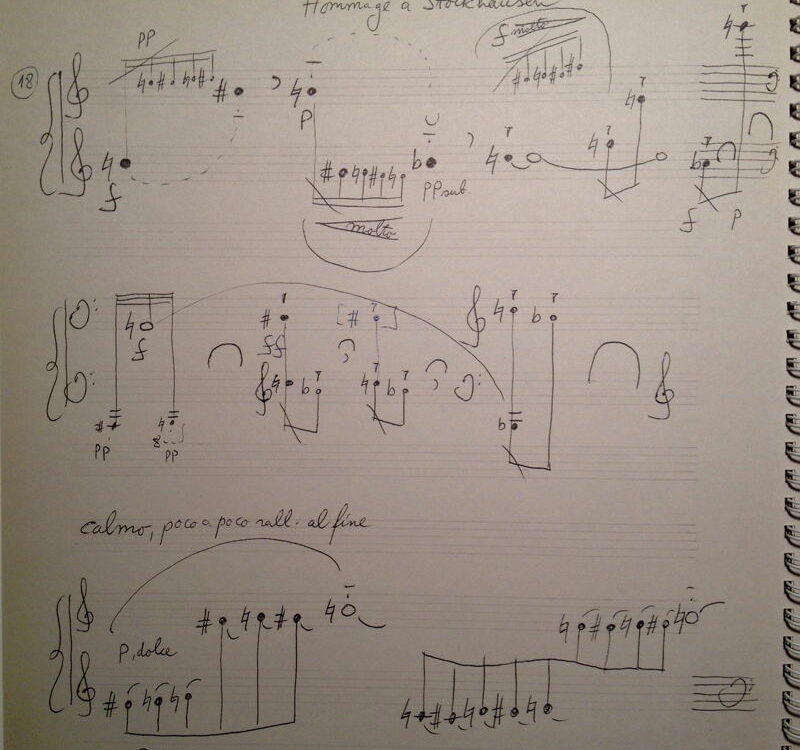Beginnings in Fragile Times: Literature, Architecture and Art Between Memory and Survival
22 Febbraio 2026
Generativo e mistico: il pensiero di Hillesum
22 Febbraio 2026Samuel Beckett fu il primo a notare che l’autore della «Recherche» non ce la raccontava giusta. Philip Roth ci andò giù pesante in «Pastorale americana»: parodiando la scena della madeleine, rivela la natura artificiosa e consolatoria della cosiddetta «memoria involontaria». Quello stesso biscotto è l’oggetto polemico di quest’ultimo «Partenze» . Ma il tema è presente da sempre nell’opera dell’ottantenne scrittore britannico che ha appena annunciato il ritiro, perché è un tema inevitabile
di Alessandro Piperno
Julian Barnes non è il primo scrittore di lingua inglese a farsi beffe di Marcel Proust e della sua idea del Tempo. Nella mia vita di lettore ne ho incontrati parecchi. Ma dato che anche una lista approssimativa esaurirebbe lo spazio a mia disposizione, mi limiterò al paio di esempi che mi stanno a cuore.
1) Era il 1932 quando un dinoccolato irlandese non ancora venticinquenne, con un impiego precario presso l’École Normale Supérieure, scrisse un breve saggio su Proust. Il giovanotto si chiamava Samuel Beckett. Ancora oggi quell’acerbo libretto (che peraltro l’autore, ormai celebre, avrebbe ripudiato) rappresenta per i proustiani una pietra miliare. Beckett ritiene che almeno su un punto Proust non ce la conti giusta. Il Tempo, ammonisce, non può essere ritrovato: tutt’al più può essere cancellato, ma allora è un’altra storia.
2) Ed ecco cosa scrive più di mezzo secolo dopo Philip Roth in Pastorale americana: «Divorando un boccone dopo l’altro di questi pasticcini il cui sapore farinoso avevo amato fin dall’infanzia — un misto di burro, panna acida, vaniglia, mascarpone, tuorlo d’uovo e zucchero — forse avrei fatto sparire da Nathan ciò che, secondo Proust, sparì da Marcel nell’attimo in cui riconobbe “il sapore della piccola madeleine”: la paura della morte. “Un semplice assaggio” scrive Proust “e per lui la parola morte non ha più alcun senso”. Mangiai dunque, avidamente, ingordamente, non volendo limitarmi, nemmeno per un attimo, nel vorace accumulo di grassi saturi; ma senza avere, infine, la fortuna di Marcel».
Scetticismi condivisi
Anche se non si tratta di un saggio ma di un’opera narrativa, non è così difficile intendere dove Roth voglia andare a parare. Parodiando le pagine famose della madeleine proustiana, Roth rivela (o almeno è convinto di farlo) la natura artificiosa e consolatoria della cosiddetta «memoria involontaria».
Date le circostanze, mi guarderò bene dal fare le pulci a Roth. La bellezza del passo appena trascritto è tale che nessuna delle mie pedantesche obiezioni potrà mai scalfirla. Ciò che mi preme segnalare è l’affinità tra le perplessità di Roth e quelle espresse da Julian Barnes in Partenze, il suo ultimo romanzo. L’oggetto polemico è il medesimo: la più celebre scena della Recherche, quella della madeleine intinta nella tazza di tè.
Il Narratore di Partenze — che peraltro, come talvolta avviene nei romanzi di Barnes, condivide le generalità (e non solo) con l’Autore — dedica un bel po’ di capoversi a smontare la sofisticata «macchina del ricordo» allestita da Proust. Il tono non è molto diverso da quello di Beckett e di Roth: tra il perplesso e il canzonatorio. Anche a lui, questa storia della «memoria involontaria», sembra un tantino artefatta, se non proprio posticcia. Anzitutto tale memoria, stando a come Proust la racconta, non sembra affatto involontaria. Forse all’inizio sì, ma via via si fa sempre più consapevole. Di fatto, nota Barnes non senza impertinenza, essa raggiunge il suo obiettivo solo quando decide di affidarsi al contributo volontario dell’intelligenza. Come se non bastasse, Barnes si chiede cosa spinga Proust a ritenere i ricordi resuscitati dalla «memoria involontaria» più veri e genuini di quelli ottenuti interrogando la «memoria volontaria». E questa sì che è una bella domanda. Ma il vero punto è che Barnes non ha la più pallida idea di cosa Proust stia parlando. «Forse il mio scetticismo», scrive, «deriva dal non aver mai sperimentato ricordi trascendentali come questi in vita mia; mi sono dovuto accontentare dei semplici biscotti secchi della memoria volontaria». E come se non bastasse, ecco che si sbriga ad aggiungere: «D’altronde, a differenza di Marcel, non ho mai trovato frustranti i limiti della memoria volontaria; e dubito che se potessi riavere accesso ad Acton w3 (un noto quartiere londinese), come si presentava alla fine degli anni Quaranta e inizio Cinquanta, il sobborgo mi sboccerebbe in mente come un fiore di carta giapponese nell’acqua, ricordandomi episodi e felicità dimenticate. Né riesco a indovinare quale subitanea chiave olfattiva potrebbe funzionare nel mio caso: di sicuro non un qualunque pezzetto di dolce molliccio. Piuttosto il profumo di colla e vernice che usavo per costruire modellini aerei, o magari l’aroma di bacon sfrigolante, o l’odore di un golden retriever bagnato».
Possiamo non dirci proustiani?
Poi, dopo averlo citato (e disapprovato) ancora una volta, Barnes nota: «C’è parecchio Proust in questo libro, mi accorgo. E dire che non sono nemmeno proustiano. Ma forse si vede, perché, come è appena successo, lo nomino essenzialmente per dissentire».
In un certo senso lo capisco, capisco perché lo dice. Non è facile fare il romanziere con Proust alle calcagna. Tanto più se il faro da cui non stacchi mai gli occhi è Gustave Flaubert, al quale peraltro hai dedicato un libro bellissimo (confesso: non c’è corso sulla Bovary o sull’Educazione sentimentale in cui non consigli agli studenti la lettura de Il pappagallo di Flaubert di Julian Barnes).
E tuttavia mi chiedo: può un romanziere — non solo Barnes, qualsiasi romanziere — affermare di non essere proustiano? Può farlo così, a cuor leggero? E noi? Siamo tenuti a credergli? Mi rendo conto che ad alcuni la questione potrà apparire di scarso interesse. E in effetti poche cose sono noiose come elucubrare sulle ascendenze letterarie di uno scrittore, tanto più se lo scrittore in questione ha raggiunto oramai lo status di artista eminente. Vorrei rassicurare il lettore: non è mia intenzione inerpicarmi lungo un sentiero così impervio. Diciamo che vorrei sfruttare l’opportunità concessami da Barnes per affrontare un problema ineludibile per ogni narratore realista: il tempo.
Il senso del Tempo
Ecco come la pensa Tony Webster, la voce narrante de Il senso di una fine (per alcuni il capolavoro di Barnes): «Viviamo nel tempo; il tempo ci forgia e ci contiene, eppure non ho mai avuto la sensazione di capirlo fino in fondo. Non mi riferisco alle varie teorie su curvature e accelerazioni né all’eventuale esistenza di dimensioni parallele in un altrove qualsiasi. No, sto parlando del tempo comune, quotidiano, quello che orologi e cronometri ci assicurano scorra regolarmente: tic tac, tic toc. Esiste al mondo una cosa più ragionevole di una lancetta di secondi?».
Credo che quella appena posta da Tom Webster sia una domanda retorica. Chiunque abbia un po’ di decenni alle spalle, infatti, conosce la risposta, e nessuno la conosce meglio del romanziere attempato: nulla è ragionevole come l’inesorabile trascorrere del tempo. A chi obbietta che Tony Webster non è un romanziere, rispondo: bah, dato che lo stile con cui si esprime gli è stato prestato da uno dei migliori, è come se lo fosse.
Per averne una prova ulteriore, sentite cosa aggiunge subito dopo: «Ma a insegnarci la malleabilità del tempo basta un piccolissimo dolore, il minimo piacere. Certe emozioni lo accelerano, altre lo rallentano; ogni tanto sembra sparire fino a che in effetti sparisce sul serio e non si presenta mai più». Questi sono i classici pensieri che con cui si balocca chi scrive romanzi. Proustiano o non proustiano che sia, il romanziere sa che il suo campo d’azione è quello delimitato dal tempo: un carcere di massima sicurezza da cui nessuno è mai riuscito a evadere.
Chiamatelo pure nichilismo
Barnes ne ha parlato anche nel suo libro più personale e doloroso: Livelli di vita. Quello in cui — con flemma encomiabile, occorre dargliene atto — ha dato conto dei primi tempi della sua vedovanza. «Noi siamo stati insieme trent’anni. Ne avevo trentadue quando ci conoscemmo, sessantadue quando è morta. Il cuore della mia vita; la vita del mio cuore».
È così che accade. Al netto di eventi, situazioni, contesti quanto mai differenti, la sostanza resta invariata. Prima o poi arriva il momento, per ciascuno di noi, di constatare quanto la natura del tempo sia ingannevole. «Il dolore», scrive Barnes, «riconfigura il tempo, alterandone durata, consistenza e funzione: posto che ogni giorno è insignificante quanto il successivo, ci si chiede come mai siano stati distinti e dotati di nomi diversi l’uno dall’altro». In un attimo ciò che ti resta da vivere perde di attrattiva. Parlando di Pat, la moglie, Barnes scrive: «Non credo che la vedrò mai più. Non la potrò mai più vedere, sentire, toccare, abbracciare, ascoltare; non riderò più con lei, non aspetterò il rumore dei suoi passi, non sorriderò sentendole aprire la porta, non incastrerò il suo corpo nel mio, il mio nel suo. E non credo nemmeno che ci rincontreremo con chissà quali fattezze smaterializzate. Sono convinto che chi è morto è morto».
Questo è ciò che i credenti chiamano «nichilismo». Un approccio alla vita che nei momenti peggiori può affossarti, ma che il più delle volte ti fa sentire non voglio dire in pace, ma perlomeno onesto.
Il valzer degli addii
In Partenze, nel prendere congedo dal lettore (a quanto pare, per sempre) Barnes si guarda bene dall’indorargli la pillola: «Perciò, concludendo, sto andando — letteralmente — da nessuna parte (e temo che ci stiate andando anche voi, amici miei, ma voi restate più a lungo che potete, anche solo per farmi un piacere)».
Chissà perché, ma dopo aver trascritto questa frase — amara e anodina a un tempo — mi è venuto in mente l’invito che nel suo diario John Cheever rivolge a sé stesso: «La narrativa deve illuminare, esplodere, ristorare. Non credo ci sia alcuna filosofia morale nella narrativa oltre all’eccellenza. L’intensità della sensibilità e la rapidità le ho sempre ritenute importantissime». Questo è il genere di consegna cui Barnes ha strenuamente cercato di attenersi. L’idea che la narrativa possa o debba rivelarci chissà quale verità superiore gli è del tutto estranea. «Nessun romanziere dovrebbe scrivere in modo condiscendente presumendo di possedere una saggezza superiore».
Del resto, la sola verità di cui Barnes dispone è tutto fuorché rassicurante: «La vita non è una tragedia a lieto fine, nonostante le promesse della religione; è piuttosto una farsa dal finale tragico o, tutt’al più, una commedia leggera dal finale triste».
P.S. Proust pensava che per conoscere un autore, per conoscerlo realmente, occorresse tornare sui suoi libri spesso e volentieri. È ciò che ho fatto in queste settimane con i romanzi di Barnes. Anche per questo sento la necessità di ringraziare la traduttrice, Susanna Basso. La ringrazio per aver messo la sua prosa limpida e sonora a disposizione di Barnes e dei suoi devoti lettori italiani.