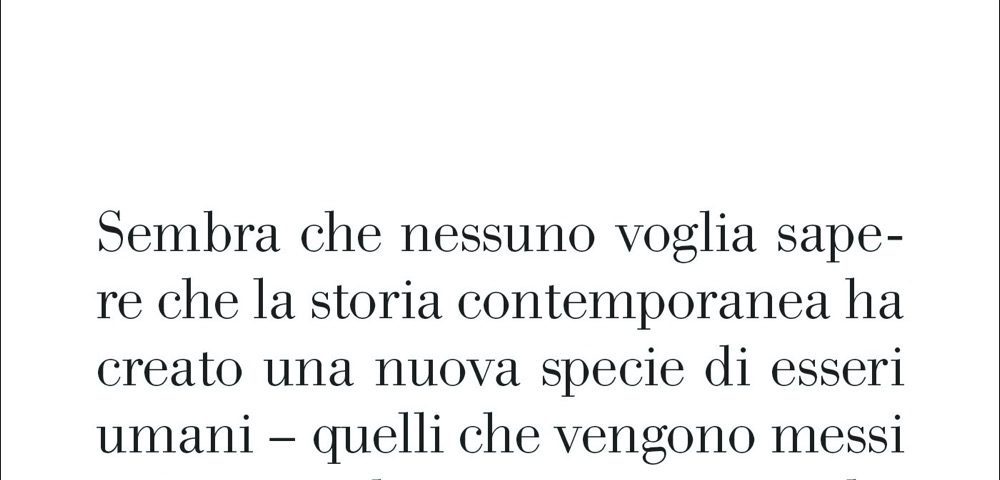Max Ernst, 4 Ottobre 2022 – 26 Febbraio 2023
3 Ottobre 2022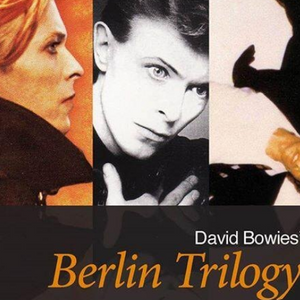
Bowie – Berlin Trilogy
3 Ottobre 2022di Carlo Bordoni
Che cosa pensano i rifugiati? C’è un documento di straordinario valore umano che apre uno spiraglio di comprensione. L’ha scritto ottant’anni fa una donna, un’ebrea, scampata alla Shoah e riparata negli Stati Uniti. Hannah Arendt (1906-1975), una tra le filosofe più importanti del Novecento, autrice, tra l’altro, di testi come Le origini del totalitarismo (1951), Vita activa (1958) e La banalità del male (1963). Il documento s’intitola Noi rifugiati (Einaudi) ed è curato da Donatella Di Cesare, un’altra donna, anche lei ebrea e filosofa, che accompagna le parole della Arendt con un appassionato testo di approfondimento, Hannah Arendt e i diritti dei rifugiati, a completare il volume.
L’esperienza della migrazione è devastante; lo è ancora di più se avvenuta durante il nazismo. Hannah Arendt è fuggita dalla Germania nel 1933, al momento della salita al potere di Hitler, ha riparato in Francia, dove è stata considerata «straniero indesiderabile» e, al momento dell’invasione nazista, internata nel campo di Gurs, nei Pirenei. Fuggita attraverso la Svizzera, l’Italia e la Spagna, ha riparato a Lisbona, per poi raggiungere gli Stati Uniti nel 1941. Privata della cittadinanza tedesca, ha vissuto a New York come apolide fino al 1951, quando ha ottenuto finalmente la cittadinanza americana. Senza patria, perché la vita dei rifugiati è segnata da incertezze, pericoli, difficoltà. La devastazione fisica e psicologica prodotta dallo sradicamento forzato (che in alcuni ha spinto al suicidio) è registrata qui, in Noi rifugiati, lucida denuncia politica che ha la coralità di una testimonianza collettiva, in nome di tutti i perseguitati.
Pubblicato nel 1943 sul «Menorah Journal», appena due anni dopo il suo arrivo a New York, fu accolto — come sottolinea Di Cesare — da un assordante silenzio, benché fosse rivolto esplicitamente agli ebrei americani. L’assenza di partecipazione aggrava il clima che circonda i nuovi arrivati, con una presa di distanza che li fa sentire di nuovo intrusi. «Non vogliamo essere rifugiati — scrive Arendt, non senza ironia — perché non vogliamo essere ebrei». Esserlo significa sentirsi diversi, un corpo estraneo nella società, e per cercare l’accettazione è necessario rinunciare alla propria identità, diventare persone comuni mescolate tra la folla. La perdita volontaria dell’identità si unisce alla perdita della cultura di origine, dei legami sociali, della lingua, dei colori e dei sapori della quotidianità. Sempre con il timore di essere additati, sospettati, denunciati.
Il sociologo Gianfranco Bettin Lattes segnalava come i suoi correligionari spesso mantenessero un atteggiamento curvo e defilato, quasi affetti da un senso di colpa mai risolto. Perché il bisogno interiore dei rifugiati si traduce in una brutta parola: assimilazione. Qualcosa che esprime la necessità di una perdita, di una rinuncia, di una sottomissione per poter continuare a esistere. È la stessa sensazione espressa da un altro grande pensatore, Zygmunt Bauman, migrante con un percorso speculare rispetto ad Hannah Arendt, fuggito dall’antisemitismo sovietico, attraverso Israele, per approdare a Leeds, in Inghilterra. «Essere in esilio — scrive Bauman in un testo del 1996, Assimilation into Exile — significa essere fuori luogo. L’esilio è un confino obbligato ma anche un posto irreale, esso stesso fuori luogo rispetto all’ordine delle cose. Dove può capitare di tutto ma non si può fare nulla. Ciò che rende l’esilio un luogo irreale è lo sforzo quotidiano di renderlo reale, cioè ripulirlo di tutte quelle cose che lo rendono irreale. In esilio si vuole smettere di essere in esilio. Si vuole essere come chiunque altro».
Donatella Di Cesare estende la denuncia oltre i limiti temporali della Shoah. Ne fa un manifesto a difesa degli indesiderati a cui viene negato il diritto di abitare il mondo. Questo perché il fenomeno delle migrazioni è in aumento: interessa ormai decine di milioni di persone, quasi un continente che si sposta da una parte all’altra della Terra, con un movimento incessante e silenzioso.
Forse siamo all’alba di una nuova grande mutazione delle abitudini sociali, che recupera l’antica vocazione umana al nomadismo, dopo secoli di stanzialità. Non solo a causa di persecuzioni, ma per i motivi più disparati, che vanno dalla fame alla necessità di trovare lavoro. Ma con una grande differenza rispetto al passato, quando a muoversi erano gruppi consistenti, intere comunità, spinte da motivazioni climatiche, economiche o politiche. Lo facevano in massa, veri esodi, trasferendo altrove la loro cultura, cercando di ricreare nei nuovi spazi le stesse attività tradizionali e la continuità quotidiana. Erano spostamenti «protetti», perché accompagnati dal calore della comunità. Adesso le migrazioni sono perlopiù in solitaria, in coppia o in piccoli gruppi, talvolta assieme a sconosciuti, con l’ansia di dovere affrontare luoghi e persone ostili senza alcuna protezione.
Abbiamo assistito impotenti al disgregarsi del diritto all’ospitalità, una conquista di civiltà che aveva impiegato tempo per affermarsi ed è sancita dalla Convenzione di Ginevra con il principio del non-refoulement, del non-respingimento di chi arriva da un altro Paese. Abituati come siamo a osservare il problema dall’altra parte, non ci rendiamo conto di che cosa significhi lasciare per sempre la propria casa e ricominciare da capo.
I motivi — inutile dirlo — sono legati alla modernità, alla separazione dei territori da abitare, alle divisioni territoriali, al tracciamento dei confini tra uno Stato e l’altro, tra una nazione e l’altra. Un’idea essenzialmente moderna, stabilita dalla pace di Vestfalia del 1648, che ha messo fine alle estenuanti guerre di religione. Le grandi nazioni si sono chiuse dentro i loro confini, appellandosi al principio del «sangue e del suolo» (Blut und Boden), che è alla base di ogni odiosa discriminazione e che sancisce il diritto di nascita.
È la stessa Donatella Di Cesare a ricordare opportunamente che nazione deriva dal latino nasci, «nascere», quindi il luogo in cui si è nati: da qui la possibilità di «eliminare» (letteralmente far uscire dal, e(x), confine, limen) tutti coloro che non possono reclamare un diritto, lo ius soli. Il nazismo ha interpretato il concetto di «eliminazione» nel suo senso più brutale e violento, mettendo in pratica un progetto di «giardinaggio sociale» per liberarsi degli indesiderabili, sulla base di un presupposto diritto di nascita e a causa della nascita.
Questo allucinato progetto di eliminazione ha qualcosa di terribilmente razionale, è così «moderno», attuato grazie a perfezionate tecnologie di sterminio, dove l’uomo può lasciare il lavoro sporco alle macchine, limitandosi alla parte burocratica. Arendt ha descritto questo procedimento in La banalità del male, svelando come grazie all’«adiaforizzazione», la virtù stoica dell’indifferenza, sia possibile sottrarsi alla responsabilità voltandosi dall’altra parte.
Oggi l’eliminazione si perpetua senza apparati tecnologici e senza proclami. Invece di rinchiudere nei campi di concentramento, raccoglie i rifugiati in campi di internamento, «zone di transito», anonimi non-luoghi che non hanno identità e sono isolati dal resto del Paese, contribuendo a fare sentire corpi estranei coloro che vi sono accolti. Sospesi nel tempo come nello spazio, in attesa di un’«eliminazione», cioè di un respingimento oltre i confini.
Malgrado le aperture, le garanzie di libertà di movimento, il riconoscimento dei diritti civili, la globalizzazione culturale ed economica, gli Stati post-vestfaliani, o quel che resta di loro, continuano a praticare — come sosteneva il filosofo francese Michel Foucault — il potere di «far morire, lasciar vivere», che implica, allo stesso tempo, l’esercizio esclusivo della violenza e la concessione di certe libertà.
L’evoluzione di questo diritto sovrano ha permesso di modificarlo e integrarlo con il potere di «far vivere, lasciar morire», dove ci si sottrae al compito di un agire pregiudizievole. Ma anche in quest’inazione, in quest’inadempienza divenuta cardine centrale della post-democrazia, si cela una spaventosa, anche se indiretta, responsabilità morale.
https://www.corriere.it › la-lettura