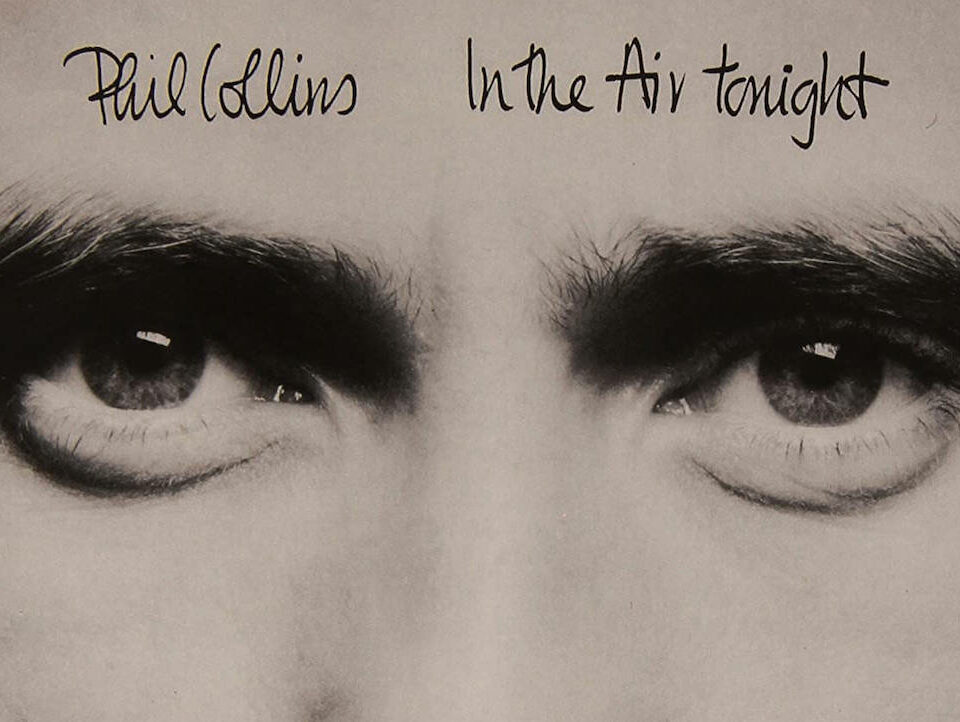La prima volta che balzò agli onori della cronaca non fu esattamente per meriti artistici. Si era a un concerto dei Clash a Londra, era un giorno di ottobre del 1976, e tale era l’eccitazione collettiva che una ragazza addentò a sangue l’orecchio destro dell’allora diciannovenne Shane MacGowan. I tabloid inglesi ne approfittarono per scrivere che nel corso delle serate dell’appena nato movimento punk si verificavano anche episodi di «cannibalismo». Lui anni dopo, quando si era ritirato dalle scene, costretto in sedia a rotelle inseguito dagli acciacchi, sminuì l’episodio, declassandolo a sperimentazione sadomaso tipica di quel periodo. Colpì lo spargimento di materia ematica ma si sa, disse Shane, il lobo auricolare quando è ferito sanguina parecchio.
ADESSO CHE è morto a 65 anni, qualcuno cercherà di ridurre la figura di Shane MacGowan a quella dell’etilico cantante dei Pogues che per primo ha unito l’energia elettrica del rock alle sonorità della tradizione irlandese, associando la sua immagine a sbronze pantagrueliche e feste leggendarie. Tutto ciò corrisponde a uno sguardo che esiste in superficie e che è in effetti incontestabile. Ma chi arriva assieme a lui al culmine della bottiglia, scopre che il suo percorso artistico e il messaggio più profondo è molto più articolato. A cominciare dalla genealogia dei Pogues, che non suonavano musica tradizionale e non erano una «band irlandese». Erano nati a Londra, e in quanto tali rappresentavano il mondo poetico dei paddies, irlandesi fuori dall’Irlanda. Quando MacGowan raccontava la sua infanzia nell’isola, di prima che i con i suoi si trasferisse nella capitale britannica, tirava fuori un’immagine fortissima per esprimere questo rapporto conflittuale e non addomesticato con le radici. Eccola: quando da bambino andava in riva al mare, gli bastava scavare la sabbia per qualche decina di centimetri per trovare teschi e ossa umane. Erano i cadaveri degli irlandesi morti nelle carestie, l’ultima delle quali negli anni Settanta dell’Ottocento. Erano stati seppelliti alla bell’e meglio e tirati fuori dalle maree. Il rapporto con le origini, dunque, era un ricordo di miseria e morte.
COSÌ IL SUO rapporto fin troppo esibito con l’alcol (MacGowan aveva sempre il bicchiere in mano durante i concerti) era un modo per anestetizzare il dolore di quelle storie e le vicende atroci delle strofe che cantava con voce roca, a volte sguaiata, inconfondibile. Si definiva socialista e indipendentista, ma la nostalgia delle canzoni dei Pogues non era per la verde Irlanda né per le scogliere del mare del Nord o i pub rivestiti di legno dell’iconografia da cartolina. Questi elementi erano presenti, ma sullo sfondo quando non ridicolizzati. Non c’era nessun bel tempo andato da rimpiangere, nel ripescare vecchi canti della tradizione e gettarli nella temperie della scena punk londinese. Le canzoni che diceva di preferire, e che gli sopravviveranno, sono ballate dolenti e malinconiche, storie di sconfitti che maledicono le loro vite o inseguono storie d’amore impossibili come «A Rainy Night in Soho» e «A Pair of Brown Eyes» o rievocazioni di mete esotiche e solo episodiche (e per questo struggenti) come «Summer in Siam». La fortunatissima «Fairytale of New York» è emblematica del doppio registro di MacGowan: ormai celeberrima, entrata a far parte a pieno titolo del repertorio gioviale delle canzoni di natale, eppure canta la storia di un irlandese emigrato oltreoceano che si ritrova in cella di sicurezza per una notte e rievoca i suoi fallimenti e le sue pene d’amore, costretto a consolarsi con la lontana eco dei caroselli dell’orchestra degli stessi sbirri che lo hanno arrestato.Si definiva socialista e indipendentista, ma la nostalgia delle canzoni dei Pogues non era per la verde Irlanda né per le scogliere del mare del Nord o i pub rivestiti di legno dell’iconografia da cartolina.
COI POGUES finì preda di un management disinvolto, che negli anni Ottanta gli fece li costrinse a sfilze di concerti senza sosta per sfruttare il successo del momento. Il che trasformò la band, che ci piace ricordare nella parte della gang di cowboy dipendenti dal caffè nello strampalatissimo western Straigh to hell di Alex Cox, in una macchina da concerti. Ciò alimentò gli stravizi di MacGowan, che all’alcolismo unì l’eroina. Alla fine di quel decennio, chiesero a Joe Strummer di accompagnarli in tour, per fare da paracadute agli eccessi del frontman. Assieme all’ex Clash, i grandi nomi del rock’n’roll che adoravano MacGowan erano tanti: tra gli altri Nick Cave, Bruce Springsteen, Elvis Costello, Tom Waits.
QUALCUNO DIRÀ con fare un po’ allusivo che gli è andata bene. Che è vissuto a lungo, visto lo stile di vita che si era scelto. Non credete loro, non è questo il punto: se n’è andato quello che tutti in cuor loro consideravano, a torto, indistruttibile perché capace di sfidare ogni eccesso con lo scudo e in nome della poesia. Senza di lui ci toccherà fare i conti con la nostalgia e l’avvenire, con gli scheletri sepolti del passato e con le struggenti possibilità del futuro, con la massima sobrietà possibile. Questo sì, lo avrebbe stupito.