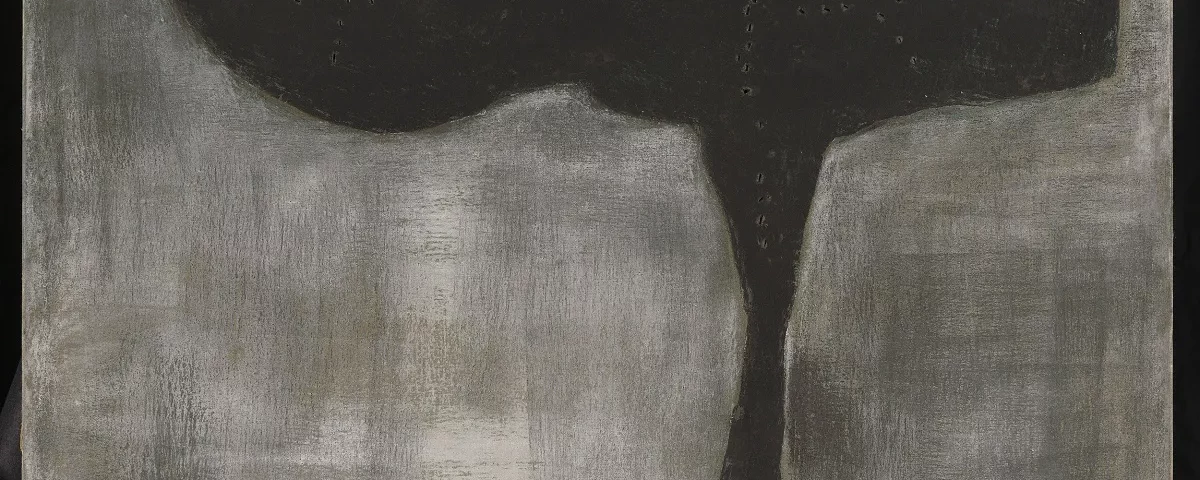Anche in un’epoca secolarizzata come la nostra, i calendari sono segnati dai nomi dei santi e dalle feste liturgiche cristiane, se non altro per ricordarsi degli onomastici e per scandire le vacanze. Ebbene, giovedì scorso, 28 agosto, ci si è imbattuti nel nome di s. Agostino, morto appunto in quella data del 430 nella città di Ippona (l’attuale Annaba), in Algeria, della quale era vescovo dal 396. Egli era nato in quella stessa regione proconsolare romana, la Numidia, a Tagaste il 13 novembre 354, figlio di un piccolo proprietario e consigliere municipale e di Monica, una fervente cristiana che sarà fondamentale nel suo percorso personale.
È facile comprendere che questa nostra memoria di un personaggio notissimo e capitale non solo per la Chiesa ma per l’intera cultura occidentale è motivata dalla figura dell’attuale pontefice, Leone XIV, entrato nell’Ordine religioso agostiniano a 22 anni nel 1977, del quale sarà superiore generale dal 2001 al 2013. Fin dal suo affacciarsi alla loggia della basilica di San Pietro l’8 maggio scorso, nelle sue parole aveva incastonato una citazione del grande Padre della Chiesa: «Con voi sono cristiano, per voi sono vescovo». Era una frase autobiografica del Sermone 340: si ipotizza che in circa 40 anni di predicazione Agostino abbia pronunciato tra i 3 o 4mila discorsi, anche se a noi ne sono pervenuti solo 570 circa.
Come è noto, la grande svolta fu la conversione maturata nel ritiro lombardo di Cassiciaco (Cassago), dopo essere giunto a Milano nel 386 per salire sulla cattedra di retorica. Fondamentale fu l’ascolto della predicazione del vescovo s. Ambrogio, che lo battezzò nella notte pasquale del 24/25 aprile 387. Altrettanto decisiva, anche se discreta, fu la testimonianza della madre Monica a cui egli era legato intimamente. È spontaneo, per questa vicenda che trasformò radicalmente Agostino, raccomandare la lettura delle Confessioni, un’opera indispensabile nella biblioteca di tutti per la sua potenza letteraria, spirituale e filosofica.
Lo scrittore francese Julien Green affermava: «Agostino non delude mai. È così forte la sua concisione che sembra preservarlo dalla sventura di invecchiare. È poco dire che sembra aver scritto per noi; egli è sempre in anticipo sui tempi in cui lo si legge». Non per nulla si dice che di media quasi ogni giorno nel mondo ancor oggi esca un testo critico teologico o devozionale sui suoi scritti e sul suo pensiero. Impossibile è sintetizzare una riflessione così imponente e geniale. Faremo solo un cenno su uno dei cardini preliminari, quello del rapporto tra fede e ragione, i due canali di conoscenza che non devono essere disgiunti. Lasciamo nel latino sempre originale e assonante la sua tesi: Crede ut intelligas et intellege ut credas.
Ugualmente tagliente è un altro suo passo: «Chiunque crede pensa e credendo pensa e pensando crede. La fede, se non è pensata, è nulla». Nell’orizzonte filosofico che si apre davanti a questa conoscenza duplice e intrecciata si diramano innumerevoli percorsi che spesso hanno come approdo l’antropologia (il celebre interrogativo Tu, quis es?). L’uomo è «un grande abisso»: nella sua interiorità abita la verità. Vanamente si cerca all’esterno Dio e, invece, secondo le sue parole, «Tu eri dentro di me e io ero fuori di me stesso ed è fuori che ti cercavo» senza trovarti.
Dio e l’uomo diventano, così, i due poli della riflessione filosofica di Agostino, destinata ad allargarsi in modo impressionante quando egli passerà alla trattazione teologica. Certamente la sua antropologia filosofica non teme di inoltrarsi lungo sentieri d’altura: anima e corpo, tempo e storia, essere e mutabilità, contingente ed eterno, conoscenza e amore, bellezza e male e così via. Riserviamo solo un’allusione a una triade da lui sviluppata in dialettica col platonismo, lui che pure era debitore del filosofo greco (come di Plotino): la creazione, l’illuminazione, la beatitudine.
La prima è dal nulla ed è nel tempo; l’illuminazione non è “reminiscenza” legata alla preesistenza dell’anima (come voleva Platone), ma è svelamento che genera certezza e universalità delle idee; la beatitudine è l’approdo all’eterno ed esclude ogni ciclicità della vita personale. È interessante notare che, non solo nei grandi trattati teologici (si pensi a quel capolavoro simile a una cattedrale che è La città di Dio), ma anche negli scritti più filosofici il vescovo di Ippona adotta una tonalità che interpella sempre Dio, il suo interlocutore costante. È, quindi, un pensare colloquiale con un Tu trascendente, senza che la ragione perda il suo aggancio con la realtà del limite, del male, della caducità.
In finale a queste note minime e sparpagliate attorno a un gigante della cultura, ribadiamo l’invito a ri/leggere le Confessioni, tanto care al Petrarca e a molte menti geniali dell’umanità. Lo facciamo rievocando quella cantilena infantile che generò un fremito nell’Agostino dissipato, spingendolo alla lettura sacra: Tolle lege, Tolle lege. «Piangevo, il cuore a piombo nella tristezza più amara. Ed ecco all’improvviso dalla casa vicina il canto di una voce come di bambino o bambina, lenta cantilena: Prendi e leggi, prendi e leggi!… Allora soffocai il mio pianto e mi levai in piedi» (VIII, 29).