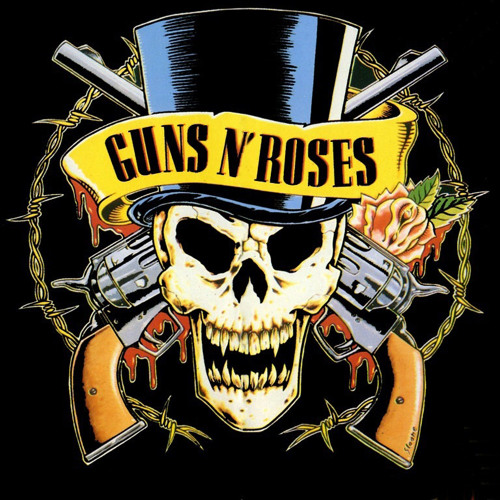Felicia Kingsley Sante o puttane i soliti cliché che ci puniscono
13 Agosto 2023
Heller profetessa del “Gesù ebreo”
13 Agosto 2023Ha una carriera cinematografica che inizia nei primi anni ’70, lavorando con registi come Fassbinder, Schlöndorff, Wajda, Truffaut, Greenaway, Fuller, Varda. L’attrice Andréa Ferréol si è sostanzialmente divisa tra la patria francese e l’Italia, dove ha interpretato ruoli per Festa Campanile, Samperi, Monicelli, Rosi, Scola, Montaldo, Cavani, Verdone. Molto attiva anche in sceneggiati televisivi, comparendo in serie storiche come Ligabue e Cuore, e a teatro: è attualmente impegnata nelle recite di due spettacoli. Il ruolo che l’ha fatta conoscere è quello della maestrina procace di La grande abbuffata di Marco Ferreri, film che compie cinquant’anni e che è stato riproposto al Sicilia Queer Filmfest 2023, nella versione digitalizzata della Cineteca di Bologna, alla presenza dell’attrice. Abbiamo incontrato Andréa Ferréol in questa occasione.
Rivedendolo oggi, sembra proprio che «La grande abbuffata» non abbia perso nulla del suo sarcasmo nei confronti di una società capitalista bulimica. Lei ha la stessa impressione?
È ancora un film molto attuale. Marco era come un veggente. Questo film cinquant’anni dopo è lì, vivo, presente. Il consumismo è sempre più forte e condiziona la nostra vita.
Leggenda vuole che lei dovette ingrassare per interpretare quel film. È vero?
Quando incontrai prima il secondo aiuto regista e poi Ferreri in persona, l’accordo riguardava proprio il fatto che mi avrebbero preso per il film se fossi ingrassata di 25 chili. Ho cominciato a mangiare. Il problema riguardava i vestiti. Gitt Magrini, una grandissima costumista, doveva farli sul mio fisico grasso. Aveva già scelto i tessuti, i materiali, i colori, anche con me. Eravamo andate insieme a vedere tutto. Quando finalmente ho raggiunto 85 chili, in una settimana hanno fatto le camicie da notte, gli slip, tutto molto velocemente. Ferreri mi invitava a cena per essere sicuro che mangiassi. «Non hai mangiato abbastanza. Devi mangiare di più!». Ma io mangiavo cinque volte al giorno. Prendere 25 chili in due mesi non è facile. Dopo tre giorni non hai più fame. Un dottore a Parigi mi suggerì di puntare sul cibo salato, il più salato possibile. E di bere birra. La birra e il sale fanno gonfiare. Dopo il film, per caso un giorno incontrai Ferreri sugli Champs-Élysées. Lui mi vide tornata magra e si indispettì: «Sei una stronza! Non hai capito niente! Ti ho creata grassa, guarda come sei diventata!». Ma io avevo 26 anni, ero giovane. Volevo essere donna, incontrare dei ragazzi.
Lei era la maestrina che comprende la perversione autodistruttiva dentro quella villa e vi rimane, mentre le prostitute fuggono. Cosa ci può dire di quel ruolo?
Le prostitute capiscono che questi quattro uomini vanno verso la morte e non vogliono partecipare a quel percorso. La maestra invece, forse più educata, forse più intelligente, ha capito che avrebbe accompagnato ognuno di loro alla morte. Lei è diventata la madre, l’amante, la sorella, l’angelo della morte. Ha avuto un rapporto più o meno grande con ognuno di loro. E li ha portati, con amore, dolcezza, simpatia, alla morte. Lei lo sa fin dall’inizio. Abbastanza velocemente capisce che moriranno tutti e lei è li per quello. Una bella parte di donna, rappresenta tutte le donne.
Ferreri era un genio, ma come personaggio pubblico risultava sgradevole. Che ricordo ha di lui?
Anche sul set era sempre arrabbiato. A volte l’aiuto regista se ne andava e tornava dopo un’oretta, sperando che si fosse calmato. Le prime parole che ho imparato in italiano erano le parolacce che Marco diceva tutti i giorni. In francese lo definirei con l’espressione «brut de décoffrage». Poi era meticoloso, sapeva esattamente quello che voleva, come lo voleva. Parlava poco. Non dirigeva gli attori come Francesco Rosi o Liliana Cavani, capaci di lavorare con tanti attori. Io ero con questi quattro mostri sacri, Michel Piccoli, Philippe Noiret, Ugo Tognazzi e Marcello Mastroianni. Gli ultimi due, che avevano già lavorato con lui più volte, capivano subito quello che voleva.
Un altro regista genio ma umanamente controverso, con cui lei ha lavorato, è stato Rainer Werner Fassbinder. Per lui è stata protagonista, insieme a Dirk Bogarde, di Despair, grossa produzione internazionale in inglese, tratto da Nabokov. Com’era invece il rapporto con lui?
Fassbinder era tutto un altro discorso. Lui arrivava, metteva a posto l’inquadratura, poi andava a dormire. Era un ragazzo che mentre girava il nostro film, scriveva la sceneggiatura di un altro film, montava un ulteriore altro film, produceva il film di un amico. Una volta mi invitò a mangiare ma non si presentò perché era a lavorare da un’altra parte. Avevo imparato l’inglese per recitare nel suo film. Ci ho messo tre mesi, sono capace di tutto: imparare l’inglese in tre mesi come ingrassare in due. La volontà è una mia caratteristica. Lui, spiritosamente, mi metteva in difficoltà. Tutte le mattine arrivava e mi diceva: «Ti ho messo una battuta in più», e io avrei dovuto studiarla. Parlo bene l’italiano perché è proprio nella mia bocca, ma l’inglese è più difficile per me. Il primo impatto con Fassbinder fu a una cena, dove non mi rivolse la parola. Poi un giorno, anni dopo, a Berlino mi invitò a uscire la sera, e mi portò in un club dove tutti gli uomini erano vestiti di cuoio, bianco o nero, e dove ero la sola donna. Mi guardavano tutti male, ero un pesce fuor d’acqua, e alla fine mi ubriacai. Lui e tutti quegli uomini si divertivano come pazzi. Questo è Fassbinder.
Lei ha cominciato a teatro e tutt’ora è impegnata sui palcoscenici. Non si può non andare a un film sul teatro quale «L’ultimo metrò» di François Truffaut. Lei ha un ruolo molto delicato, quello della sarta che nasconde la propria omosessualità. Cosa ci può dire di quella parte?
Sono Arlette, la sarta del teatro, innamorata della mia padrona, che è Catherine Deneuve, ma lei non ricambia, e mi sorprende a dare un bacio a Sabine Haudepin. La cosa mi disturba perché sono in realtà innamorata di lei. Un bellissimo ruolo. Truffaut, a differenza di Ferreri, non urlava mai. Truffaut dava del lei a tutti tranne che a Sabine Haudepin, che conosceva da quando aveva lavorato con lei da bambina in Jules e Jim. Ma a tutti gli altri, come all’operatore delle luci e quello del suono, dava del lei. Sul set di questo film regnava il silenzio. Non c’era un rumore. Ognuno faceva il proprio mestiere con calma, con precisione. Ero reduce da un set in Italia dove l’atmosfera era completamente diversa. Truffaut amava tantissimo gli attori. Li anteponeva a tutto.
Lei è ancora adesso impegnata a teatro?
Sono in scena con due spettacoli in questo periodo. A Marsiglia, al teatro Odéon recito in una commedia dal titolo Très Chère Mandy. Sono una donna in difficoltà economica che rivela alla figlia di essere stata ad Auschwitz da bambina. Un momento in cui il pubblico non ride affatto, un gelo di 6/7 minuti. L’altro, dal titolo La priapée des écrevisses, è un monologo di un’ora e un quarto sulla vita di Marguerite Steinheil, la donna con cui si stava intrattenendo sessualmente il presidente Félix Faure quando morì per un ictus. Una vita incredibile. Fu pagata due volte dallo stato francese, la prima perché stesse zitta, e poi per il riscatto del rapimento che aveva simulato in Marocco. Una puttana che si è concessa a tutti i grandi dell’epoca. E a breve inizio a imparare un altro testo su un’anziana donna affetta da Alzheimer. Ho appena finito poi di girare una serie televisiva e i miei ultimi due film sono usciti, uno, Choeur de rockers, a fine dicembre, l’altro, Notre tout petit petit mariage, in aprile. Ho poi un altro progetto al cinema dal titolo Le piège. Spero di tornare a lavorare in Italia. Ho fatto una trentina di film e serie televisive, e poi tutto si è chiuso. Fa parte del nostro mestiere. Un giorno, non sai perché, non ti chiamano più, non ti vogliono più.