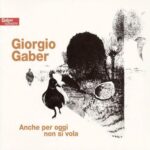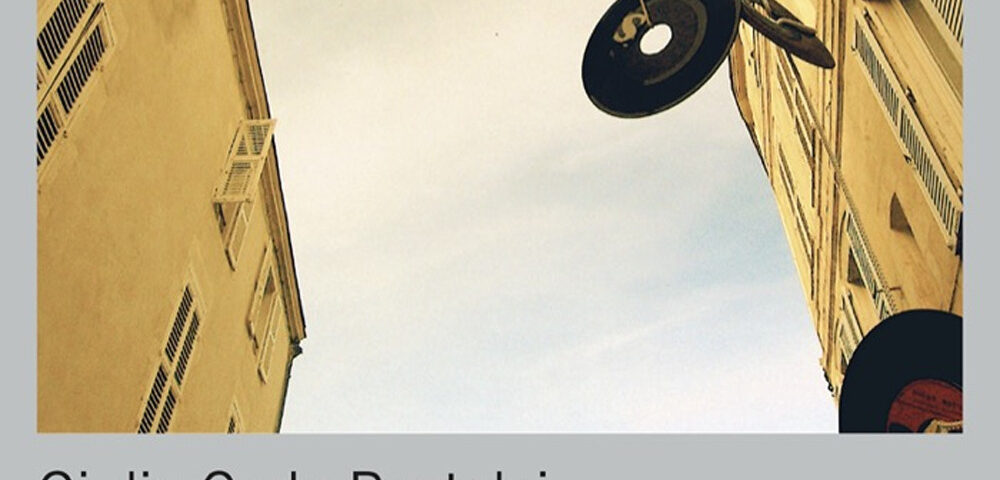Febbraio 1964, Sanremo, XI Festival della canzone italiana. In diretta televisiva, tra un acuto e l’altro, uno dei maggiori poeti del tempo, il livornese Giorgio Caproni, è chiamato a leggere alcuni versi ancora inediti, che l’anno successivo confluiranno in Congedo del viaggiatore cerimonioso: «Ahi l’uomo – fischiettai – | l’uomo che di notte, solo | nel gelido dicembre, | spinge il cancello e – solo – | rientra nei suoi sospiri». È difficile, forse impossibile, immaginare un contrasto più stridente: e ancora di più se pensiamo che si tratta della stessa edizione del Festival vinta da Gigliola Cinquetti con Non ho l’età.
Il curioso aneddoto, sinora poco noto, figura in apertura di Una lingua per cantare di Giulio Carlo Pantalei: avvincente e dottissima ricostruzione dei tentativi di alcuni dei maggiori scrittori italiani del secondo Novecento di inserirsi nel mondo della musica leggera per trasformarlo alla radice. Tutto il libro, a dire il vero, è un po’ così: una sequenza ininterrotta di sorprese, per il semplice motivo che in precedenza nessuno aveva mai provato a raccontare un ventennio di letteratura “alta” – dalla fine degli anni 50 alla fine degli anni 70 – attraverso le sperimentazioni dei narratori e dei poeti che, sulla scia di analoghe esperienze europee (da Jacques Prévert a Bertolt Brecht), cercarono di introdurre in Italia una canzone finalmente “adulta” nei contenuti e nelle forme.
Per ricostruire questa storia incredibilmente complessa e articolata, Pantalei ha optato per una scansione geografica. Dopo l’apertura a Sanremo, ecco gli «anni di Torino», dove dominano le figure di Italo Calvino, Franco Fortini e Fausto Amodei (con il progetto del “Cantacronache”), seguiti dagli «anni di Roma», dove – in un ideale passaggio del testimone – è invece attorno a Pier Paolo Pasolini e a Laura Betti che all’inizio degli anni 60 si raduna un gruppo di scrittori interessati a comporre dei versi musicabili, da Alberto Moravia a Goffredo Parise, da Ennio Flaiano ad Alberto Arbasino. Fino alla Bologna di Roberto Roversi e Lucio Dalla: con i quali, un poco malinconicamente, il volume si avvia a conclusione nel decennio successivo.
Fondato su una vasta ricerca archivistica e su numerose interviste con gli ultimi testimoni di quella stagione, Una lingua per cantare merita di essere letto anche solo per il gran numero di aneddoti che raccoglie o per i testi e gli spartiti (anche di autori studiatissimi) che sottrae all’oblio. Ecco, per esempio, riapparire una ignota traduzione caproniana de Il disertore di Prévert e quella di Pasolini delle canzoni per il film Sweet Movie del regista jugoslavo Dus?an Makavejev (1974). O la scoperta che grazie a Giacomo Debenedetti la canzone Dove vola l’avvoltoio di Sergio Liberovici e Italo Calvino ricevette un riconoscimento speciale al Premio Viareggio del 1958 (una notizia sin qui assente anche dagli annali del premio). O la ricostruzione del pomeriggio di prove in cui – letteralmente chiudendosi «nel cesso» – Gigi Proietti mise in musica alcuni epigrammi di Flaiano nati da una passeggiata goliardica con Federico Fellini. E così via: una rivelazione ogni tre o quattro pagine.
Una lingua per cantare offre però anche molto altro. Pantalei possiede infatti solide competenze metriche e musicologiche e, senza appesantire la lettura, ogni volta che serve interrompe la narrazione per analizzare la partitura e il sistema dei versi, con notazioni che spesso illuminano in maniera originale anche le opere maggiori dei poeti e dei narratori da lui studiati. In un periodo in cui sempre più spesso gli studiosi di letteratura si accontentano delle genericità della storia culturale per raggiungere un pubblico più vasto, o invece, con un’opzione altrettanto estrema, cercano rifugio nel commento ai testi, non capita spesso di leggere un saggio in cui le microanalisi stilistiche si sposano così felicemente col racconto.
E c’è la politica. Estremizzando un poco il discorso di Pantalei, le tre città della canzone raccontate nel libro appaiono le capitali di tre Sinistre diverse, intrecciate ma anche in competizione: quella marxista di Torino (dove gli operai ci sono per davvero), quella libertaria e radical chic di Roma (dove l’irrisione del perbenismo borghese sostituisce le lotte sociali) e quella quasi dadaista della Bologna studentesca. A differenza dei tanti che da qualche anno studiano le collaborazioni dei grandi autori novecenteschi con il cinema, la radio o la televisione in cerca di precursori e padri nobili per l’attuale società dello spettacolo, Pantalei mostra al contrario come scrittori e musicisti si siano allora incontrati proprio per offrire un’alternativa ai prodotti stereotipati dell’industria culturale di allora. Non certo da apocalittici, ma ancora meno da integrati.
Dagli esperimenti degli scrittori-parolieri degli anni 50-60 sono venuti fuori i grandi cantautori italiani del decennio successivo – e Pantalei è bravissimo a mostrare i loro cospicui debiti verso quella esperienza così feconda. Tuttavia non si è trattato di un percorso lineare, senza contrasti e senza perdite. Già alla metà degli anni 60 (cioè prima dei veri esordi di De André, Guccini, Dalla, De Gregori, ecc.) Fortini aveva lamentato il ridursi a «meri moduli al servizio dell’espressione e della comunicazione odierna» di quelle che, in precedenza, erano state forme di contestazione radicale (surrealismo compreso), indicando proprio nelle «canzonette» uno dei campi in cui l’asservimento al mercato era stato più rapido, e fatale. Su basi simili, non molto tempo dopo, si sarebbe incrinato e poi rotto il sodalizio artistico di Roversi e Dalla. Nel 1992, la scelta di quest’ultimo di concedere Il motore del 2000 per la pubblicità televisiva della Fiat Uno rappresenta davvero, da questo punto di vista, il perfetto requiem per un’intera stagione creativa e di ideali. E non aver chiuso gli occhi sui conti che non tornano, per raccontare solo i successi di quella fruttuosa collaborazione tra scrittori e musicisti, non è l’ultimo dei meriti di Una lingua per cantare.
https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/