
Veneziani in via d’estinzione
21 Marzo 2023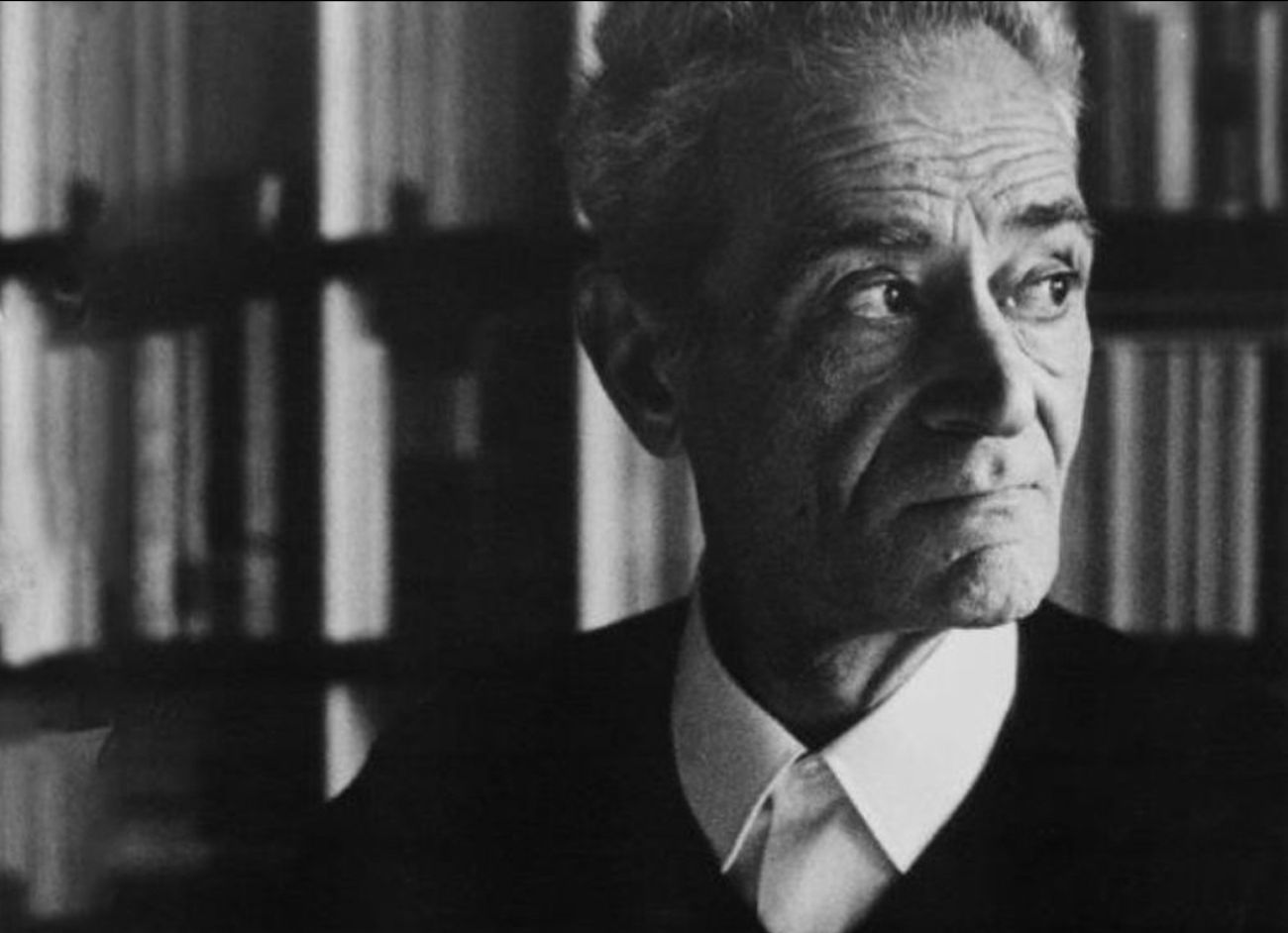
I poeti invisibili maestri del tempo così lontani dalla rete e dai talk show
21 Marzo 2023Agatha Christie in una celebre battuta sosteneva che «Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova». Attualmente nel giallo dello stato di salute del sistema bancario globale e, di conseguenza, di quello economico-finanziario, siamo arrivati in pochi giorni già alla coincidenza. Il fallimento della Silicon Valley Bank (Svb) e il successivo crollo in borsa di Credit Suisse richiamano immediatamente il crack di Lehmann Brothers, cioè il fallimento bancario che accese la crisi finanziaria globale del 2008. A distanza di quindici anni, come di riflesso, il ricordo e le paure tornano a quella vicenda, quando le autorità statunitensi non intervennero, lasciando fallire l’istituto. L’automatismo è in parte giustificato, se si considerano le fragilità dell’attuale sistema finanziario e l’importanza del fattore fiducia, ma ad alcune analogie corrispondono anche differenze importanti che restituiscono un quadro complesso ed estremamente dinamico.
Sarà una nuova Lehman?
Molti analisti hanno messo in luce le differenze, rassicurando ed escludendo che il fallimento di Svp sia l’inizio di una nuova crisi sistemica. Questa visione indubbiamente poggia su alcuni elementi di verità.
Dopo la crisi del 2008 i meccanismi precauzionali sono aumentati. I vari accordi quadro raggiunti a Basilea svolgono una funzione di deterrenza richiedendo alle banche maggiore capitalizzazione e liquidità. L’Europa, nel tempo, si è dotata di sistemi di controllo più rigidi. Non a caso il presidente dell’Associazione delle Banche Italiane (Abi) si è precipitato a tranquillizzare l’opinione pubblica affermando che non vede «il rischio di contagio anche perché in Europa le regole sono più rigide», sottolineando come la Silicon Valley Bank, sebbene fosse sottoposta al regime di Basilea, rientrasse in una categoria di banche soggetta ai requisiti patrimoniali, ma non a quelli di liquidità. In Italia gli indici sulla liquidità sono piuttosto elevati, garantendo maggiormente dai rischi di fuga degli investitori e sulla durata delle fonti di finanziamento. Infine, la Svp è la sedicesima banca statunitense e non la quarta banca d’affari come la Lehman, con una dimensione chiaramente sistemica che Svp non ha.
Fin qui le differenze rassicuranti. Passando alle analogie si potrebbe partire proprio dalle reazioni: in fondo anche nel 2008 le istituzioni finanziarie non immaginavano la valanga che il fallimento di Lehman avrebbe innescato e qualcuno si affrettò addirittura a brindare, interpretando il crack come un segnale di vitalità del mercato, uno stop deciso al moral hazard, capace di punire gli investimenti sbagliati e di premiare quelli corretti. Che quello di Silicon Valley Bank perlomeno non sia un caso isolato lo confermerebbe il fatto che in questi giorni c’è stato anche il crollo della sua filiale britannica (comprata per una sterlina dal colosso HSBC), il fallimento della Signature Bank (ventunesima banca a stelle e strisce), della Silvergate Bank (legata al mondo delle criptovalute) e il salvataggio in extremis della First Republic Bank (avvenuto proprio ieri grazie all’intervento dei principali istituti statunitensi). Primo indizio, dunque.
A distanza di meno di una settimana si verifica il crollo borsistico del 28% di Credit Suisse. Nell’istituto elvetico durante il 2022 erano emerse difficoltà, con perdita di clientela e ristrutturazioni con migliaia di esuberi, totalizzando perdite complessive per 7,3 miliardi di franchi (solo nel 2008 aveva registrato un risultato peggiore con perdite pari a 8,2 miliardi). Le ragioni sono molteplici e autonome dal caso Svp, ma riassumibili nel fatto che Credit Suisse ha inanellato una serie di insuccessi legati alle sue pratiche iper speculative, a fenomeni di corruzione diffusa, a flop di mercato che offrono uno spaccato di come poco sia cambiato nelle dinamiche di fondo del mondo bancario dopo il 2008. Nel 2021 l’istituto aveva già registrato un risultato negativo pari a 1,6 miliardi a causa dei fallimenti dell’hedge fund Archegos e alla liquidazione dei fondi Greensill. Il punto di contatto con Svp è la progressiva mancanza di liquidità dovuta alla fuga dei clienti negli ultimi mesi del 2022. Dopo il fallimento di SVB l’istituto elvetico ha registrato una nuova fuga di capitali e contestualmente è arrivato l’annuncio dei principali soci, i sauditi di Saudi National Bank, che non interverranno con nuove iniezioni di liquidità, anche se si rivelassero necessarie. Un handicap derivante dall’espediente di utilizzare risorse provenienti da quella che potremmo definire la grande finanza emergente, che spesso si caratterizza per investimenti a breve termine. Problemi che vengono da lontano combinati con un quadro contingente piuttosto precario. Parliamo, comunque, di un istituto del sistema bancocentrico elvetico, che non è sottoposto alle regole europee o dell’eurozona, ma che ha comunque una portata globale che si riverbera proprio nelle vicine Borse europee con pesanti perdite. Secondo indizio, una coincidenza?
Tanti continuano ad affannarsi nel dichiarare che il sistema delle banche europee è solido e non esposto come quello anglosassone. In parte è vero, ma lo era anche ai tempi della Lehman… Dopo il 2008 l’allora ministro plenipotenziario all’Economia e al Tesoro, Giulio Tremonti, rivendicava la solidità del sistema del credito italiano, ma il Credit Crunch mondiale, la recessione del 2009 e il crescente costo del debito pubblico, investirono eccome il sistema finanziario italiano. La mancanza di eccessi e una certa perifericità delle banche italiane non mise al riparo il paese dalla crisi globale. Gli attuali appelli all’ottimismo e al fatto che «qui è diverso», dunque, non sono tranquillizzanti fino in fondo, tanto più che negli Usa la tendenza a una maggiore regolamentazione bancaria è stata frenata sotto la presidenza Trump. La maggiore regolamentazione, inoltre, non è di per sé un muro invalicabile per meccanismi finanziari che hanno importanti strumentazioni per aggirare regole e paletti. In fondo i paradisi fiscali, il sistema bancario ombra e l’enorme dimensione del mercato dei titoli derivati sono ancora lì, dove erano dopo la crisi del 2007-2008. Per non parlare dei livelli di indebitamento. Nel 2021 il debito privato era sostanzialmente identico a quello del 2007 in Italia, Stati uniti e Germania, era cresciuto del 25% sul Pil in Giappone e dell’83% in Francia, solo il Regno unito ha fatto registrare una contrazione di oltre quaranta punti. Contemporaneamente crescono fortemente i livelli di indebitamento nei paesi emergenti. Il debito complessivo mondiale è passato dal 269% del Pil del 2007 a quasi il 350% nel 2022, e i debiti pubblici hanno contribuito a oltre il 50% della crescita.
Forse la novità più importante è proprio la memoria di quella crisi, e di quella pandemica, in cui le banche centrali hanno, chi prima e chi dopo, dimostrato di poter spegnere con interventi senza precedenti il panico finanziario. Ma forse il problema, almeno in parte, nasce anche da qui.
Tra aumento dei tassi d’interesse e la e-sovraproduzione
Per rifuggire da facili e meccanici richiami al passato, si tratta di capire cosa è accaduto e, in particolare, cosa potrebbe accadere. È giudizio diffuso che le cause del fallimento della Silicon Valley Bank siano riconducibili principalmente a due ordini di motivi che si sono intrecciati tra loro. Il primo, scatenante, è di natura finanziaria, cioè l’aumento dei tassi d’interesse. Il secondo, più legato all’andamento dell’economia reale, è la crisi delle start up che hanno come epicentro la California. Entrambi ricchi di complesse implicazioni.
Andiamo con ordine. Svb era la principale banca di riferimento per l’architrave della cosiddetta economia digitale. Gli anni della pandemia erano stati particolarmente fruttuosi per il settore, e il conseguente aumento della liquidità era stato investito dalla banca californiana in titoli di stato statunitensi. Negli ultimi 12 mesi i tassi d’interesse, dopo i ripetuti aumenti della Fed (la banca centrale statunitense), sono passati in breve tempo da pressoché zero al 4,5%. Tale operazione è stata condotta dalle principali banche centrali per cercare di contenere la crescita dell’inflazione.
Deglobalizzazione selettiva, pandemia, guerra, crisi ambientale ed energetica, hanno dato vita a un aumento dei prezzi come non si vedeva da quarant’anni. Il deciso aumento del costo del denaro implica una svalutazione del valore nominale dei titoli di stato acquisiti, non quelli che arrivano alla loro scadenza naturale, quanto quelli che un istituto, per necessità, deve vendere in anticipo. La vendita anticipata dei Treasures per far fronte alla liquidità richiesta dai propri clienti, che nel frattempo vivevano un momento di diffusa difficoltà, ha determinato perdite enormi nel portafoglio di Svb. Una dinamica simile a ciò che è accaduto a Credit Suisse più esposta sul mercato obbligazionario privato e travolta dalla fuga dei clienti in seguito a scelte speculative sbagliate e a condanne costose per pratiche illegali. In entrambi i casi le perdite hanno generato ulteriore allarme, poi panico e innescato una corsa al ritiro online della liquidità da parte dei clienti. Da qui il fallimento di Svp e il crollo di Credit Suisse. Pare che i fondi non garantiti dalla banca californiana avessero raggiunto l’87% del totale. La rapidità con cui si è sparso il panico nel settore è stata particolarmente impressionante: qualche giorno prima del fallimento, le principali agenzie di rating consideravano Svp una banca in salute, ancora una volta fallendo totalmente di fronte all’emergere di una crisi bancaria.
L’azione governativa tesa a salvare i piccoli correntisti (fino a 250.000 dollari di deposito) al momento sembra rappresentare poca cosa, dato che i principali clienti della banca sono concentrati in aziende grandi e piccole del settore digitale e hanno cifre depositate ben superiori, senza le quali potrebbero fallire a loro volta in un settore, quello digitale, che in questi anni si è caratterizzato per elevate dosi di innovazione, ma anche di rischio. Start up e venture capital (cioè capitali che investono in società che ancora non hanno confermato il loro potenziale, spesso in perdita, in attesa che diventino aziende di successo), hanno trovato in questo campo un contesto ideale per proliferare. Anche grazie ad anni di moneta facile. La repentina inversione di rotta delle politiche monetarie ha messo direttamente in concorrenza l’accresciuta appetibilità dei titoli di stato proprio con l’investimento in titoli delle start up, sottraendo inevitabilmente risorse a quest’ultime proprio nel momento di maggior bisogno. Con la pandemia, infatti, il settore è cresciuto notevolmente, finendo in sovraproduzione con il progressivo ritorno alla normalità. Il fallimento di Svp non è solo una storia finanziaria, ma anche un segnale di difficoltà profonda del pezzo più dinamico del capitalismo americano. Negli ultimi mesi sono stati annunciati piani di ristrutturazione con decine di migliaia di licenziamenti proprio da colossi come Google, Twitter, Amazon, Facebook.
La distruzione non può essere creatrice
Riflettiamo, dunque, sui due assi lungo i quali è esplosa la Silicon Valley Bank. Iniziamo dall’ultimo. Il primo fallimento finanziario digitale ci parla delle difficoltà, perlomeno, del settore di punta dell’attuale economia. Il settore che dovrebbe svolgere la funzione di traino. Dalle difficoltà aziendali siamo passati alle difficoltà delle banche che con queste hanno a che fare. Colpisce, per esempio, che in un recente libro il noto imprenditore Carlo De Benedetti sia disposto a una profonda critica del sistema economico dominante, ma finisca per salvare, portandolo a modello, proprio quel venture capitalism a impronta anglosassone dove i capitali di rischio scommettono sulle innovazioni facendo da volano per l’intera economia. Nella sua critica, dunque, sfuggono dai radar proprio i problemi e il modello oggi sotto i riflettori. Un modello dove non basta enfatizzare le innovazioni avvenute negli scantinati californiani, ma vedere anche l’ipercompetizione che si impone, le dinamiche speculative, i processi di concentrazione e acquisizione, il pesce grande che mangia sempre quello piccolo, la crescita di dinamiche di iper sfruttamento in una logica inesorabile con al centro il mercato e le sue rigide regole. Come ha recentemente scritto il massmediologo Douglas Rushkoff «le piattaforme digitali hanno trasformato un mercato che era già all’insegna dello sfruttamento e dell’estrazione (si pensi a Walmart) in qualcosa di ancor più disumano (si pensi ad Amazon)».
Il secondo aspetto è la lotta all’inflazione. La scelta decisa per contrastarla mediante l’innalzamento dei tassi e l’abbandono delle politiche monetarie accomodanti inizia a mostrare la corda. Tentennamenti e battute d’arresto verso la normalizzazione monetaria si sono imposte nella lunga fase post-crisi del 2008. Ogni volta che le banche centrali hanno provato a mettere fine alle politiche monetarie non convenzionali e ultra espansive, si sono palesate difficoltà complessive dell’economia finanziaria e reale che hanno costretto a un passo indietro. Ciò non deve stupire particolarmente, il modello economico entrato in crisi nel 2008 era caratterizzato da quello che è stato definito keynesismo finanziario e privatizzato. In altre parole, la crescita dei prezzi degli asset finanziari e immobiliari, favorita dall’azione dello stato e delle banche centrali, ha permesso una crescita dell’indebitamento, che a sua volta ha tenuto alta una domanda aggregata, messa a dura prova dalla decennale politica di ridimensionamento della quota salariale sul reddito complessivo a tutto vantaggio di rendita e profitti. Dopo il 2008 non si è affermato un nuovo modello, ma si è salvato il precedente con dosi ancora più massicce d’intervento monetario e d’indebitamento. Ora l’inflazione ha tolto i freni all’azione delle banche centrali, anche perché l’inflazione stessa è andata a minare i rendimenti reali di molti investimenti finanziari. L’andamento di diversi mercati borsistici e finanziari è, infatti, negativo da mesi. Ma l’operazione è contraddittoria e dolorosa, soprattutto perché la politica di rialzo dei tassi, pur aumentando gli introiti nominali delle istituzioni creditizie, svaluta titoli a lungo termine sia pubblici (come nel caso di Svb) che privati (come nel caso di Credit Suisse) e contemporaneamente rischia d’innescare una catena di fallimenti nelle aziende strutturalmente indebitate e incapaci di uscire da un ciclo del debito di tipo speculativo.
Il sistema finanziario ed economico dopo il 2008 non ha intrapreso una strada diversa. La crescita resta asfittica. Sottrarre moneta facile resta difficile. Certo anche l’inflazione alla lunga erode capitali. Ciò spiega la determinazione dei banchieri centrali, ma il fallimento di Svb e il crollo di Credit Suisse potrebbero nuovamente imporre un rallentamento, l’ennesima diluizione della normalizzazione monetaria, se non un suo arresto. Il contesto è complesso. Il rischio è quello di passare dai due casi che fanno una coincidenza ai tre che fanno una prova. E forse di prove che qualcosa di strutturale non funziona nessuno sente il bisogno. Difficile scegliere tra inflazione e protezione del sistema, mediante droga monetaria.
Quel che però non pare all’orizzonte è l’affermarsi di quel meccanismo schumpeteriano chiamato della «distruzione creatrice». Far fallire banche, aumentare nettamente il costo del denaro, ripulire il sistema economico-finanziario dai rami secchi è sistemicamente, oltre che socialmente, sopportabile? Attualmente l’unica distruzione possibile appare poco creatrice. Perciò, se ci fosse da scommettere, riteniamo che in ultima analisi si accetterà una dose oltre il consentito di inflazione (fino a che punto?), piuttosto che rischiare di mandare tutto a gambe all’aria. Vedremo nei prossimi mesi le decisioni delle principali banche centrali. Mentre scriviamo, registriamo l’intervento straordinario della Banca centrale svizzera per salvare Credit Suisse e la contemporanea scelta della Banca centrale europea di aumentare nuovamente il costo del denaro di 0,50%. Per ora pare affermarsi in eurozona la linea dura, ma va considerato che i tassi, dopo questo aumento, restano ancora inferiori di un punto a quelli statunitensi e ampiamente negativi in termini reali. Non solo, era difficile immaginare una retromarcia così repentina dopo che la Lagarde aveva annunciato in lungo e in largo un radicale aumento dei tassi. Emergono, però, anche le prime importanti pressioni a rinviare ulteriori innalzamenti dei tassi, e forse proprio per questo oggi la Bce non ha fatto riferimento ad altri possibili incrementi.
Vedremo la condotta che assumerà la Fed. Prendere tempo è stata la regola aurea degli ultimi quindici anni. Probabilmente sarà la strada che guiderà l’azione della politica monetaria anche in futuro, ma navigare a vista quanto può durare?
*Marco Bertorello collabora con il manifesto ed è autore di saggi su moneta e debito. Danilo Corradi insegna filosofia e storia ed è docente a contratto all’Università Tor Vergata. Insieme hanno scritto Capitalismo tossico (Alegre, 2011).





