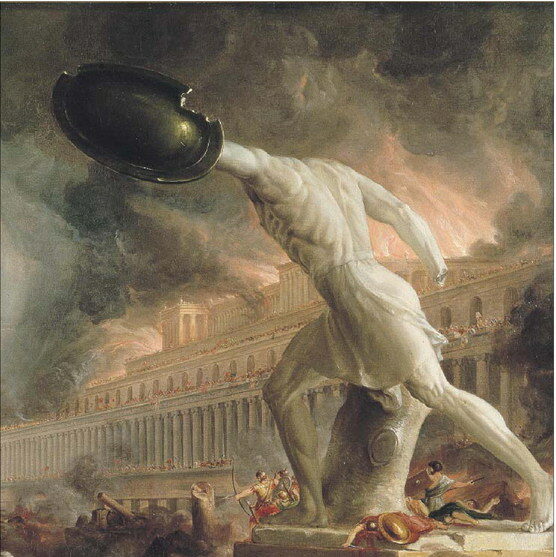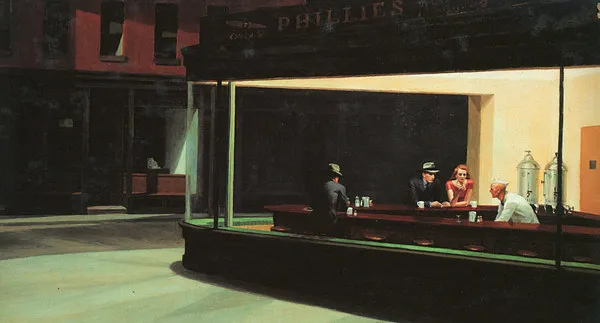Nella scorsa settimana di due notizie non si è occupato praticamente nessuno. Il 15 novembre al convegno la Qualità dell’inclusione a Rimini il pedagogista Dario Ianes ha illustrato i risultati di un’indagine per cui il 27,1 per cento dei docenti è favorevole al ritorno di classi speciali (nel 2023 era il 17 per cento, più di dieci punti percentuali in meno). È un fenomeno allarmante, che prospetta la possibilità nel dibattito pubblico del ritorno di quello che si poteva considerare giustamente un tabù: le classi differenziali.
Il 10 novembre scorso invece è morta a quasi cento anni a Luserna San Giovanni, nella Val Pellice, in Piemonte, Mirella Antonione Casale; era nata a Torino il 12 dicembre 1925. Casale è stata la promotrice di quella che giustamente molti considerano una delle riforme più importanti per l’istruzione in Italia se non di tutta la storia repubblicana: la legge 517 con cui nel 1977 vennero eliminate le classi differenziali. I pochi necrologi e articoli di commiato riprendono al massimo il comunicato dell’Anffas, l’Associazione nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (lei stessa aveva fondato una sezione delle valli pinerolesi nel 1989) o ricordano la fiction Rai del 2016, La classe degli asini, con Vanessa Incontrada a impersonarla.
Sembra completamente dimenticata se non rimossa ogni dimensione intellettuale e politica della sua biografia, mentre proprio oggi è più che necessario ricordare e onorare gli effetti imponenti della sua battaglia personale e collettiva.
La figlia Flavia
La storia di Casale è esemplare per tante ragioni diverse, che vanno tutte esplorate. Laureata in lettere classiche a Torino nel 1949, inizia la sua carriera come insegnante di lettere nelle scuole medie e tecniche. Nel 1957 nasce sua figlia Flavia, che a nemmeno sei mesi viene colpita dall’influenza asiatica, per cui sviluppa febbri altissime e una gravissima encefalite virale che la porta in coma. Dall’ospedale viene dimessa solo per essere lasciata morire a casa. Casale riesce a risvegliarla dal coma grazie a un nuovo farmaco sperimentale per neonati, anche se Flavia riporta gravi e permanenti lesioni cerebrali e resta incapace di apprendere, di parlare e di essere autosufficiente (è morta nel 1994 per un melanoma).
I medici e gli specialisti, compresi neuropsichiatri infantili e neurologi, le consigliano insistentemente di collocare la bambina in un istituto specializzato, una pratica che Casale rifiuta sempre. Quando Flavia fa sei anni, Casale tenta di iscriverla alla scuola dell’obbligo, ma Flavia è rifiutata ovunque. L’unica possibilità sono quindi le classi differenziali, le classi destinate ai “diversi”.
Qui la storia privata si incrocia con la storia pubblica. Le prime classi speciali, chiamate “classi speciali per fanciulli deficienti”, sono state aperte a Torino nel 1900 presso la scuola Aurora: è l’inizio dell’istituzione di intere scuole destinate ai cosiddetti ritardati. Esperienze simili si sono sviluppate negli stessi anni in altri paesi europei: in Francia, le classes pour arriérés, in Spagna le clases de niños retardados, in Germania le Hilfclassen, nel Regno Unito le special classes.
Classi differenziali
La locuzione “classe differenziale” è stata coniata sotto il regime fascista con il testo unico sull’istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d’integrazione del 1928. E nel 1933 le classi differenziali sono state ufficialmente introdotte nella scuola elementare. Il fascismo tratta la disabilità con un misto di cordoglio patriottico e discriminazione pseudoscientifica. All’onore per i mutilati di guerra (il mito di Enrico Toti) si accompagna una segregazione de facto e de jure di tutte le persone con disabilità, compresi i bambini. Fuori dall’Italia, tra le due guerre, cresce invece in modo disarticolato ma progressivo un’attenzione per una didattica che oggi chiameremmo inclusiva, soprattutto rispetto ai problemi dell’educazione linguistica.
Dopo la Seconda guerra mondiale, il bacino d’utenza delle classi differenziali si amplia: arriva a includere non solo alunni con disabilità ma anche “i bambini e i ragazzi feriti dalla guerra”. Viene adottata una categorizzazione più complessa dei disturbi cognitivi e scolastici; si utilizza spesso la tipologia del disadattamento per indicare sia i ragazzi con disturbi psichici, fisici o sensoriali che limitano la capacità di apprendimento, sia i ribelli, gli asociali, i disadattati appunto.
Il fascismo viene sconfitto, e nel 1948 viene proclamata la Costituzione che tiene insieme due articoli, il 33 e il 38. Non si fa caso quasi mai che sono due articoli in parte contraddittori. Il 33 recita «La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso». Il 38 recita: «Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale». E nella pratica la disuguaglianza è ancora più forte. Alla fine degli anni Quaranta solo un ragazzo su tre in età di obbligo si iscrive alla scuola media. Il tasso di analfabetismo è del 13 per cento. Due ragazzi su tre vanno precocemente a lavorare. Dopo le classi elementari si può scegliere, diciamo così, tra la scuola media che consente di proseguire gli studi, e la scuola d’avviamento professionale.
Scuola media unica
Nel decennio successivo le inchieste parlamentari sulla miseria e la disoccupazione evidenziano la gravità del problema educativo. La stragrande maggioranza dei lavoratori manuali del dopoguerra era entrata nel mondo del lavoro da minorenne con studi assenti o interrotti precocemente; e alla fine degli anni Cinquanta il tasso di scolarità nella scuola media cresce per arrivare a uno su due, facendo emergere l’incoerenza lacerante tra la crescita del benessere e la persistente esclusione educativa dei figli dei lavoratori che non possiedono il titolo dell’obbligo scolastico. Si arriva al 1962, alla legge sulla scuola media unica, un avanzamento normativo prodotto dalla convergenza di una stagione riformistica che coinvolge democristiani e socialisti ma anche una parte dei comunisti, guidati dalla riflessione pedagogica di Gramsci.
E qui emerge il più grande paradosso della democrazia italiana: le classi differenziali resistono anche nella scuola media unica. Come indica la norma, queste vengono destinate a soggetti ritenuti “ipodotati intellettuali non gravi”, “disadattati ambientali” o con anomalie comportamentali, con l’intenzione di reintrodurli nella scuola comune dopo uno o due anni di didattica individualizzata. Insomma, nonostante la democratizzazione incarnata dalla legge del 1962 (l’apertura alle classi sociali più povere; la percentuale di 14enni in possesso del diploma di licenza media che passa dal 43 per cento del 1963 a oltre l’82 per cento del 1973), il mantenimento delle scuole speciali e delle classi differenziali esclude coloro che vengono classificati come minorati o anormali.
La coesistenza di scuola media unica da una parte e scuole speciali e classi differenziali genera un dibattito vivacissimo e trasversale. C’è chi sostiene che le condizioni siano migliorabili ma questa divisione sia necessaria per evitare che i meno capaci possano costituire una “zavorra” per il resto della classe; c’è chi ne rivendica il valore proprio in nome di una pedagogia speciale; c’è chi invece è profondamente contrario.
Dibattito tra i progressisti
La discussione più interessante avviene proprio nel mondo progressista/democratico. A difendere le classi differenziali, almeno in una prima fase, è il padre della neuropsichiatria infantile in Italia, Giovanni Bollea: «Dall’inizio della scuola e fino alle vacanze di Natale i maestri sono chiamati a osservare i loro alunni e, successivamente, a selezionarli, con l’ausilio di un’équipe medico-psico-pedagogica, inviando gli incapaci nelle classi differenziali». Contro Bollea e il mondo degli psicologi cominciano a schierarsi invece il Movimento di cooperazione educativa e in special modo Bruno Ciari, che nel 1969 poco prima di morire pubblica La grande disadattata, nel quale rovescia fin dal titolo lo strabismo pedagogico delle classi differenziali. (Ciari in special modo va riletto, come invita del resto il saggio di Vanessa Roghi, Rileggere La grande disadattata, in cui affiora come la sua posizione fosse in antitesi rispetto alle molte idee di “pedagogia speciale” d’impostazione psicologico-medicale).
La pedagogia dovrebbe essere tutta speciale, perché è la scuola cosiddetta normale a essere disadattata, non gli studenti esclusi e emarginati nelle classi differenziali.
Da Don Milani a Basaglia
Ma non è solo il mondo dei docenti e degli specialisti a discutere; ma anche – e molto – i genitori. Mirella Antonione Casale è entrambi. Tra il 1963 e il 1965 Casale frequenta un corso biennale di specializzazione in psicologia, nel quale sviluppa una sensibilità pedagogica e verso i bisogni delle persone con disabilità e riesce a concepire un’evoluzione scientifica della scuola inclusiva, per le persone come sua figlia Flavia.
Nel 1967 esce il libro che fa deflagrare il dibattito sulla scuola, Lettera a una professoressa scritto da don Lorenzo Milani insieme ai suoi ragazzi di Barbiana. Nel 1968 esce invece il libro che modifica per sempre il dibattito sulla segregazione negli spazi istituzionali, L’istituzione negata di Franco Basaglia, il testo chiave per la cosiddetta antipsichiatria e per le lotte che porteranno alla legge 180 e alla chiusura dei manicomi nel 1978. Nel 1970 esce il libro di Tullio De Mauro, L’educazione linguistica dell’Italia unita, che diventerà il caposaldo dell’educazione linguistica democratica.
La ricezione di quello che avviene nel doposcuola a Barbiana, nei dipartimenti di linguistica, nelle sperimentazioni scolastiche, nei reparti psichiatrici a Gorizia e a Trieste e nelle scuole sperimentali in Italia – investe ogni altra battaglia sulla scuola inclusiva (lo ricostruisce bene anche qui sempre Vanessa Roghi nel suo saggio La lettera sovversiva e nel podcast Gli archivi della follia) – compresa quella contro le classi differenziali.
L’inserimento selvaggio
Anche Casale conosce l’esperienza di Barbiana e le idee di Basaglia e, come neopresidente dell’Anffas torinese, organizza insieme a genitori e insegnanti volantinaggi, manifestazioni e proteste. Nel 1968 vince il concorso per diventare preside della scuola media, e comincia a lavorare alla Camillo Olivetti a Torino. Da preside e attivista si dedica a due grandi fronti, come dichiara lei stessa: il tempo pieno e l’integrazione degli alunni che allora si chiamano “handicappati” nelle classi comuni. Riesce a far chiudere un istituto psichiatrico dove i bambini venivano segregati e apre un centro diurno per la sperimentazione educativa.
Tutto questo è possibile per la convergenza di famigliari, operatori sociali e insegnanti, che creano, mentre le piazze si riempiono delle lotte dei movimenti operai, un altro fenomeno di massa: l’inserimento selvaggio. I genitori degli alunni disabili vengono spinti a togliere i loro figli dagli istituti speciali, considerati ghetti, e a iscriverli nelle classi comuni. Questo porta le scuole speciali e le classi differenziali a perdere oltre 22mila iscritti tra il 1968 e il 1975. Migliaia di studenti con disabilità vengono inseriti nelle scuole ordinarie, spesso senza supporti materiali o educativi specifici, ma è un’onda che dilaga anche nel dibattito pedagogico: dal maestro Alberto Manzi (del Movimento di cooperazione educativa e della trasmissione tv Non è mai troppo tardi) al professore Aldo Visalberghi che ragiona su come la valutazione determini in modo ponderoso i meccanismi di segregazioni come le classi e le scuole speciali.
Su Raiplay si trovano tutte le puntate del programma di Luigi Comencini, I bambini e noi: nel quarto episodio vengono intervistati i bambini di una classe differenziale di Prima Porta. L’evidenza è che si tratti di una segregazione che non ha nessun senso pedagogico ma è soltanto una discriminazione di tipo sociale e economico che tiene ancora in piede questa separazione.
La pressione generata dall’inserimento selvaggio e l’azione politica dei movimenti (come quello dei genitori guidato da Casale) spingono lo Stato a intervenire. La legge 118 del 30 marzo 1971 accoglie parzialmente queste spinte e stabilisce che alcune categorie di alunni disabili debbano adempiere l’obbligo scolastico nelle classi comuni.
La legge è firmata dai principali esponenti della corrente di sinistra della Democrazia Cristiana, da sempre vicini alle associazioni di volontari e operatori nel campo delle disabilità, nella stragrande maggioranza dei casi favorevole al superamento dei ghetti.
Sempre nel 1971 Casale avvia sperimentalmente l’inserimento di alunni con disabilità intellettive e psicofisiche nelle classi comuni del tempo pieno, prima ancora che la Legge 517 del 1977 lo imponga.
Documento Falcucci
Viene anche istituita una commissione parlamentare, per monitorare gli effetti della legge 118 (che effettivamente è molto difficile da applicare e al tempo stesso non risolve i problemi di segregazione) e per fare un lavoro d’inchiesta permanente sui problemi scolastici degli studenti con disabilità guidata da Franca Falcucci, che nel 1975 sintetizza la situazione nel Documento Falcucci. La prospettiva del documento è realmente riformistica se non rivoluzionaria: «La preliminare considerazione che la Commissione ha ritenuto di fare è che le possibilità di attuazione di una struttura scolastica idonea ad affrontare il problema dei ragazzi handicappati presuppone il convincimento che anche i soggetti con difficoltà di sviluppo, di apprendimento e di adattamento devono essere considerati protagonisti della propria crescita. In essi infatti esistono potenzialità conoscitive, operative e relazionali spesso bloccate degli schemi e dalle richieste della cultura corrente e del costruire sociale».
I principi innovativi del documento sono i cardini di quella che oggi definiamo scuola inclusiva: 1) La struttura scolastica per gli alunni cosiddetti handicappati non doveva essere configurata come una nuova scuola speciale o differenziale, 2) La scuola doveva adeguare l’azione educativa alle potenzialità individuali di ogni allievo, superando il concetto rigido del voto, 3) Le classi comuni dovevano avere una popolazione limitata (15-20 alunni).
L’insegnante di sostegno
Sono gli stessi principi che costituiscono la base della legge 517 del 4 agosto 1977, che segna il più grande momento di trasformazione nelle pratiche scolastiche: la legge sancisce l’abolizione progressiva delle classi differenziali (articolo 7, comma 10), promuove l’integrazione scolastica e introduce la figura dell’insegnante specializzato (l’insegnante di sostegno) per favorire la partecipazione attiva dei bambini con disabilità nei contesti educativi e didattici comuni. Al termine “inserimento”, dunque, alla fine degli anni Settanta viene sostituito quello di “integrazione”, che va a colmare i vuoti dell’inserimento, facendo appello alle potenzialità del bambino con disabilità, e promuovendo situazioni educative volte al loro sviluppo qualitativo e quantitativo.
È la vittoria di Mirella Antonione Casale, e del movimento di genitori e docenti che lei ha accompagnato, guidato, attraversato. Dal 1977 al 1982 le viene dato un incarico dal Ministero della pubblica istruzione presso il provveditorato agli studi di Torino con il compito di coordinare e seguire l’integrazione scolastica dei disabili. E poi rimane politicamente attiva anche dopo il suo pensionamento nel 1988 e il trasferimento a Torre Pellice, dove fonda la sezione Anffas delle Valli Pinerolesi nel 1988, che presiede per otto anni.
Nel 1991 pubblica Il bambino handicappato e la scuola, scritto con Pierangela Peila Castellani e Francesca Saglio, in cui spiega le ragioni e i modi in cui ha cambiato la scuola e l’intero Paese in meglio, in molto meglio. Nel 1992 viene promulgata la legge 104 che definisce in modo ancora più articolato il diritto all’educazione e all’istruzione nella scuola comune e pone al centro l’integrazione e la creazione di un progetto di vita orientato all’autonomia del disabile, possibile con il coinvolgimento anche di altri enti sociali.
Verso la fine degli anni Novanta si va definendo l’idea che per realizzare l’inclusione scolastica sia necessario il costante coinvolgimento della comunità educativa nella sua totalità, in quanto, per realizzare la “scuola di tutti”, perché non sono sufficienti l’inserimento delle persone con disabilità nelle classi comuni e la loro educazione individualizzata.