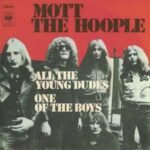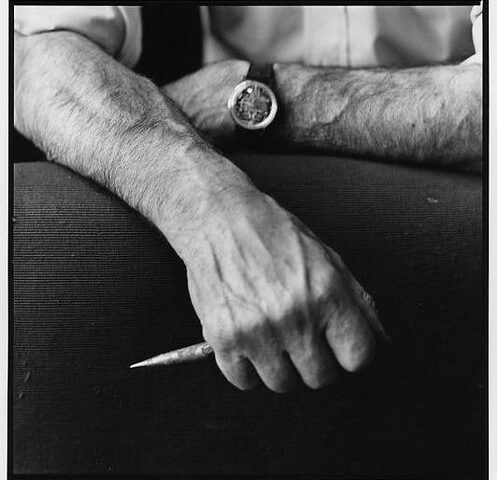Sull’arte di Lucio Fontana (Rosario di Santa Fé, Argentina, 1899-Comabbio, Varese, 1968) si sono scritti tanti saggi, monografie, cataloghi, da riempire intere biblioteche. Sulla persona di Lucio Fontana, al di là dei commenti spesso ripetuti sull’eleganza impeccabile anche quand’era in ristrettezze, sul grande fascino personale, sul suo essere un instancabile donnaiolo pur avendo accanto per l’intera vita la paziente Teresita (allora non era raro, però), sulle sue doti di ballerino e sulla passione per le Lucky Strike (quando non era in bolletta, ma fino agli anni 50 lo fu quasi sempre), su di lui uomo, prima che artista, e sulle prove che dovette affrontare sin dall’infanzia, ben poco si sapeva sinora. Eppure la personalità di questo maestro che con i suoi Concetti spaziali (i Buchi, i Tagli) ha creato autentiche icone della modernità, da quegli eventi non poté non essere segnata.
A raccontarne la storia, fondata su una solida documentazione, ha provveduto Paolo Campiglio, da sempre studioso dell’opera di Fontana e imparentato con la famiglia dell’artista: il padre di Lucio, Luigi, sposò infatti in Argentina Anita Campiglio, che fu per il piccolo un’affettuosa vice-madre.
Chi sapeva, se non pochissimi, che Lucio avesse avuto due “madri”? Una, quella biologica (Lucia Bottini) era una modella bellissima e anticonformista che nel 1899, quando dalla sua storia con Luigi Fontana nacque il piccolo, rifiutò di sposarlo e per qualche anno allevò il bambino da sola. L’altra fu Anita, la moglie di Luigi che, nato nel 1865 a Capolago, Varese, nel 1890 era sbarcato in Argentina in cerca di fortuna, con il suo diploma di Brera. Quando il marito strappò il piccolo Lucio alla madre e lo portò in casa, Anita lo accettò come un figlio proprio, allevandolo teneramente con il primo dei numerosi bambini che avrebbe messo al mondo, tutti molto amati da Lucio. Per lui furono anni di felicità vera ma ad appena sette anni il padre lo sradicò di nuovo e lo portò in Italia, affidandolo ai duri collegi del tempo, mentre i fratelli crescevano felici a Rosario, in famiglia. Non stupisce che appena prima di compiere i 18 anni –nel 1917, piena guerra- Lucio si sia arruolato volontario con i “ragazzi del ‘99”, compiendo presto un atto di eroismo, di cui solo ora si sono trovati i documenti, che gli guadagnò una medaglia d’argento al valore. E non stupisce che nel 1921, riportato a Rosario da quel padre-padrone che lo voleva con sé nella sua florida impresa di scultura funeraria, lui sia presto fuggito, restando per due anni nel mezzo della pampa húmeda, a Sunchales, dove visse da gaucho, sotto le stelle: «Ero un mandriano e dormivo all’aperto. Ho vinto gare e competizioni ippiche di velocità con cavalli non addomesticati. Sono stati anni felici, di cui ho sempre nostalgia» rammenterà. Chiarendo però in seguito (a Carla Lonzi, nel 1967) che quegli orizzonti senza fine certamente lo segnarono ma che «lo spazio non è la pampa, lo spazio è un altro, nella testa». Un «concetto», appunto.
La sua volontà di rompere tutti gli schemi in arte, di lottare per creare una nuova scultura e poi una nuova pittura fatte (come per l’amato Boccioni) di spazio e non di volume, fu alimentata anche dal rapporto burrascoso con quel padre tanto autoritario, che lo accusava di essere uno scioperato sognatore? È possibile. Certo è che con l’autorità e le istituzioni Lucio Fontana intrattenne sempre rapporti difficili. Accadde con la sua prima opera monumentale, l’altorilievo in bronzo del 1932 per il Monumento ai Caduti di Erba, progettato dall’amico Giuseppe Terragni: una Vittoria che, non amata dalle gerarchie fasciste per il suo sperimentalismo, fu presto rimossa: «per offrire bronzo alla patria» si disse, ma fu poi fusa e trasformata nel gran cannone posto all’interno di quell’architettura. E accadde alla Biennale veneziana del 1950, quando lui, che aveva appena presentato alla Galleria del Naviglio di Milano l’Ambiente spaziale a luce nera (1949), era ormai il riconosciuto – seppure deriso da molti– maestro dello spazialismo: propose l’Ambiente ma Rodolfo Pallucchini lo rifiutò, esponendogli solo le sculture ceramiche. Anche più dolorosa la vicenda del concorso per la V Porta del Duomo di Milano, in cui al suo progetto (i gessi, magnifici, sono al Museo Diocesano di Milano) fu preferito quello di Luciano Minguzzi. Non che non ricevesse riconoscimenti ma per lui e Teresita la vita fu durissima per lunghi anni.
Oltre alle tante notizie sulla vita in Argentina (frutto anche dello studio commissionato dalla Fondazione Lucio Fontana alla studiosa italo-argentina Daniela A. Sbaraglia), l’autore mette in luce un altro tratto caratteristico della personalità di Fontana che, raggiunto il successo, era sì generosissimo con i giovani artisti ma che da loro sembrava anche trarre sempre nuova linfa: così, alla fine degli anni 30, avvicinandosi ai giovani di «Corrente», dopo le sculture astratte tornò a una figurazione quasi espressionista nelle grandi opere («sculture, non ceramiche!», tuonava) realizzate ad Albisola nella fornace di Tullio Mazzotti. E poi, bloccato dalla guerra in Argentina, fu con i suoi studenti dell’Accademia di Altamira che nel 1946 formulò il «Manifiesto blanco», dove si gettavano le basi dello spazialismo, mentre fu anche grazie all’energia scaturita dal dialogo con Yves Klein e Piero Manzoni che nel 1958 trovò la forza di attuare, dopo i Buchi, il gesto dirompente e azzerante dei Tagli.
Paolo Campiglio
Lucio Fontana.
La possibilità di un oltre
Johan & Levi, pagg 368, € 40