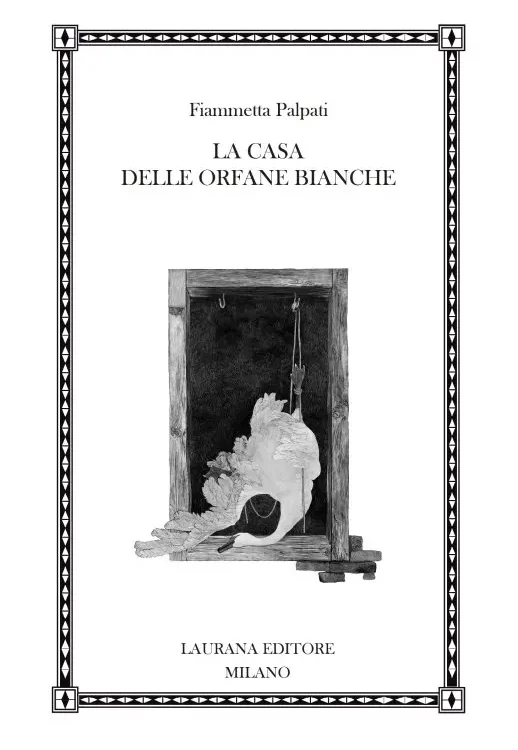Bipopulismo. Le parole della neopolitica
7 Ottobre 2022Così l’aria della rivolta spazza via «il destino dell’obbedienza»
7 Ottobre 2022Della conclamata marginalità, nel contesto globale, della letteratura francese, non sembra prendere atto il più prestigioso premio internazionale: dopo Le Clézio (2008) e Modiano (2014), arriva il terzo Nobel del nuovo secolo – la Francia è seconda solo al Regno Unito. E certo, fra i recenti vincitori transalpini, Annie Ernaux è quella che più merita il riconoscimento: non solo (non tanto) per ragioni estetiche (di gran lunga superiore a tutti e tre, Pierre Michon è ancora una volta, forse definitivamente, ignorato), quanto per evidente congruità con l’idea di letteratura che, salvo felici eccezioni, l’Accademia di Svezia mostra di apprezzare: genericamente engagée, incline a una testimonianza personale e a una denuncia politica, attente a tenersi lontane dalle più urticanti contraddizioni.
Ernaux riscuote consensi sia nel vasto pubblico, sia fra esigenti studiosi (più all’estero che in Francia, a dire il vero). Ha dato la sua impronta al sottogenere romanzesco che forse più di ogni altro è assurto a forma simbolica dei decenni a cavallo fra i due secoli: la cosiddetta autofiction, autobiografia di fatti in una certa misura inesistenti, disinvolta nel travisare la minuta cronaca individuale per accrescerne icasticamente la rappresentatività collettiva, rendendo porosi i confini fra realtà e finzione, fra identità e performance.
NESSUNO più di Ernaux ha creduto nella possibilità di parlare dei destini generali raccontando la sua vita: quella di una donna di estrazione socioculturale umile e provinciale, che ha attraversato il secondo dopoguerra, si è integrata nella middle class intellettuale, ha vissuto gli anni della contestazione e dell’emancipazione femminile, cogliendo un significato al tempo stesso personale e collettivo in tutte le esperienze antropologicamente marcate che le sono occorse. Dal rapporto con i genitori alla liberazione sessuale, dall’aborto al matrimonio, dal tumore alla vecchiaia, quasi non c’è evento rilevante (per lei e per tutte) cui non abbia dedicato un libro: in questo senso, un genere nato al maschile come l’autofiction rivela, declinato al femminile, una vitalità supplementare – per la banale ragione che la vita di una donna del 1940 è stata in media più ricca di imprevedibili e a volte traumatiche trasformazioni di quella di un suo coetaneo maschio eterosessuale.
RISVOLTO NEGATIVO di questa impresa, ostinatamente autobiografica e sociologica, è una certa ricorsività dei temi e degli stilemi. Quella di Ernaux è un’opera coerente anche perché spesso (e sempre più negli anni) ripetitiva: non è perciò una gratuita provocazione sostenere che un libro non tradotto come L’usage de la photo (2005), coniugando immagine e testo, racconto di un trauma (una malattia ancora difficile da accettare) e di un’esperienza erotica in età matura (bellissime le descrizioni delle fotografie degli abiti tolti velocemente e gettati a terra alla rinfusa prima del sesso), è più riuscito del celebratissimo Gli anni (2008): dove l’autobiografia al plurale, il parallelo fra le vicende di una donna e quelle della Francia, l’intreccio fra un io taciuto (la protagonista autobiografica è «elle») e un noi precario o impersonale (è un romanzo in chiave di «on»), trova la sua più grandiosa, ma anche prevedibile e manieristica, esecuzione sinfonica.
IL FATTO È CHE LA SCRITTRICE ha studiato sociologia, e il suo maestro Bourdieu quasi sempre offre ai suoi romanzi strumenti d’interpretazione del reale che sembrano – a lei e al lettore – perfettamente adeguati. Ha fatto l’insegnante, Ernaux, e nei suoi libri c’è non di rado un fondo didattico: non spiattellato, certo, ma roccioso; c’è una pretesa di dire il vero sulla storia, per emblemi e immagini allegoriche. Perciò, se per un verso «pochi autobiografi hanno saputo raccontare così bene l’oggettiva inappartenenza della vita personale alla persona che la vive» – ha scritto di lei Guido Mazzoni – per un altro è legittimo il sospetto che la postura quasi inavvertitamente pedagogica della narratrice trattenga molte sue pagine al di qua della grande letteratura.
LE IMPLICITE CERTEZZE – progressiste, femministe, di sinistra: sempre dalla parte giusta, insomma – si incrinano di rado, forse solo nel bellissimo Il posto (1982), storia del rapporto con il padre, della bruciante vergogna per la goffaggine sociale del genitore: dove il ribrezzo per la rozzezza (innanzitutto linguistica) dei familiari si mescola inscindibilmente, nella figlia parvenue intellettuale, con uno struggente, insopportabile senso di colpa.