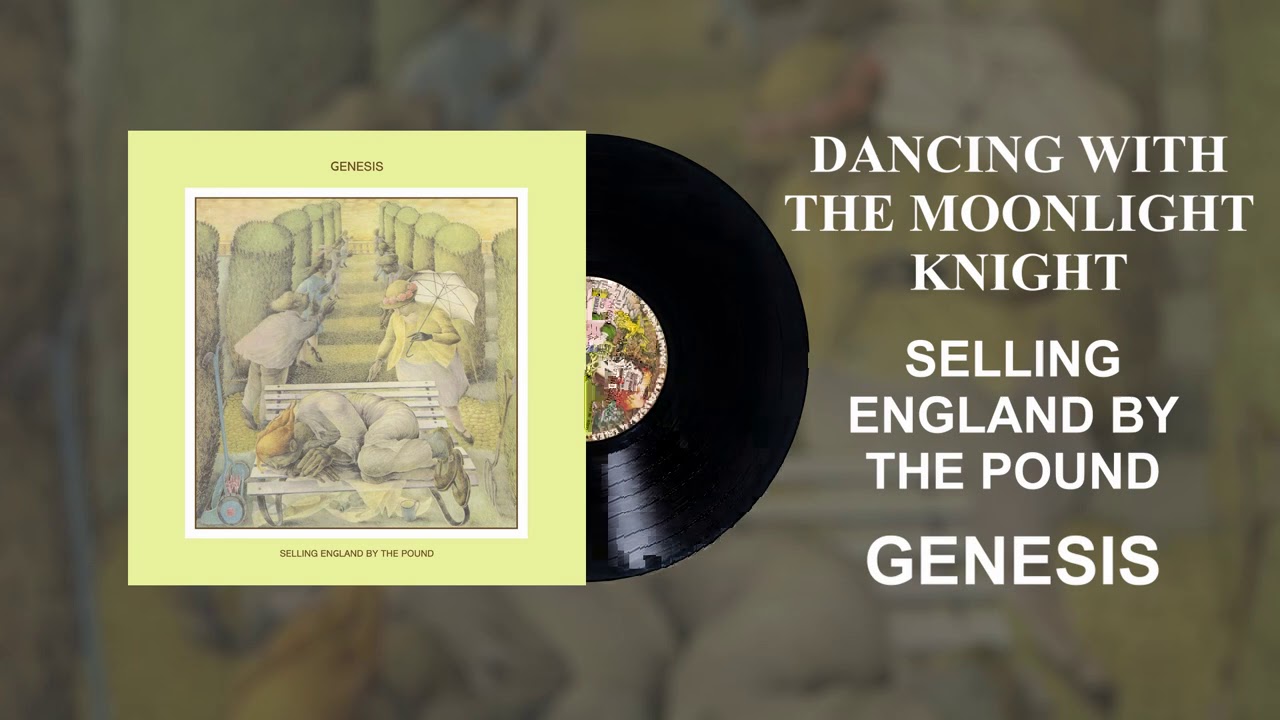Si è vissuta e si vive, sia pure con ansia crescente, da parte degli artisti l’idea di un’arte espansa figlia del concetto benjaminiano di perdita dell’aura come libero gioco di compenetrazione di arte e vita nelle più svariate esperienze, senza alcun limite. Il dogmatismo storicistico si è come capovolto in possibilismo senza regole capace di spezzare i confini anche tra i generi fondendo parola, immagine, suono.
Un’apparente estrema libertà si è poi avuta col ricorso al gioco della citazione. Viviamo ancora oggi un relativismo senza punti di riferimento, un orizzonte infinitamente espanso, un futuro senza storicità, senza un divenire che implichi continue trasformazioni, falsificazioni nel senso popperiano. A questo punto se l’opera d’arte vale in quanto tale e non per la sua collocazione nella storia risulta molto difficile poter dar valore ad opere tanto discontinue, molto più facile identificare il valore con il prezzo e ricorrere al “ciò che costa vale”.
È Antoine Compagnon ad introdurre il concetto d’ironia come criterio per dare senso all’idea che solo la genialità dell’artista sarà in grado con uno sguardo ironico di destituire l’opera di quei valori assoluti in cui si sarebbe oggettivato lo spirito creativo infinito e quasi divino. Anche Vattimo applica il concetto d’ironia all’opera d’arte postmoderna «uno dei criteri di valutazione dell’opera d’arte sembra essere, in primissimo luogo, la capacità dell’opera di mettere in discussione il proprio statuto».
L’ironia come categoria estetica è utilizzata dai romantici ed è quella propria del genio dell’artista che con uno sguardo ironico carica l’opera di un segno di perenne insoddisfazione.
Se davvero risultava impossibile dar valore ad opere discontinue e l’ironia “salvezza debole” non ha potuto trasformarsi in un apprezzabile strumento in quella direzione, l’Artworld ha con fiammeggiante successo messo in atto le pragmatiche strategie capaci di fissare il valore anche intellettuale delle opere nel prezzo, anzi proprio il prezzo è il valore dell’opera stessa. Nel tempo abbiamo, sia pure con qualche trepidazione, dovuto constatare che l’arte si è velocemente trasformata in oggetti atti a produrre capital gain, beni rifugio, asset class, aggregati, fino al punto, nel caso di procedere agli acquisti, di convincerci a evitare letture di decorativi e inutili apparati critici dirigendoci piuttosto verso utili Gatekeepers o Market Masters, ragionando come la gallerista newyorkese Mary Boone detta «The Queen of the Art Scene» quando con pudore parlava delle proprie perplessità a tramutare l’arte in puro business e sentenziava «ma le ho superate». Andy Warhol, da par suo, mormorava: “The good business is the best art” e Thomas Hoving del Met di New York ci allietava facendo sapere che «l’arte è sexy, l’arte è soldi-sexy, arrampicata sociale fantastica».
Mutazioni oggettive cariche di conseguenze non trascurabili (ne parla anche Christian Caliandro in un suo recente libro Contro l’arte fighetta) la prima delle quali è la scomparsa della figura dell’artista come intellettuale e di molti di coloro che, a vario titolo, trafficano con gli strumenti della creatività. Abolita ogni attitudine critica, irrequietezza intellettuale, gusto reale del non allineamento, gioia dell’eclettismo, l’artista si perde imbambolato in un vago universo di dubbia potenza espressiva e non s’accorge d’essere immerso – purché tenuto in qualche considerazione – nel labirinto della trafila delle certificazioni, l’indescrivibile territorio fatto di osservanze, obblighi e silenzi critici. Per lo più schiavo della ripetizione differente legata ad un presunto immodificabile stile fatto per la riconoscibilità commerciale, il magico regno in cui le opere d’arte hanno valore come oggetti di marca, brand esclusivi. Siamo, come vuole Jean Baudrillard nel suo Le complot de l’art, all’illusione degli artisti che quando pensano di fare arte producono in realtà solo feticci disincantati gli stessi che Roger Caillois chiama “ornamenti iperbolici”. Notte scura fatta di radi bagliori luminosi, l’universo critico è popolato per lo più di manager a sostituire gli studiosi, mai come li vorrebbe Sabino Cassese “Dotti, Saggi, Maître à penser, Public Intellectual”.
Solo un ricordo letterario l’immagine dell’intellettuale come figura solitaria, individuo critico verso la società e i suoi riti banali, ribelle per cultura, nemico giurato degli obblighi imposti, un personaggio che possa aver da fare con lo Stephen Dedalus di James Joyce.
In balia del letterario taedium vitae leopardiano, spleen romantico, persino angoscia esistenziale, le insicurezze dell’artista pensante generano malinconia per un’arte che, a sentire l’amico Baudrillard, «tenta di abolire sé stessa man mano che si esercita».