
Mosca sfida l’Europa: retorica di guerra alla vigilia del faccia a faccia Trump–Putin
11 Agosto 2025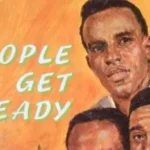
People Get Ready
11 Agosto 2025
In Italia il tema del fine vita si muove su un terreno fragile, dove questioni morali, diritto e politica si intrecciano senza una direzione chiara. All’interno della stessa Chiesa cattolica emergono approcci differenti. Da una parte, l’orientamento prudenziale che invita a non intervenire se il rischio è quello di legittimare scelte ritenute incompatibili con la dottrina; dall’altra, la convinzione che una legge nazionale, pur frutto di compromesso, possa arginare vuoti normativi e disuguaglianze territoriali.
Questa seconda visione è sostenuta da mons. Vincenzo Paglia, impegnato anche nella riforma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria per gli anziani. A suo avviso, il pericolo maggiore non sta nell’affrontare il tema in Parlamento, ma nel lasciare che siano tribunali e giunte regionali a decidere caso per caso, creando una mappa disomogenea di diritti e tutele. Il suo obiettivo non è riconoscere un “diritto alla morte”, ma definire limiti chiari in cui l’aiuto a morire non sia perseguibile, salvaguardando chi è più fragile e vulnerabile.
Il cuore della sua critica, tuttavia, non si ferma alla questione normativa. Paglia denuncia una realtà poco raccontata: l’abbandono terapeutico, quel vuoto di assistenza che lascia troppi malati gravi senza cure adeguate o sostegno umano. Nonostante la legge sulle cure palliative garantisca questo diritto da oltre un decennio, in molte regioni resta lettera morta. Per riordinare concetti e linguaggio, la Pontificia Accademia per la Vita ha diffuso un vademecum che chiarisce termini e principi etici, dalla sospensione di trattamenti sproporzionati alla distinzione tra terapie ordinarie e straordinarie.
Sul fronte opposto si colloca chi, come il cardinale Camillo Ruini, teme che una legge sul fine vita possa trasformarsi in una porta aperta verso pratiche irreversibili, preferendo quindi che il legislatore non intervenga. La divergenza tra i due non riguarda la condanna dell’eutanasia e del suicidio assistito, ma la strategia: per Ruini è prioritaria la difesa dei principi, per Paglia la prevenzione di un far west normativo.
Il confronto italiano si inserisce in un contesto europeo tutt’altro che uniforme. Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Spagna hanno legalizzato l’eutanasia; Svizzera, Germania e Austria consentono il suicidio assistito; altri Paesi, come Francia e Regno Unito, mantengono divieti formali ma si affidano a sentenze per i casi particolari. Dove si è legislato, spesso lo si è fatto parallelamente a un rafforzamento delle cure palliative, in alcuni casi rendendole passaggio obbligato.
Per Paglia, discutere di fine vita significa anche interrogarsi sul ruolo dei cattolici nella sfera pubblica. Non si tratta di fondare un partito confessionale, ma di proporre visioni capaci di superare la frammentazione e di affrontare le sfide globali — dall’individualismo estremo ai nazionalismi — con un orizzonte comune. Cita come ispirazione esperienze storiche in cui, in momenti di crisi, si è avuto il coraggio di immaginare un futuro condiviso per l’Italia e l’Europa.
In questo senso, la legge sul fine vita non è soltanto un provvedimento di natura bioetica. È un banco di prova per capire se il Paese è in grado di trattare questioni complesse senza ridurle a slogan o contrapposizioni sterili, costruendo invece un quadro di garanzie che protegga la dignità di ogni persona fino all’ultimo istante della vita.





