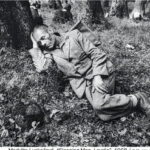
Istantanee sulle strade della fede nelle mostre fotografiche
10 Agosto 2025
Gli Oasis e la nostalgia millennial: l’unico argine è Ticketmaster
10 Agosto 2025Fino a pochi anni fa non se ne sapeva nulla, ma il «Grande Gatsby» ebbe tre stesure, conservate a Princeton, che parlano della insoddisfazione dell’autore, convinto di avere fallito in tutto: nella vita, nel matrimonio e nella scrittura
Se c’è un romanzo perfino troppo generoso di frasi indimenticabili, è Il Grande Gatsby. Nick Carraway, insieme a Jay Gatsby sul Queensboro Bridge che scavalca Blackwell Island, oggi Roosevelt Island, alla vista di una limousine guidata da un autista bianco con tre neri sul sedile posteriore, due uomini e una donna, pensa: «Qualunque cosa può accadere ora che siamo passati su questo ponte, qualunque cosa…». Quando Nick osserva, «Non puoi ripetere il passato», Gatsby risponde incredulo e orgoglioso: «Non puoi ripetere il passato? Certo che lo puoi!». E quando Nick non sa definire la voce di Daisy se non come «indiscreta», Gatsby gli risponde brusco: «Ha una voce piena di soldi»; una frase che era, ed è ancora, la migliore definizione della Voce dell’America.
Perle di saggezza possono essere estratte a ogni pagina, anche sganciate dal contesto («‘Dio vede tutto,’ ripeté Wilson. ‘È solo una pubblicità,’ lo rassicurò Michaelis»), ma nessuna colpisce come la conclusione di Nick su chi sono veramente Tom e Daisy Buchanan, dopo che la tragedia si è consumata senza che loro ne siano stati toccati: «Erano gente sbadata, Tom e Daisy; distruggevano cose e creature per poi ritirarsi nei loro soldi o nella loro immensa sbadataggine o in qualunque cosa li tenesse insieme, lasciando che gli altri riparassero i cocci che loro avevano abbandonato…».
Francis Scott Fitzgerald pubblicò Il Grande Gatsby nel 1925. Potrebbe ancora essere il cronista di ciò che l’America continua a produrre di enorme, eccessivo e folle. «Muoviti in fretta e fracassa tutto» (Move fast and break things) è il motto dei tecnocrati di Silicon Valley. Ai loro inizi erano tutti come Gatsby, dei simpatici, romantici lestofanti. Non appena le loro voci hanno cominciato ad avere il suono dei soldi, sono diventati tutti dei Buchanan.
Ogni libro – ha detto Jean François Lyotard – in fondo non è che un mucchio di frasi. Può darsi. Ma ci sono frasi e frasi. E quelle del Grande Gatsby sono perfette. Nelle scuole superiori americane viene ancora assegnato come lettura, il che forse non fa bene alla sua reputazione, né presso gli studenti, per i quali è un compito a casa, né presso i critici più sofisticati, che oggi gli preferiscono Tenera è la notte. Che forse è più «romanzo», è vero, ma non ha quella cadenza implacabile, da storico romano, che Fitzgerald riesce a conferire all’inarrestabile caduta di Jay Gatsby nato James Gatz, ebreo del Minnesota di umili origini che per scuotersi di dosso il suo peccato di non-americanità deve ricrearsi da solo, «da un’idea platonica di se stesso» (altra memorabile frase).
Il primo titolo
Inizialmente, Fitzgerald voleva intitolare il romanzo Trimalchio in the West Egg, pensando al Trimalcione del Satyricon di Petronio (e un’intera stesura con quel titolo, abbreviato in Trimalchio, è stata tradotta da Nicola Manuppelli per Mattioli 1885). Ma il Gatsby che conosciamo, quello dell’ultima versione, non ha nulla del ricco liberto che offre interminabili banchetti per guadagnarsi amici e farsi strada nella politica dell’impero. Gatsby è più simile a quei personaggi di Boccaccio come Nastagio o Federigo, cavalieri di un’età cortese in cui ormai credono soltanto loro, e che dissipano i loro averi per far colpo sulla dama del loro cuore. Storie con un lieto fine, che però a Gatsby non è destinato.
Quel poco che ho realizzato è stato sempre con il lavoro più faticoso e in salita, e ora vorrei non essermi mai rilassato, mai guardato alle spalle…Francis Scott Fitzgerald
Trimalchio può essere letto come una ricostruzione o un’ipotesi. Il rapporto tra Jay e Nick è più stretto, forse Daisy è più innamorata di Jay di quanto non lo sia nell’ultima stesura, e Jay non afferma di poter rivivere il passato a volontà. Di fatto, il Grande Gatsby è uno e trino. Ed è Emma Sarconi, curatrice della collezione di libri rari alla Firestone Library della Princeton University, a sorvegliare che tutte le pagine delle tre stesure complete rimangano avvolte nella loro busta di cellophane, una per una, in una stanza climatizzata: quelle del manoscritto originale, con le sue gloriose cancellature e minuziose riscritture al limite della leggibilità; quelle delle prime bozze, ancora con il titolo Trimalchio; più la prima edizione con ulteriori correzioni. (Un altro titolo che Fitzgerald aveva contemplato era Sotto il rosso, bianco e blu – della bandiera, s’intende, a riprova che l’autore sapeva di voler scrivere il «grande romanzo americano»).
La celebre copertina dipinta da Francis Cugat, con il volto piangente e la ruota di Coney Island – un’interpretazione del romanzo più che un’illustrazione – è conservata insieme al manoscritto. Chi vuole lo può scorrere consultando il sito della Princeton University Library. Eppure, fino a pochi anni fa, non si sapeva quasi nulla di una primissima stesura, un Ur-Gatsby perduto o alla cui esistenza non si credeva nemmeno.
La storia ha inizio nel 1978, quando Matthew J. Bruccoli, curatore dell’edizione commentata dell’opera di Fitzgerald, scrisse sulla rivista della biblioteca di Princeton un breve articolo a proposito di una lettera di Fitzgerald a Willa Cather, scritta nella primavera del 1925 da un albergo di Capri dove Scott e Zelda si erano temporaneamente rifugiati durante la loro errabonda esistenza.
Fitzgerald aveva appena letto Una signora perduta di Willa Cather, uscito nel 1923 (pubblicato in Italia da Adelphi), e temeva che la Marian Forrester di Willa assomigliasse troppo a Daisy Buchanan, o che Willa lo potesse pensare. «Il mio modo di esprimermi», le scrisse Fitzgerald, «non era né così chiaro, né così bello, né così toccante come il tuo, ma la somiglianza essenziale indubbiamente c’era. Ero preoccupato perché mi sarei dannato a dover eliminare quello che avevo scritto, così sono andato da Ring Lardner e da diverse altre persone e ho mostrato loro le mie pagine e le tue, e alla fine ho deciso di conservarle. Ho tenuto anche le pagine della mia prima stesura per mostrartele, e te le allego qui». Willa Cather lo rassicurò, le somiglianze non erano nulla di cui preoccuparsi. «Dopotutto», aggiunse, «l’unica cosa che si può dire della bellezza è quanto duramente ci ha colpito, non è così?».
Nelle due pagine che Fitzgerald inviò a Willa Cather, Nick Carraway si chiamava Dudley, detto Dud, mentre Daisy si chiamava Ada Fay e la sua voce non aveva ancora il rumore dei soldi, era solo il canto futuro di una felicità che doveva ancora, magicamente, accadere.
La lettera di Fitzgerald e la risposta di Willa Cather vennero poi pubblicate, ma nessuno aveva visto che nell’involucro conservato alla Firestone Library giacevano ancora le uniche due pagine rimaste dell’Ur-Gatsby. Nel dicembre del 2011 se ne accorse Anne Margaret Daniel, altra importante studiosa di Fitzgerald. Non è impossibile che il resto del manoscritto giaccia ancora sul fondo di qualche baule a Capri o sulla Costa Azzurra.
Le tredici chiavi
Anche quelle prime pagine, nonostante la bella calligrafia di Fitzgerald, erano segnate da cancellazioni e ripensamenti. «Scrivo lentamente», disse una volta, «e con enorme sforzo». Non amava la macchina da scrivere. I suoi manoscritti sono strati di scrittura, uno sull’altro come pennellate. Da Zelda sappiamo quanto il loro domicilio potesse essere un andirivieni di persone ad ogni ora. L’alcol proteggeva Scott dalle distrazioni e insieme lo distruggeva. Perfino Hemingway gli raccomandò di non bere troppo e di prendersi miglior cura del suo talento. Ma non è vero che non avesse controllo sul caos del suo processo creativo.
Come racconta Sara Antonelli in Domani correremo più forte. Vita letteraria di Francis Scott Fitzgerald (Feltrinelli), negli ultimi anni lo scrittore portava sempre con sé un portamonete con dentro tredici chiavi. Le più piccole aprivano le serrature di schedari, valigie e bauli colmi di carte, appunti e manoscritti conservati in un magazzino di Baltimora affittato nel 1935, e oggi traslocati a Princeton.
Nel 1917, durante la Prima guerra mondiale, Fitzgerald aveva scritto alla cugina Cecilia Taylor che il patriottismo gli sembrava una grandissima idiozia e che se mai fosse morto per l’America in realtà sarebbe morto soltanto per se stesso. L’ultima ironia della sua eredità postuma fu che Il Grande Gatsby, meno di ventimila copie vendute alla sua uscita, e con recensioni tiepide se non negative, fu riscoperto quando il servizio bibliotecario dell’esercito degli Stati Uniti lo incluse nelle sue liste di libri consigliati e spedì 155.000 copie ai soldati impegnati sul fronte della Seconda guerra mondiale e agli ospedali militari. Era un’edizione piccola, a pagine larghe, come un orario ferroviario. Portava il sigillo «Armed Service Edition» e specificava: «Edizione integrale – non condensata».
Fitzgerald non lo seppe mai. Morì il 21 dicembre 1940, all’età di 44 anni, convinto di avere fallito in tutto, nella vita, nel matrimonio e nella scrittura. Una volta scrisse alla figlia Scotty, ancora bambina, quanto gli dispiaceva che nessuno degli amici di lei avrebbe mai saputo niente di suo padre. Aveva regalato a Zelda un anello di pietra verde, come la luce verde in cui credeva Jay Gatsby, la luce dall’altra parte della baia, dove viveva Daisy. Oggi lo porta una signora di nome Blake Hazard, sua pronipote.





