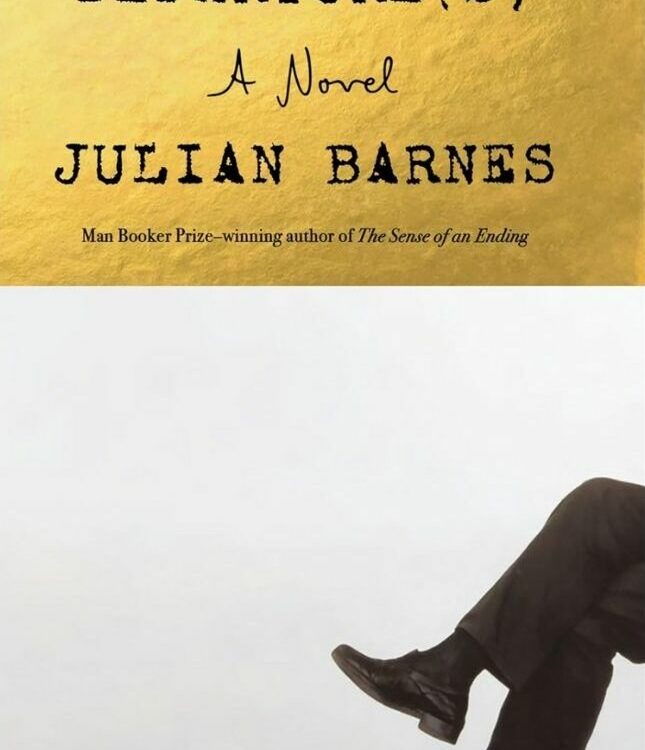La geopolitica a stelle e strisce
4 Novembre 2025
Stevie Wonder- Signed, Sealed, Delivered, I’m Yours
4 Novembre 2025L’anniversario Una riflessione sull’opera e l’eredità del filosofo francese nato 100 anni fa e morto il 4 novembre 1995. Un percorso di letture tra il nostro Paese, la Francia e il mondo anglosassone.
Il doppio anniversario di Gilles Deleuze, nato cento anni fa e scomparso il 4 novembre 1995, oggi è l’occasione per riflettere sull’attualità di uno dei pensieri filosofici e politici più discussi nel mondo. In maniera puntuale è ciò che sta avvenendo in Italia dall’inizio dell’anno. Da Palermo a Milano passando per Padova, sono stati organizzati convegni e seminari, anche online come quello della casa editrice napoletana Orthotes, in cui sono intervenute più generazioni di studiosi su uno dei filosofi francesi più frequentati in Italia. Sin dagli anni Settanta, si sono formate letture diverse.
Tantissimi gli interpreti: da Franco Berardi Bifo a Antonio Negri, da Ubaldo Fadini a Tiziana Villani, da Sandro Palazzo a Rosi Braidotti e Rocco Ronchi, da Filippo Dominicali, Paolo Vignola e chi scrive per la rivista La Deleuziana. E molti altri, tra i quali ci sono anche Giorgio Agamben o Roberto Esposito.
Oggi, probabilmente, c’è un’idea comune: ricominciare dalle basi, cioè dai concetti più importanti creati da Deleuze in libri strepitosi come Nietzsche e la filosofia (Einaudi), Differenza e ripetizione (Raffaello Cortina) o Spinoza e il problema dell’espressione (Quodlibet) al fine di ripensare di nuovo un pensiero che è stato profondamente equivocato, ma anche giustamente valorizzato.
Deleuze da solo, e con lo psicoanalista Félix Guattari coautore di libri da ri-leggere come L’antiEdipo (Einaudi, 1972) o Mille piani (Orthotes, 1980), ha parlato di immanenza, desiderio, schizoanalisi, inconscio macchinico, apparati di cattura, linee di fuga, macchine da guerra, concatenamenti, e così via.
QUELLO DI DELEUZE è un meraviglioso laboratorio di concetti che hanno bisogno di un nuovo apprendistato per essere compresi alla luce di nuovi problemi emersi dalla politica al cinema, dai media al teatro, dalla letteratura alla scienza o all’architettura. Oggi si sente il desiderio di praticare un rigoroso lavoro del concetto, proprio della filosofia, insieme a una non scontata «filologia vivente», cioè quella pratica di lettura intensiva attraverso la quale Antonio Gramsci intendeva conoscere attraverso un’esperienza partecipata e agire attraverso la produzione di affetti condivisi.
Un lavoro culturale di questa portata è stato accompagnato, negli ultimi due anni, dall’iniziativa editoriale di Einaudi che sta traducendo i corsi di Deleuze all’università Parigi 8, prima a Vincennes, poi a Saint-Denis, dal 1970 alla metà degli anni Ottanta. Al momento sono usciti in italiano quelli sulla pittura e su Spinoza. Si attendono gli altri in corso di pubblicazione per l’editore De Minuit in Francia. Senza dimenticare l’editore Ombre Corte che ha tradotto i tre volumi del corso su Michel Foucault.
Molto più discreto rispetto a quello di Pier Paolo Pasolini in Italia, e non paragonabile a quello che nel 2024 ha visto protagonista Michel Foucault, l’anniversario deleuziano di quest’anno è stato più evidente nell’anglosfera. A tale proposito vanno letti i materiali diffusi dalla Edinburgh University Press che pubblica tra l’altro l’importante rivista Deleuze and Guattari studies. Il sito della casa editrice ha dato voce a interpreti di grande valore e originalità, a cominciare da Ian Buchanan fino a Barbara Glowczewski che a ottobre ha raccontato il suo rapporto con Deleuze, Guattari e l’antropologia critica e postcoloniale.
A confutare talune recenti appropriazioni da destra, la dimensione poliedrica e rivoluzionaria di idee che compongono una cassetta degli attrezzi per ripensare e agire nel presente
L’INTERESSE PER L’OPERA di Deleuze nel mondo anglosassone è stato confermato dalla recente pubblicazione per Routledge di un libro di 586 pagine dal titolo suggestivo The Deleuzian mind, costosissimo ma facilmente individuabile in rete, il volume, composto da 38 saggi, è curato da Jeffrey A. Bell e da Henry Somers-Hall. È sufficiente sfogliarlo per rendersi conto dell’ampiezza dei temi, e delle discipline, che hanno attraversato tutta la riflessione deleuziana sulla filosofia, sull’economia, sulla biologia o la matematica, la linguistica, non trascurando la critica del modello familistico ed edipico della psicoanalisi.
Spicca l’interesse per il pensiero politico di Deleuze (con Guattari). Questione delicata perché soggetta ad attacchi, a sinistra come da destra, dettati dalla fallace convinzione che ha identificato Deleuze con il «postmoderno», quando semmai è uno dei suoi critici più radicali.
Una simile convinzione è il lascito della controffensiva neoliberale contro il Sessantotto, di cui Deleuze e Guattari sono stati interlocutori e interpreti inclassificabili.
Jason Read, ad esempio, ha permesso di comprendere come il pensiero di Deleuze e di Guattari si collochi in un rinnovato marxismo. Eugene Holland ha sostenuto che il concetto di assemblaggio serve a pensare praticamente una politica anticapitalista. Claire Colebrook si è soffermata sul concetto del «divenire donna» sul quale si base l’idea del «divenire-rivoluzionari.e» attraverso il quale Deleuze e Guattari hanno rilanciato l’idea della rivoluzione al di là delle catatoniche malinconie in cui versano le sinistre nel XXI secolo.
Si moltiplicano le iniziative editoriali che propongono letture innovative dei suoi testi
UN CONTRIBUTO al rovesciamento di duraturi pregiudizi è arrivato dalla Francia con il libro Deleuze aujourd’hui curato da Camille Chamois e Thomas Detcheverry (Puf, pp. 151, euro 12). Il suo interesse sta nella critica di «letture contro-intuitive».
Di recente si è arrivati ad attribuire a Deleuze le posizioni di reazionari e tecno-fascisti come Nick Land, Peter Thiel (ideologo del trumpismo e fondatore di PayPal) e persino del vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. Deleuze (e Guattari) sarebbero stati i teorici delle capacità «accelerazioniste» del capitalismo, o del desiderio inteso come «diritto», e non invece come lotta e «produzione della realtà», primi assunti del loro marxismo «storico-macchinico».
In Deleuze aujourd’hui, senza ira e con studio, Alyne Costa, Marion Farge, Viviana Lipuma, Adamo da Veiga e Camilla Zani hanno smontato queste riappropriazioni e ristabilito la verità dei testi. Per loro non si tratta di affermare un’ortodossia deleuziana, ma rispettare la lettera di un pensiero poliedrico come tutte le grandi filosofie che si presentano come una «cassetta degli attrezzi» per ripensare, e agire, nel presente.
Ciò che Deleuze (e Guattari) hanno messo a disposizione della politica, sia quella più tradizionalmente «di classe» che quella transfemminista o ecologista, è una critica marxiana del capitalismo che comprende sia una critica del valore che quella del desiderio di una soggettività intossicata e colonizzata dal sessismo, dal razzismo e dal suprematismo. Le prime pagine dell’AntiEdipo sono sufficienti per avvertire la duplicità di un marxismo concepito nei termini di una dialettica del Capitale e in quelli della liberazione, diffusi, ad esempio, nei femminismi materialistici che, con Angela Davis e Selma James, hanno pensato una strategia collettiva dell’autonomia.
Non diversamente da quanto hanno fatto interpreti illustri, ma poco compresi, come il grande critico statunitense Fredric Jameson, anche gli autori di Deleuze aujourd’hui sono stati capaci di distinguere la sussunzione della vita al capitale da un desiderio rivoluzionario che inceppa la macchina e libera i «flussi» del desiderio tramite la produzione di una soggettività «trasversale» composta di «blocchi di alleanze». Questa è un’idea generale della politica definita nei termini di una «macchina da guerra rivoluzionaria» in Mille piani.
L’uso politico del pensiero deleuziano è stato evidente dai libri che Félix Guattari ha scritto da solo: Lignes de fuite, Le tre ecologie o Caosmosi. La bellezza dell’opera, ancora poco valorizzata, è un esempio di cosa significhi pensare con Deleuze.
PARTICOLARMENTE frequentata oggi è l’idea, che ho sviluppato in Divenire rivoluzionari.e. Gilles Deleuze, Félix Guattari e noi (DeriveApprodi), sulla necessità di creare una linea di massa capace di concatenare i divenire rivoluzionari.e dispersi, e frammentati, individuando una duratura potenza di agire. Quella per esempio che abbiamo visto balenare in Italia nel movimento per Gaza.
Gli scritti di Deleuze sulla Palestina in Due regimi di folli (Einaudi, Orthotes) sono importanti. Dimostrano che la sua filosofia non è declinabile in termini euro-americanocentrici. È uno strumento per criticare la necropolitica genocidiaria, comprendere il problema della rivoluzione in tempi non rivoluzionari e affrontare i «fascismi molecolari», a cominciare da quelli usati da Trump negli Stati Uniti.
Il XXI secolo, si legge in Deleuze aujourd’hui, non sarà forse «deleuziano», come ha detto scherzosamente Michel Foucault. Tuttavia, ha ri-avviato un divenire deleuziano del pensiero, e dell’azione, in un secolo dominato dai suoi nemici: il fascismo fossile alleato con il capitalismo tecnologico che non hanno bisogno della democrazia tantomeno di una nuova rivoluzione.