
Meloni fa l’americana: «L’Europa si è un po’ persa»
29 Marzo 2025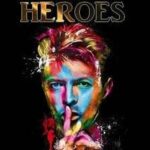
David Bowie – Heroes
29 Marzo 2025Gli adolescenti, un enigma indecifrabile?
La domanda angosciante e sospesa nell’era degli smartphone
QUEI FIGLI CHIUSI IN CAMERETTA E LA PAURA DI NON SAPERE CHI SONO
Adolescence è un pugno nello stomaco per noi genitori del terzo millennio. Racconta una storia estrema che quasi certamente non vivremo mai. Ma al tempo stesso ci dice che ciò che ha generato il dramma intorno al quale la serie ruota – un preadolescente viene incarcerato perché sospettato di aver ucciso a coltellate una coetanea – è già dentro le nostre vite, sta già accadendo ai nostri figli. Ci racconta di una famiglia composta da due genitori amorevoli. Ce li mostra seriamente coinvolti e interessati a fare sì che il proprio figlio abbia la migliore vita possibile. Il padre di Adolescence usa la propria paternità per medicare le ferite della paternità che ha vissuto quando il figlio era lui. C’è empatia e sensibilità nei due adulti che di colpo vedono la loro vita cambiare in cinque minuti, quando una squadra speciale della polizia irrompe di prima mattina nella loro casa.
È la scena di un risveglio tragico e inaspettato. La polizia entra con le armi spianate in una casa dove tutti dormono. Abbiamo la percezione che sia alla ricerca di un criminale pericoloso. Quel criminale è Jamie, tredicenne con il corpo e lo sguardo di un bambino sospettato di essere l’assassino di una compagna di classe. Quando Jamie viene prelevato dalla polizia per essere portato in prigione, piange come un bambino. Il papà lo rassicura: «Ci penso io a te. Vedrai che ne verremo fuori». Si ha la sensazione che sia tutto uno sbaglio. Non può essere che quella “faccia d’angelo” sia il vero colpevole di un crimine tanto orribile. Si apre una crepa dentro di noi: non sappiamo più chi è il colpevole in una scena tanto destabilizzante.
Ma ci viene da dire: la polizia sta sbagliando. E invece… l’intera serie è una lunga narrazione di questo “e invece”. Ci porta alla totale demolizione delle nostre certezze. Scopriamo la solitudine di Jamie, rappresentante di una generazione di bambini e bambine che – una volta entrati nella preadolescenza – si sono trovati a lasciare il pallone e i pennarelli con cui riempivano il loro tempo libero e ad avere in mano uno smartphone, rimanendo per ore chiusi nella propria stanza. Jamie è il testimonial di una mutazione – che potremmo definire antropologica – del passaggio da infanzia ad adolescenza in cui i giovanissimi invece che fare squadra, generare appartenenze, esplorare la vita dal lato giusto (ma verrebbe da chiedersi se ne esiste ancora uno, quando hai 11-12 anni nel terzo millennio e appartieni alla Generazione Zeta) si trovano immersi in dinamiche aggressive e violente, a base di bullismo, vergogna, disprezzo, esclusione, giudizio. Il film racconta una pubertà in cui i luoghi della vita reale diventano un ring, che amplifica la gogna sempre in azione dentro i social media, raccontando un tempo in cui non sai più che è un amico e sperimenti la fatica di muoverti in un gruppo in cui tutti sono contro tutti.
Un mondo, in cui il reale, contaminato dal virtuale, ti porta a 12 anni a parlare di cose di cui non comprendi nemmeno il senso, abitando una vita in cui tutto avviene troppo presto, troppo velocemente, in modo troppo intenso. Una vita in cui gli adulti si trovano sempre in altri luoghi rispetto a quelli frequentati dal figlio. E in realtà nemmeno potrebbero starci in quei luoghi, perché si tratta di communities, social media e chat, spazi digitali che hanno preso il posto del cortile, della panchina nel parco, del campetto di calcio dell’oratorio. Gli adulti non si accorgono di questo “altrove” in cui sostano per molte ore i loro figli, perché quell’altrove è dentro casa loro, nel luogo più sicuro della vita, in cui ad un figlio non può accadere nulla di male: la sua cameretta.
Così, con i figli protetti e al sicuro tra le pareti di casa, gli adulti escono fuori nel mondo, lavorano incessantemente, si sconnettono da loro, travolti dal “troppo da fare che abita le loro vita” fino a dover ammettere, proprio come dice il papà di Jamie, che all’improvviso del proprio figlio non sanno più nulla, lo hanno completamente perso di vista. Il regista ci inchioda a questa consapevolezza, che noi non vorremmo mai sentirci proporre. Con una storia disturbante e perturbante in cui ci sono due adulti che fanno tutto ciò che ad un genitore del terzo millennio viene chiesto di fare, il regista domanda ai suoi spettatori: «Tu mamma e papà, sai davvero chi è tuo figlio che dorme nella sua camera?» e ci mette un dubbio tremendo nel cuore e nella mente, quando ci fa capire che Jamie è un 13enne che nella notte seguente l’assassinio della sua coetanea si è addormentato stringendo un orso di peluche tra le mani, le stesse mani che secondo l’accuso poche ore prima hanno invece stretto un pugnale. Chi è quel figlio che stringe un orsetto e uccide con un coltello? Potrebbe essere nostro figlio? Potrebbe essere il suo migliore amico? Tu guardi Adolescence e non sai darti risposta. È in questa sospensione, che mescola dolore e paura, che il film ci colpisce dritto al cuore. E non ci lascia tranquilli.
Perché tutti sentono il bisogno di parlare di «Adolescence»
LA SOLITUDINE DEI GENITORI TRA «LE CINGHIATE» E «IL MEGLIO»
Il vero motivo per cui tutti in questi giorni stanno parlando di Adolescence, la miniserie di Netflix che racconta la vicenda di un ragazzino di 13 anni accusato dell’omicidio di una coetanea e compagna di scuola, non risiede probabilmente nella sua elevata qualità di regia e recitazione, e nemmeno nella complessità del tema affrontato, aspetti che in ogni caso ne stanno decretando uno straordinario successo.
La ragione più profonda che tiene sulla bocca di tanti la storia del giovane Jamie è legata al fatto che dopo aver visto la serie per intero si manifesta pressante il bisogno di parlarne. Perché è necessario liberarsi di qualcosa, trovare il modo di espellere il disagio condividendolo, superare il trauma attraverso le parole e lo scambio. Adolescence è sì un pugno nello stomaco, come in tanti hanno rilevato – o meglio, sono quattro cazzotti, quante le puntate della serie – ma è soprattutto una forma di abuso, un racconto talmente disturbante per un genitore da richiedere di essere elaborato il prima possibile. Ricordare di cosa parli la serie – per inciso: merita il successo che sta ottenendo – è persino superfluo, se lo spaccato di società nella quale si è condotti da una telecamera che una volta accesa intrappola
per l’intera puntata, è una dimensione umana nella quale nessuno sembra fare la cosa giusta. È tutto sbagliato in Adolescence, tutti commettono a loro modo una forma di violenza nel momento in cui nessuno si prende veramente cura di qualcuno, celebrando il fallimento delle istituzioni che fondano una comunità.
Nel mondo quasi distopico di
Adolescence ogni cosa è fuori posto, niente è come vorremmo che fosse in una società ideale: le forze di polizia, la scuola, i vicini di casa, gli studenti, gli amici, i ragazzi del quartiere, il commesso del negozio, persino la psicologa arriva a istituzionalizzare la rinuncia. E ovviamente la famiglia, perché se c’è un problema a casa è certamente “colpa” della famiglia. Ecco la sottile forma di violenza, un abuso oggi probabilmente necessario, che Adolescence arriva a esercitare su ogni genitore: infilare il dito nella piaga di tutti i possibili sensi di colpa capaci di attraversare un padre e una madre contemporanei, terrorizzati dalla possibilità che il male possa entrare in casa propria senza bussare, pervasi dalla convinzione di essere soli nello sforzo quotidiano di provare a svolgere bene il proprio compito. Anzi: a dare “il meglio”. Eppure, la famiglia è probabilmente l’unica meritevole di umana assoluzione in un mondo che ha abdicato alla responsabilità della cura e dell’educazione, non solo dei propri figli, ma di tutti i suoi figli, e dove la bolla parallela e oscura dei social che animano gli smartphone ricorda tanto il Signore della notte del Cipì di Mario Lodi, l’uccello anziano e da tutti considerato saggio, che in realtà divora i raggi della luna, la luce e il futuro dei piccoli.
Tra le molte possibili frasi emblematiche, una centra benissimo questo aspetto della solitudine dei genitori, e a pronunciarla è il papà del giovane protagonista: «Mio padre mi ha cresciuto a cinghiate, io avrei voluto fare di meglio ». Già, ma cosa c’è tra le cinghiate e il meglio? Nessuno lo sa veramente, nella crisi dei punti di riferimento, non bastano certo le parole e il dialogo, e ascoltare gli esperti può essere disorientante quando attorno c’è un deserto. La violenza di Adolescence è mostrare la deriva possibile di una società in cui non esiste più una comunità educante. Per questo, accompagnati nella desolazione in tutta la sua aridità, abbiamo bisogno di parlarne. E allora facciamolo, ma anche per ricordarci che la vita reale non è solo buio, che nessun destino è preordinato, e che là fuori c’è molta più speranza di quanto una serie tv, di matrice anglosassone, possa raccontare. Consideriamolo un avvertimento, insomma.
L’analisi degli studenti, dalla fragilità al dialogo difficile in famiglia
DURA, VEROSIMILE, SENZA SPERANZA «ADOLESCENCE» VISTA DAI GIOVANI
«Non ero pronta a vedere una storia così violenta eppure così normale oggi. La necessità di sentirsi accettati non si nega e non è solo della mia generazione. Avere le proprie idee, diverse dagli altri, è difficile. Devi essere brava a scuola, educata, obbediente a casa, tra i compagni furba e vestita in un certo modo; devi piacere e condividere storie nel posto giusto. Senza uno di questi requisiti, la vita potrebbe diventare un inferno e per colpa dei social non c’è un posto dove nascondersi. Mi ha sconvolta l’incapacità del protagonista di capire che aveva un’altra scelta. Mi ha spaventato che nessuno abbia chiesto aiuto agli adulti e che essi siano così ciechi e sordi. Questa serie non dà speranze!».
Sono le parole di Ludovica, una delle alunne a cui ho chiesto pareri su Adolescence, e le fanno eco quelle altrettanto intense di Nina: «La serie purtroppo è più simile alla realtà di quanto si immagini. Un sistema in cui noi siamo chiuse in un mondo dove gli adulti non hanno il controllo che sono convinti di avere. Le caratteristiche principali che riconosco sono rabbia e paura, nella scuola sempre presenti; sappiamo che gli adulti “domineranno” o faranno di tutto per avere il controllo. Ma il nostro mondo ha un suo linguaggio, se vuoi farne parte, ci metterai tempo e impegno ». A lei si accorda con realismo Grazia: «Ciò che pensa la gente influisce tanto da dimenticare chi siamo, cosa vogliamo, portandoci ad inseguire l’irraggiungibile per essere accettati. Si ha paura di mostrare ciò che si è, benché originale; non è giusto dire che è colpa dei genitori se i figli non sono perfetti, siamo umani, è normale
sbagliare e rivalutarsi. Abbiamo libertà di scegliere i pensieri da nutrire e chi essere. Molto potremmo prendere per giustificare le nostre azioni, ma ci muovono le emozioni profonde, come la paura di chi non sa cos’è l’amore, ma siccome non vuole essere diverso, “segue la massa” rischiando».
In generale mi ha sorpreso che la maggior parte abbia visto la serie solo dopo il mio input, mentre di solito sono loro a consigliarmele, comunque immedesimandosi come Davide: « Ho sentito un senso di inquietudine, come fossi dentro la storia, incapace di staccarmi. Non è la classica serie da compagnia, scuote e costringe a pensare. Mi ha fatto provare un misto di rabbia e impotenza, perché ogni scelta sembrava vera e lasciava emozioni forti. A volte mi sono sentito a disagio, altre ho provato empatia, come se le paure fossero mie».
Ad un’altra Ludovica, invece, sono sorte delle domande: « La colpa è dei genitori che vedono in noi ciò che non siamo? Si è così o sviluppiamo aggressività per il bullismo? Da un lato i genitori devono dialogare con noi e conoscere la nostra sfera affettiva, dall’altro l’integrazione favorisce lo sviluppo, perché crea autostima».
Giovanni, invece, è stato colpito dal fatto che proprio un suo coetaneo, senza l’aiuto dei genitori, ammetta la colpa: « Avrebbe dovuto ricevere sostegno, ma è stato abbandonato. Inoltre, non si tenta di recuperarlo, si tende a punirlo, lasciandolo solo. Dovremmo poter comprendere gli errori, pagarne le conseguenze, ma anche riabilitarci».
Di famiglia parla pure Marco: « Il contrasto a casa riesce ad isolarci, facendoci sentire soli, impotenti uditori di liti tra adulti. Così giungono delle “consolazioni” che ci distruggono: droga, bullismo, alcool, azzardo, atti criminali. Mi fa riflettere la fragilità umana e la delicatezza dei rapporti».
Le voci convergono sulla fragilità dell’età: « L’adolescenza narrata è in linea – dice Flavia – sia per forma che per problematiche al periodo di debolezza di tutti noi. I problemi ci sembrano insormontabili ed è semplice perdere la testa. La parte aggressiva sfogata sui social si scontra con le paure della realtà. Gli adulti cercano di difenderci, comprenderci, a volte rendendosi oppressivi, perché noi non vediamo il loro aiuto».
Invece, per certi aspetti non si è riconosciuta in pieno nella narrazione Vittoria: « La serie si concentra eccessivamente sulla realtà anglosassone, tralasciando le peculiarità di altre realtà adolescenziali, tuttavia ho trovato il fenomeno della mascolinità tossica, la disperata ricerca di approvazione, seguita da insulti e aggressività. I ragazzi si mostrano irriverenti e incuranti delle conseguenze, come riscontro spesso nei miei coetanei. La figura adulta è rappresentata in tutta la sua estraneità al nostro mondo e linguaggio».
Poi c’è Sofia che spezza una lancia per l’adolescenza e per gli adulti: « Da un lato mi rivedo in dinamiche come la “pressione sociale” o l’isolamento emotivo, che possono portare a gesti estremi per i social che amplificano le insicurezze; dall’altro, ritengo questa rappresentazione esagerata o concentrata solo sugli aspetti negativi dell’adolescenza escludendone altri come le amicizie, la ricerca di sé o la crescita personale. Gli adulti vengono rappresentati incapaci di comprendere il mondo dei ragazzi o di riuscire a intervenire, ma non tutti sono “ciechi” nella realtà».





