
Guerra e filosofia: Galvano della Volpe, 1940
11 Luglio 2025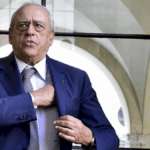
Monte dei Paschi, la Procura di Milano accelera: ascoltati i vertici di UniCredit e Mediobanca
11 Luglio 2025
Gli elementi architettonici e simbolici non sono meri supporti funzionali, ma contribuiscono alla celebrazione
Nella nostra lingua ‘avere luogo’ significa qualcosa come ‘accadere’. Non si dà niente in questo mondo che non sia situato, qui e non altrove, così e non altrimenti, adesso e non chissà quando. L’essere umano anzitutto, intrinsecamente legato a quell’aver luogo del ‘sé’ che è il ‘corpo’. Anche la grazia del divino, quando vuole toccarci in qualcosa di intimo come la vita, deve premurarsi di ‘avere luogo’, stare nei pressi dell’esistenza. Quanto questi temi riguardino l’‘incarnazione’ non deve certo essere spiegato a chi, gentilmente, vorrà leggere questo libro. La grazia di Dio è inseparabile dal ‘corpo’ in cui, una volta per tutte, ha avuto luogo, e nemmeno si rinnova senza animare i ‘corpi’ a cui continuamente si destina. Nasce da questo intreccio il primato che il rito cristiano assegna alla comunità che celebra, vero luogo del Risorto. Essa, del resto, si modella come sua vera presenza mediante segni/azioni che parimenti non si danno senza ‘avere luogo’. Gli spazi rituali sono nel cristianesimo divenuti relativi, ma non superflui. Non sono quindi la sostanza della liturgia, ma concorrono alla sua specifica qualità. Per questo vale la pena di assegnare loro pensiero e cura. Questo libro prova a ragionare su quegli elementi legati allo spazio che nella liturgia ‘danno luogo’ alla grazia. Sono i ‘luoghi della liturgia’. Il loro senso va strettamente connesso al loro esercizio. Non si tratta semplicemente di spiegare dei significati, ma di comprendere dei dinamismi. Uno spazio diventa veramente luogo solo perché la densità simbolica dell’azione può animarlo con tutta la sua sostanza. In questo, l’intensità dell’azione svolge un ruolo primario, ma la qualità dello spazio che la ospita ne condiziona molto le possibilità. Predisporre quindi la consistenza di un altare o di un ambone, dare forma a un’assemblea, disegnare luoghi di passaggio, illuminare lo spazio, e molte altre attenzioni di questo tipo non sono esercizi puramente ornamentali che si aggiungono come elementi di corredo alle ragioni funzionali del gesto. Conferire una forma adeguata a quei luoghi attiva già la sostanza non meramente operativa dell’azione che la liturgia rende viva. Non si tratta semplicemente di arredi. Ma di luoghi della presenza. Ho scelto di considerarne un elenco essenziale e saliente, cominciando dal corpo, primario luogo della liturgia, per esaminare temi classici come l’assemblea, l’altare, l’ambone, le soglie, il battistero, chiudendo la rassegna
con la questione della luce e quella delle immagini. L’accezione di ‘luogo’ è quindi qui estensiva, non limitata al mero elemento costruttivo. Nel merito di ognuno di essi mi è sembrato utile, ogni volta possibile e nella misura del dovuto, attraversare sommariamente la storia che, come sempre, vale anche quale indice della loro evoluzione teologica. Tratteggiare i vari modelli storici di uno o dell’altro dei luoghi della liturgia serve già a mettere a fuoco la densità del senso che essi portano con sé. La tradizione, del resto, non procede avvicendando significati che si sostituiscono uno con l’altro, ma distillando forme di senso che mutano per mantenersi fedeli al loro principio. La storia, quindi, mentre documenta quello che cambia, testimonia quello che perdura. Nel contempo il libro ha la modesta ambizione di essere un piccolo manuale didattico per il presente. Il senso teologico dei luoghi della liturgia si congiunge sempre con l’esercizio pratico della loro ideazione materiale. Si tratta di un passaggio che non è sempre il luogo della coerenza e della linearità, che spesso resta puro terreno di un’improvvisazione cui manca coscienza del tema: a questo il libro cerca di essere un aiuto. Ma non di rado quel passaggio è anche frontiera di un ‘conflitto delle interpretazioni’ che ha occupato, con fin troppa animosità, la nostra vita di Chiesa. Su questo non voglio pesare con ragioni aggiuntive, benché sia inevitabile portare, nella visione generale delle questioni trattate, un punto di vista che spero sia il più coerente possibile al senso di una riforma liturgica ancora in attesa di una comprensione adeguata alle intenzioni. L’insieme del discorso che compone il libro resta mol-to condizionato dal dovere di sintesi della pubblicazione. Molte questioni avrebbero certamente meritato, per risultare più perspicue e non rischiare equivoci, una maggiore ampiezza di argomenti, in qualche caso anche una serie di precisazioni. Spero quantomeno che la sintesi possa non apparire mai sommarietà. Il lettore capirà certamente i limiti di questo lavoro. Come, mi piace credere, anche le qualità. Ma un ultimo pensiero deve doverosamente accompagnare i contenuti che sono esposti in questo manualetto. Non mi sfugge la relatività dei temi che qui espongo rispetto a una vita di Chiesa che ha effettivamente questioni più grandi a cui pensare. Mi sento anche perfettamente cosciente di quella ‘verità’ del celebrare cristiano che resta viva anche quando è senza qualità e semplicemente consegnata all’immediatezza della spontaneità. Ho il vivo ricordo di messe celebrate sulle Ande boliviane, in chiesette fatte con mattoni di fango, con un tavolo per altare, e il catechista in piedi col libro che legge la Scrittura, mentre qualche donna seduta per terra allatta il suo bambino. Questa immagine riempie ancora il mio cuore. Ho precisa coscienza del fatto che nelle nostre liturgie il Signore ‘si presenta’ all’appuntamento anche quando le nostre tavole non sono proprio così ricche, il nostro arredamento non sempre di qualità, e persino il nostro cuore non del tutto presente. Ma una tale incondizionatezza non merita la nostra indifferenza, tantomeno autorizza all’incuria. Il fatto che il Signore accetti volentieri di mangiare con noi anche seduto su uno sgabello in un luogo di fortuna, non significa che, potendo, non ci si debba mettere a tavola con lui con quell’eleganza che meritano i nostri sentimenti più veri, senza per questo farne un ossessivo estetismo. A Marta Gesù rimprovera di occuparsi troppo dell’ordine, ma se Maria può ascoltarlo con tanto trasporto è anche perché ha trovato una casa pulita. Certi incontri, come anche quello che si realizza nella liturgia, sono ‘veri’ a prescindere, ma alla loro verità concorre sempre anche una ‘cura’ che è già traccia del loro accadere. È solo per dire che si può, e si deve, prendere sul serio anche ciò che non sembra dirimente. Poveri ma belli, si diceva una volta.





