
Ragionare con Carlo Nepi. Per una visione esigente e responsabile del Santa Maria della Scala
18 Novembre 2025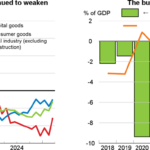
DIGEST STRATEGICO – Mercoledì 19 novembre 2025
19 Novembre 2025
C’è un paradosso irresistibile nella politica italiana: il fascismo è “finito”, il comunismo no. Anzi, prospera. Non nei partiti, non nella società, non nei programmi politici: prospera nella destra. È diventato il suo carburante simbolico, un feticcio retorico sempre pronto, una reliquia narrativa che risolve ogni imbarazzo.
A custodirlo non sono eredi di Marx, ma tre figure inattese: Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni, Gennaro Sangiuliano.
Tre personalità diversissime, legate da un’unica straordinaria abilità: tenere in vita un comunismo che non esiste più, precisamente perché serve così com’è — immaginario.
Berlusconi è stato il grande inventore del comunismo immaginario. Per decenni ha adoperato un’ideologia ormai priva di presa reale sulla società come principio esplicativo di tutto: avversari politici, magistrati, giornalisti, perfino la meteorologia. È riuscito dove nessun partito aveva osato: trasformare il comunismo in un’entità metastorica, un eterno presente buono per ogni narrazione.
Meloni ne ha raccolto l’eredità e l’ha portata nell’era del marketing politico. Ha fatto del “comunista” una categoria elastica: la applichi a chiunque non rientri nel racconto dominante. Diritti, redistribuzione, salario minimo, dissenso critico, sindacati, pioggia fuori stagione: tutto può essere comunista. È un sistema di segnaletica ideologica: un cartello di divieto che evita l’obbligo di discutere.
Sangiuliano, da ministro della Cultura, ha compiuto un passo ulteriore: ha trasformato il comunismo in un’estetica. Non è più una posizione politica, ma un modo di essere. Una postura mentale. Una categoria antropologica. Un’etichetta da applicare ai comportamenti, ai gusti, perfino all’immaginario. La cultura si riduce così a gesto di appartenenza: noi contro “i comunisti”, comunque definiti.
E i comunisti veri?
Nessuna traccia. Non c’è un soggetto politico, non c’è un radicamento sociale, non c’è una progettualità. Ma non importa: nel linguaggio della destra il comunismo non deve esistere, deve apparire. Serve a riempire il vuoto della politica concreta: salari fermi, sanità esausta, scuola precaria, territori dimenticati. Meglio un nemico immaginario che affrontare la realtà.
Il comunismo, oggi, è uno strumento:un effetto speciale, un diversivo, un riflesso condizionato. Una tecnologia del consenso, non un’ideologia. Per questo il paradosso è tragico e comico insieme: i veri teorici del comunismo contemporaneo non sono quelli che lo studiano o lo rivendicano, ma quelli che lo agitano senza crederci.
Sono loro che gli danno forma, ruolo e funzione. Senza di loro, il comunismo odierno non esisterebbe nemmeno come fantasma linguistico. Il risultato è un discorso pubblico impoverito, infantilizzato, in cui la politica rinuncia alla complessità preferendo la tifoseria.In cui il salto sostituisce il pensiero.In cui l’insulto rimpiazza l’argomento. In cui la memoria storica diventa attrezzeria. Forse sarebbe il momento di archiviare davvero questo comunismo immaginario.Non negli archivi di Stato: ci è già.
Ma nel linguaggio politico, dove da troppo tempo funziona come scorciatoia, come riflesso, come strumento per evitare il vero nodo: misurarsi con la realtà. Perché un Paese che continua a parlare di comunismo per non parlare di sé non si limita a semplificare il dibattito: rinuncia alla propria maturità democratica.
E la democrazia, senza adulti in stanza, semplicemente si assottiglia.





