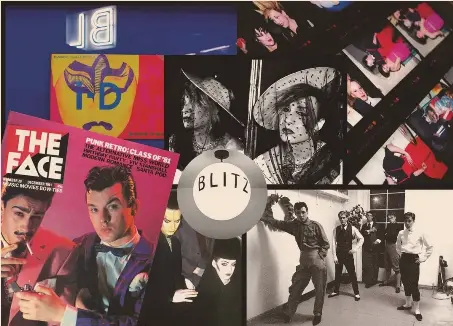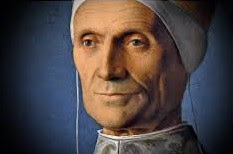All’s Fair review – Kim Kardashian’s divorce drama is fascinatingly, existentially terrible
23 Novembre 2025
Céline, non Proust è lui il padre di Fratelli d’Italia
23 Novembre 2025I lavori di restauro e pulizia appena conclusi al portale della sacrestia meridionale del Duomo di Milano rivelano una sorpresa. Che riguarda anche Petrarca e il neoplatonismo
riappaiono dopo sei secoli
di Gianni Santucci
La «Vergine dei ragni» è rimasta segreta per seicento anni. Anche se è sempre stata lì: Duomo di Milano, a destra dell’altare, scolpita in maestose scene sul portale della sacrestia meridionale. Un mastodontico presepio di marmo. Iper-affollato d’angeli. Super-popolato di nobili. Lo terminò nel 1396 il maestro teutonico Hans von Fernach (l’edificazione della cattedrale era iniziata da soli dieci anni). Al centro dell’altorilievo, le vesti di Maria modellate nella pietra. Il panneggio, in origine, sfavillava d’oro. Un solo motivo decorava la gonna della madonna. Ragnatele. E ragni. Non s’era mai vista prima, e mai s’è vista dopo (le ricerche sono state estese a pitture, affreschi, miniature, codici medievali di tutta Europa) una madre di Gesù impreziosita di ragni. Gli aracnidi, già da secoli, erano un oscuro simbolo. Nella Milano di fine Trecento si sovraccaricarono di potenza allegorica. Ai piedi della scultura si sistemavano però gli incensi. S’accendevano le candele. Così, ininterrottamente, liturgia dopo liturgia, su quel marmo si sono accumulate grasse polveri e cupe fuliggini. Una spessa coltre di sporco ha obliato le ragnatele d’oro: per sei secoli. Fino a un pomeriggio dello scorso anno.
I restauri ordinati dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano erano iniziati nel 2023. Un giorno, sui ponteggi davanti al portale della sacrestia, faccia a faccia con la scultura in fase di ripulitura, s’è svolto un conciliabolo. I restauratori (Marilena Anzani e Alfiero Rabbolini) hanno timidamente sussurrato: «Strano, molto strano, ma sembrano…». Questo è il racconto della (ri)scoperta della «Vergine dei ragni», nella voce di Elisa Mantia, storica dell’arte e coordinatrice dell’area cultura della Veneranda Fabbrica: «Questa splendida scultura, insieme alla “gemella” che sormonta la sacrestia settentrionale, appartiene alla parte veramente originaria del Duomo. Fu collocata quando quell’area era ancora un cantiere. Un’opera meravigliosa tra la polvere e le maestranze al lavoro. Le mura dell’abside erano in costruzione in uno spazio vuoto intorno alla precedente basilica di Santa Maria Maggiore. Per lungo tempo le sculture restarono all’aperto, riparate da tettoie o tetti di fortuna. Sapevamo che in origine il marmo era colorato, ma mai avremmo immaginato l’abbondanza e l’esuberanza della decorazione di cui abbiamo trovato le tracce. Uno stupore enorme. Il fondo di alcune scene azzurro, gli occhi delle figure in nero, l’incarnato roseo, le foglie in alternanza verdi e rosse. Una straordinaria ricchezza di dettagli impreziosiva l’opera. E soprattutto l’oro, dominante, steso a punta di pennello. Erano in oro i capelli di tutte le figure, tutte le vesti, i bottoni, le cinture, le nervature delle foglie; il manto del bue e dell’asino nell’adorazione; in oro le vergini sagge, mentre le stolte avevano le vesti nere. E ancora in oro erano le partiture architettoniche, le volte, anche nelle storie laterali, e anche in punti dove non sarebbe mai stato visto, come nel retro delle teste. Come fosse una maestosa gioielleria, con un effetto visivo potentissimo. Questo dà la misura di una ricchezza anche economica. Il restauro ci dà una consapevolezza nuova del Duomo delle origini: tutti abbiamo negli occhi il bianco del marmo di Candoglia, ma le prime menti che realizzavano e decoravano la cattedrale non disdegnavano una ricchezza decorativa opulenta anche nel colore». Ultimi, dalle rimosse polveri, son venuti fuori i ragni.
Laura Paola Gnaccolini, storico dell’arte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Milano, ha lavorato mesi per decodificare il valore simbolico dei ragni: «Apparivano sulle vesti della Madonna in tutte le porzioni centrali dell’opera, non potevano essere un divertissement del miniatore. Abbiamo cercato modelli iconografici, senza trovarli. Il soggetto sembrava più adatto a un codice miniato, ma non è emerso alcun altro riferimento figurativo. Quei ragni sembravano un unicum. Abbiamo avuto così la certezza di dover cercare una fonte letteraria. Guglielmo di Conches, grande studioso della scuola di Chartres, nel XII secolo, era tra i sostenitori dell’identificazione dell’anima mundi con lo Spirito Santo. Una tappa del secolare lavoro di conciliazione tra neoplatonismo e cristianesimo. Un allievo di Guglielmo, Hisdosus, che condivideva le idee del maestro, ampliò una catena di complessi rimandi: l’anima mundi, Spirito santo, amore eterno del Creatore, è anche una sorta di vigor naturalis che agisce in tutto l’universo. Dove si colloca? Tra le varie spiegazioni, Hisdosus predilige la posizione in mundi medietate, nel sole, cuore del mondo. Come l’anima umana ha sede nel cuore, da dove infonde le forze alle membra, così l’anima mundi dal sole irradia il vigor naturalis a tutto il creato. Questo parallelismo viene rafforzato da un paragone che Hisdosus dice di aver trovato in Eraclito: l’anima dell’uomo, nel cuore, ha col corpo un rapporto analogo a quello del ragno con la tela. Ecco chiusa la possibile catena di rimandi dietro i ragni sulle vesti di Maria. È l’incredibile testimonianza di come, già alla fine del Trecento, nella corte di Gian Galeazzo Visconti questi ideali erano condivisi. Milano era un’avanguardia nel recupero del platonismo che si avrà con l’umanesimo. Dietro c’era Petrarca, e la sua venerazione per Platone che aveva lasciato in eredità a Milano».