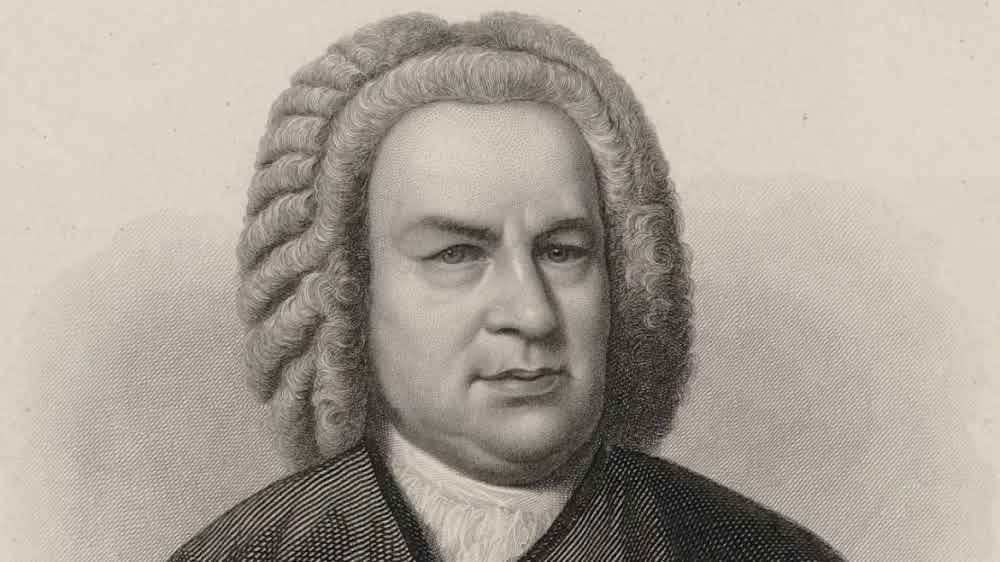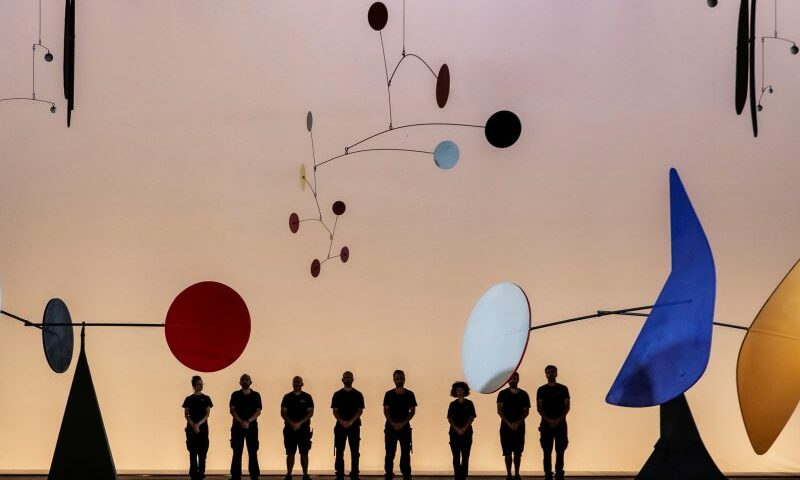«Diaspora» è parola antica. Ed è, in italiano, parola rara. Non viene mai usata, per quanto ne so, fino al pieno Ottocento. Anche le versioni riformate del Nuovo Testamento, quando la trovano in greco, preferiscono tradurla con “dispersione”. Così l’inizio della lettera di Giacomo, indirizzata «alle dodici tribù della diaspora», viene reso da Massimo Teofilo Masi, nel 1551, con «le dodici tribù che sono in dispersione». Il Grande dizionario del Battaglia dà come prima attestazione I testimoni della passione di Giovanni Papini, pubblicato nell’anno di disgrazia 1938, e di rancoroso accento antigiudaico: «in quel bailamme di giudei della diaspora [Simone] si trovava più a suo agio che nella città del Tempio». Eppure, diaspora è oggi, nel linguaggio politico e sociologico, molto più di una semplice “dispersione”. È rete di relazioni, progetto di sopravvivenza, contropotere. La svolta degli anni 80 e 90 del secolo scorso, con l’affacciarsi della globalizzazione, ha dato nuova linfa alla tradizionale esperienza giudaica di comunità sparsa ma coesa, di spazio-destino che, nonostante tutto, attraversa il tempo senza esserne dilavato e cancellato.
Se l’ebraismo resta un laboratorio privilegiato per studiare la diaspora storica (e quella metastorica), le vite di molti di noi si sono trasformate in cammini dispersi, riaggregati, di nuovo dispersi. Destini mobili, incostanti, transazionali o, per dirla con Paolo Jedlowski e Massimo Cerulo, “spaesati”. Nel senso di “senza paese”, o almeno con più paesi a cui guardare e nessuno di cui sentirsi figli esclusivi.
Sociologi accademici per professione, mobili per necessità e per vocazione, i due autori non appartengono solo a due generazioni differenti. Sono anche diversamente presi dal mulinello delle dislocazioni. Da Nord a Sud della Penisola si muove Jedlowski, milanese assoldato dall’Università della Calabria, mentre in senso inverso macina chilometri Cerulo, nato a Cosenza.
«Cosa significa lasciare il luogo in cui siamo cresciuti? Chi diventiamo? Com’è spostarsi, e magari vivere regolarmente fra più luoghi, paesi, persone? Esistono identità senza dimora?».
Una cosa è rispondere a tavolino. Tutt’altra faccenda è agguantare un treno, anzi viverci, in treno o in aereo, provare a smaltire la nostalgia, oppure immedesimarsi nella nuova simil-patria, sempre pronta a sgretolarsi al prossimo rientro. Cerulo parla di “spartenze”, per metter assieme due sofferenze.
Quella di chi parte, lasciando la propria terra, «e quella di coloro che accompagnano il partente, affidandolo al suo destino e piangendone l’assenza». E se non c’è nessuno ad accompagnarci? Oppure, caso ancora più estremo, ed estremamente ebraico, se ritornare non sarà possibile, e nemmeno pensabile? Tra le storie di mobilità esasperata affiora il tema dell’esilio, come forma ultima, e definitiva, di perdita. «Quanti in Italia, in Europa, nel mondo, sono eredi di un esilio?», si chiede Jedlowski, a sua volta figlio di un esiliato. Nell’impossibilità di ritornare sui propri passi sta una delle differenze salienti tra le esperienze di spaesamento, esplorate con acutezza e brio in questo volume, e l’antica diaspora ebraica. Senza ritorno, il viaggio di Ulisse, pur così tortuoso e labirintico, parrebbe vano, insensato. Eppure, la diaspora ebraica non si è mai abbandonata alla disperazione. La ragione? Quando il ritorno al passato è irrealizzabile, spetta al futuro servire da patria e da casa. Di tutti i ritorni impraticabili, il tempo messianico, vicinissimo e sfuggente, è forse il più efficace.
Paolo Jedlowski e Massimo Cerulo
Spaesati. Partire, tornare
tra Nord e Sud Italia
il Mulino, pagg. 224, € 18