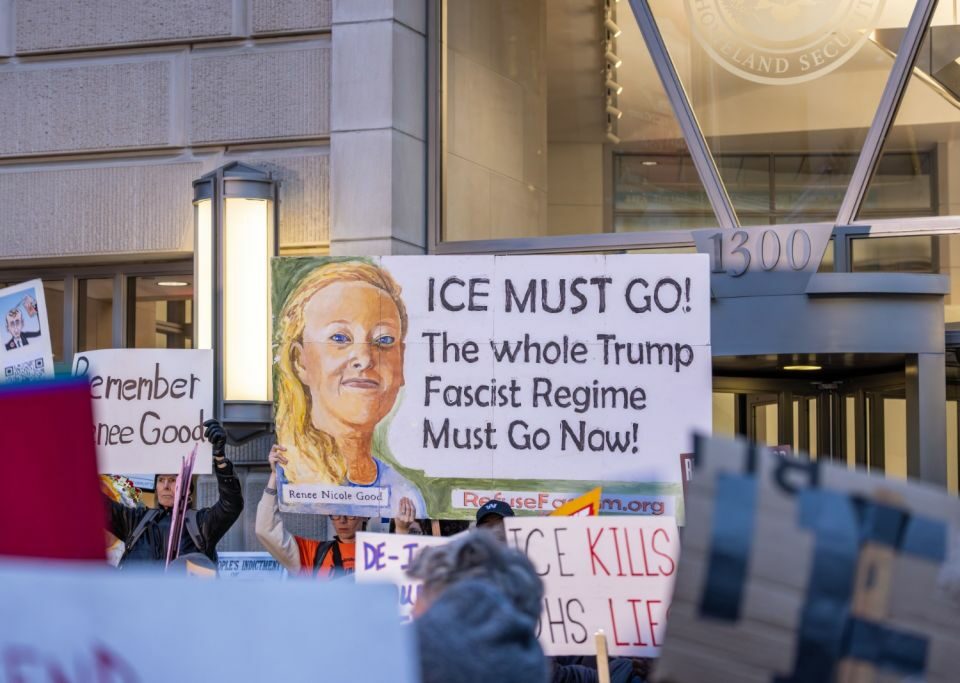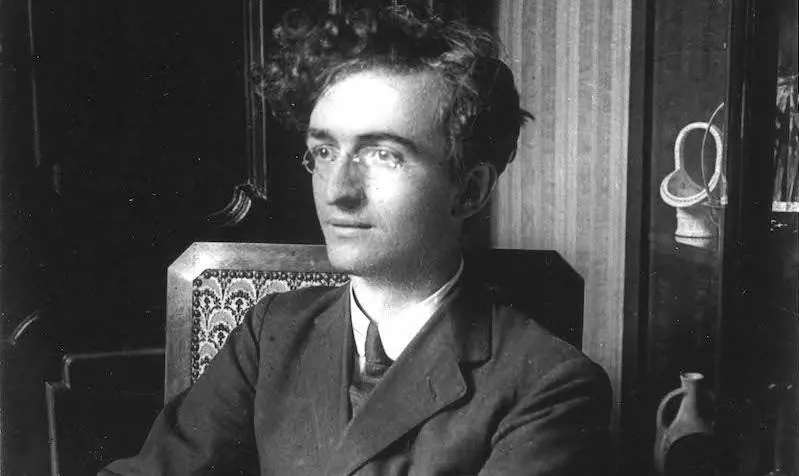Noialtri girardiani
9 Novembre 2025
DIGEST STRATEGICO – Lunedì 10 novembre 2025
10 Novembre 2025
C’è una fede che non nasce dal mistero, ma dall’identità. Una fede senza silenzio, fatta di slogan e di certezze, dove Dio non è un invito alla conversione ma il marchio di appartenenza a una comunità che si sente eletta. È la fede dell’America di Donald Trump, un cristianesimo piegato alla logica del potere, in cui la grazia si misura in termini di successo e la benedizione coincide con la vittoria.
In questa visione del mondo, la religione non chiede più di credere ma di vincere. Il fallimento non è più la condizione umana, ma la prova di una fede insufficiente. È la logica della teologia della prosperità: chi è ricco lo è perché ha creduto abbastanza; chi è povero, perché non lo ha fatto. La fede diventa così una meritocrazia spirituale.
Simone Weil scriveva che “la grazia non discende mai su coloro che hanno il diritto di riceverla”, ma su chi resta aperto al dono. In questa teologia rovesciata, il dono scompare e lascia il posto al premio. La fede non libera, giustifica; non apre, distingue.
Donald Trump ha compreso la forza politica di questa religione del successo. In un’epoca di solitudine e paura, ha trasformato la fede in un linguaggio di potere: Dio come garante dell’ordine, la famiglia come confine, la ricchezza come segno di elezione. La dimensione spirituale diventa funzionale alla costruzione di un’identità nazionale. In questo schema non c’è spazio per gli ultimi, perché la debolezza non redime: condanna.
Jean-Luc Marion ha mostrato come l’idolo sia l’immagine che satura lo sguardo, che non rinvia a nulla di invisibile. Lì dove la fede dovrebbe indicare un’assenza, l’idolo occupa tutto lo spazio. Il leader diventa la figura che prende il posto del divino, una presenza totale che non lascia più distanza. È la fede ridotta a immagine, in cui il potere si fa oggetto di adorazione.
Kierkegaard direbbe che è la perdita del paradosso: la fede che non trema, che non conosce l’angoscia, che non contempla l’impossibile. Una fede che si esaurisce nella sicurezza, e per questo non salva più nessuno.
Trump ha costruito una liturgia politica fatta di gesti, parole e immagini che imitano la religione. Il comizio è una messa laica, la folla una congregazione, la promessa di salvezza un contratto. In questa dimensione, il linguaggio religioso non è più simbolico: è letterale. Dio non è più il nome dell’Altro, ma il riflesso dell’io.
Walter Benjamin avrebbe parlato di “religione della merce”, in cui il sacro è consumato come ogni altro bene. L’esperienza spirituale si riduce a segno di riconoscimento, un marchio di appartenenza al popolo dei vincenti.
La logica della fede si rovescia: ciò che dovrebbe essere gratuito diventa utile, ciò che dovrebbe disarmare diventa strumento. La preghiera si fa slogan, il mistero diventa pubblicità. È la fede del presente assoluto, senza memoria né attesa, dove tutto accade subito. Non c’è più il tempo del silenzio, dell’ascolto, del dubbio: ogni parola deve produrre effetto, ogni promessa deve apparire vera.
Bonhoeffer, scrivendo dalla prigione, metteva in guardia contro la “grazia a buon mercato”, quella che consola senza trasformare. È esattamente questa la fede del potere: una grazia che non chiede nulla, che non cambia nulla, ma conferma l’ordine esistente. Una fede che serve a tranquillizzare, non a liberare.
Il rischio è che, in nome di Dio, si adori solo la forza. Ma il cristianesimo, nella sua origine più profonda, nasce come scandalo: la croce è il rifiuto della logica del successo, l’accettazione del limite come via di verità.
Credere, in questo senso, significa accettare di non possedere. È un atto di libertà, non di appartenenza. Marion direbbe che la fede autentica è risposta a un dono che non si può trattenere: qualcosa ci attraversa, ci eccede, e ci lascia esposti. È il contrario della fede dei vincenti, che si chiude in se stessa, che teme la vulnerabilità e nega l’alterità.
La sfida del nostro tempo non è scegliere tra fede e laicità, ma tra una fede che apre e una che chiude. Tra una religione del potere e una del dono. Tra il Dio che premia e il Dio che salva.
Tornare a credere, oggi, significa accettare il silenzio, la distanza, il dubbio. Significa riconoscere che la verità non si mostra nei palazzi del potere, ma nella fragilità di chi non ha nulla da difendere.
Solo una fede che conosce la mancanza può ancora parlare all’uomo contemporaneo. Tutto il resto è propaganda travestita da preghiera.