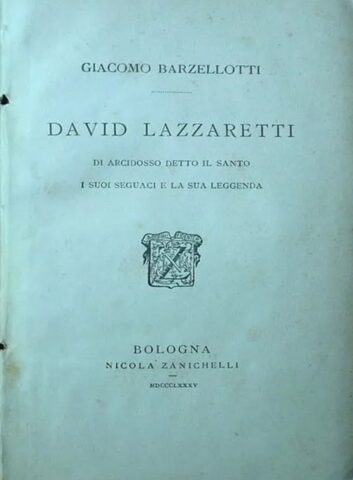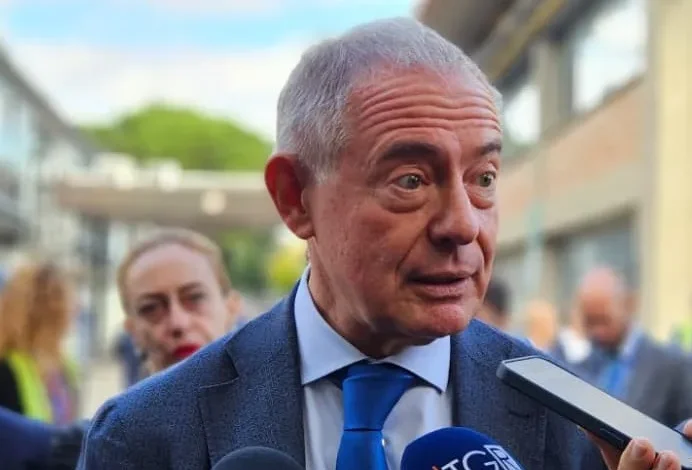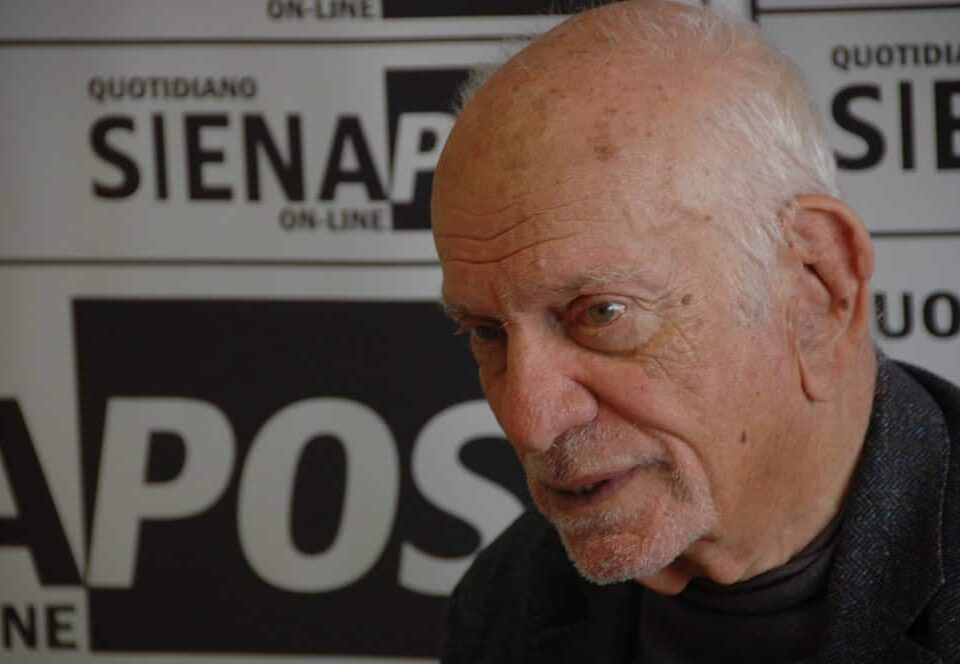U2 – With Or Without You
13 Novembre 2025
Piancastagnaio. Nella rocca medievale sul Monte Amiata si fanno mostre d’arte contemporanea (il curatore è giovanissimo)
13 Novembre 2025
Quando si torna per morire nel luogo dove si è sbagliato
di pierluigi piccini
Settembre 1917. Piancastagnaio.
 Giacomo Barzellotti ha settantatré anni. Senatore del Regno, accademico dei Lincei, professore emerito di filosofia morale all’Università di Roma. Potrebbe morire nella capitale, circondato dagli onori di una carriera compiuta. Invece torna qui, in questo borgo dell’Amiata che lo ha visto nascere.
Giacomo Barzellotti ha settantatré anni. Senatore del Regno, accademico dei Lincei, professore emerito di filosofia morale all’Università di Roma. Potrebbe morire nella capitale, circondato dagli onori di una carriera compiuta. Invece torna qui, in questo borgo dell’Amiata che lo ha visto nascere.
Non è una visita. È un ritorno definitivo.
Chi ha costruito una vita altrove, chi ha accumulato titoli e riconoscimenti lontano dal luogo d’origine, non torna per morire dove è nato. Si muore dove si è riusciti. Dove il nome ha peso. Dove la carriera trova la sua consacrazione finale.
Invece Barzellotti sceglie di scendere. Di tornare indietro. Di chiudere il cerchio non nell’apice, ma nel punto di partenza.
C’è qualcosa in questo gesto che va oltre la nostalgia. C’è una comprensione tardiva. Una resa dei conti silenziosa.
L’errore del 1878
Trentanove anni prima, agosto 1878.
Un carrettiere di Arcidosso, Davide Lazzaretti, aveva dato vita sul Monte Labbro a una comunità che metteva in discussione tutto: lo Stato unitario, l’economia monetaria, la proprietà privata, la gerarchia ecclesiastica. Contadini che condividevano lavoro, beni, preghiera. Un esperimento sociale e religioso che interrogava le fondamenta stesse della modernità nascente.
Il 18 agosto, scendendo in processione verso Arcidosso, Lazzaretti viene ucciso da un colpo di fucile. Davanti ai suoi seguaci. Un’esecuzione di Stato.
Il giovane Barzellotti, trentaquattro anni, decide di studiare il caso. Pubblica un volume: Davide Lazzaretti. Opera ricca di dati, testimonianze, fonti. Un lavoro serio, documentato, rispettoso nei modi.
Eppure profondamente sbagliato.
Lazzaretti vi appare come un soggetto da spiegare: psicologia deviante, influenze culturali confuse, arretratezza dell’ambiente montano. Un fenomeno da interpretare. Non un interlocutore da ascoltare. Non un profeta da prendere sul serio.
Quello che Barzellotti non prende mai in considerazione è la domanda che avrebbe cambiato tutto:
E se Lazzaretti avesse intravisto una verità che la modernità non riusciva a vedere?
Si può non vedere. Si può essere intelligenti, onesti, ben informati, e non vedere. Non per malafede. Per posizione. Per il punto in cui si sta. Per il riccio che ancora non è caduto.
 Gramsci e la verità nascosta
Gramsci e la verità nascosta
Dal carcere fascista, mezzo secolo dopo, Antonio Gramsci individua con precisione chirurgica ciò che non funziona nel libro:
«Il Barzellotti ridusse un moto popolare a fenomeno locale, per non vedere il malessere che attraversava l’Italia dopo il 1870.»
Non accusa Barzellotti di mentire. Lo accusa di restringere. Di rendere marginale ciò che è strutturale. Di trasformare ciò che è politico in anomalia psicologica. Di ridurre un grido collettivo a stranezza locale.
Eppure un dato resta: se Lazzaretti fosse stato davvero un visionario isolato, lo Stato avrebbe potuto ignorarlo. Internarlo, al massimo.
Invece lo uccide. In pubblico. Con premeditazione.
Questo significa che la sua predicazione aveva intercettato qualcosa di reale: nuove tasse che soffocavano i contadini, leva obbligatoria che strappava i figli alla terra, precarietà diffusa, promesse di progresso tradite. La modernità che avanzava lasciando macerie.
Lazzaretti non era un folle. Era un interprete radicale della crisi. Uno che aveva capito, prima degli altri, che qualcosa non tornava nella narrazione del progresso.
Barzellotti, nel 1878, non poteva vederlo. Troppo dentro. Troppo investito. Troppo protetto dal guscio delle istituzioni che lo accoglievano.
La contraddizione interna
La cosa più dolorosa è che Barzellotti, nei suoi scritti, mostra altrove una sottigliezza di pensiero che, applicata a Lazzaretti, avrebbe cambiato tutto.
Sostiene che la religione ha forza perché parla al sentimento e all’immaginazione, non solo all’intelletto. Che la critica non deve essere “dissezione anatomica” ma evocazione: deve far rivivere ciò che analizza, entrare nella logica interna di ciò che studia.
Ma davanti a Lazzaretti non riesce a essere evocativo. Scivola nella spiegazione. Resta fuori.
Perché?
Perché Lazzaretti era vivo, contemporaneo, destabilizzante. Riconoscerne la portata avrebbe significato mettere in questione lo Stato, il suo ordine, la legittimità stessa del mondo che stava trionfando.
Solo la distanza del tempo avrebbe potuto aprire quello spazio di comprensione.
Ma a volte la distanza non basta. Serve anche qualcos’altro.
L’Europa in fiamme
- 1917.
L’Europa è un cimitero industriale.
La scienza, promessa di emancipazione, ha prodotto gas asfissianti, artiglieria a lunga gittata, distruzione meccanizzata. Lo Stato-nazione ha mandato milioni di contadini al fronte senza che sapessero perché. L’economia del progresso si è rivelata incapace di proteggere la vita.
Barzellotti osserva tutto questo da intellettuale e da senatore. Ha settantatré anni. L’età in cui il corpo comincia a parlare più forte delle idee. L’età in cui si capisce che il tempo non è infinito e che alcune cose non potranno più essere dette.
E forse — non lo sapremo mai con certezza — comprende finalmente ciò che nel 1878 gli era sfuggito.
Che la piccola comunità del Monte Labbro non era arretratezza, ma un tentativo di inventare un’altra forma di vita.
Che ciò che sembrava follia era, in controluce, una critica della modernità nascente.
Che Lazzaretti aveva visto qualcosa che lui, Barzellotti, con tutti i suoi libri e le sue cattedre, non aveva saputo vedere.
Nel 1917 questa intuizione è possibile. Nel 1878 no.
Ma nel 1917 non c’è più tempo per scrivere un nuovo libro. Non c’è più tempo per correggere. Non c’è più tempo per prendere pubblicamente la parola e dire: ho sbagliato.
Il linguaggio accademico, d’altronde, non potrebbe comunque esprimere ciò che la realtà storica ormai impone.
Resta un gesto.
Il gesto del ritorno
Tornare.
Tornare al luogo dove tutto era iniziato. Tornare alla terra dell’infanzia e dell’errore. Tornare per morire non dove si è riusciti, ma dove non si è capito.
È un gesto contro-moderno.
Rovescia l’idea lineare del tempo: carriera, ascesa, accumulo, gloria. Affidandosi invece a un tempo ciclico: cadere, tornare, aprirsi.
Morire a Roma avrebbe confermato la narrazione del successo. Morire a Piancastagnaio la smentisce con un silenzio.
Non è pentimento. Non è nostalgia. Non è nemmeno, propriamente, un ritorno alle origini.
È il riconoscimento che la vita vera non stava dove pensavi di costruirla. Che l’errore fondamentale non era un dettaglio da correggere, ma una cecità da confessare.
E che l’unico modo per confessarlo, quando le parole non bastano più, è tornare. Fisicamente. Con il corpo. E aspettare.
Il riccio del castagno
Il riccio protegge il frutto, ma per aprirsi deve cadere dall’albero, toccare terra, seccarsi. Solo allora la castagna si libera.
La carriera di Barzellotti — i suoi titoli, le sue istituzioni, la sua filosofia accademica — è stata la scorza: dura, necessaria, protettiva. Dentro c’era, forse da sempre, un’intuizione più profonda che non riusciva a esprimersi. Un dubbio non formulabile. Una verità non dicibile.
Il ritorno del 1917 è la caduta del riccio.
Non servono più parole. Non servono libri. Non serve correggere l’opera del 1878.
Il gesto basta.
Tornare è già dire tutto.
Noi, nel 2025
Questa storia non è archeologia.
Viviamo in un sistema economico e tecnologico che consuma risorse più velocemente di quanto la terra possa rigenerarle. La modernità lineare — crescita infinita, accumulo, competizione, sfruttamento — è in crisi terminale. Lo sappiamo. Eppure continuiamo.
E come Barzellotti nel 1878, siamo talmente immersi in questo modello da faticare a vedere le alternative. Da ridurle a utopie, follie, arretratezze.
Eppure le alternative esistono. Sono qui. Sono sempre state qui.
Non bisogna inventarle. Bisogna smettere di non vederle.
Comunità che si riprendono cura dei beni comuni. Economie che chiudono i cicli invece di produrre rifiuti. Territori che ricostruiscono filiere corte. Persone che scelgono di cooperare invece di competere.
Non è tornare al passato. È tornare alle domande fondamentali.
Come si vive senza consumare il futuro?
Come si costruisce comunità, non isolamento?
Come si riconosce valore nella cura, non nell’accumulo?
Nel 1878 Barzellotti non le comprese. Nel 1917 tornò per confessarlo senza parole.
Noi possiamo farlo prima. Senza aspettare il crollo. Senza aspettare i settantatré anni.
Ma se li abbiamo, i settantatré anni, e se torniamo — se scegliamo di tornare — allora quel gesto ha un peso diverso.
Non è fuga. Non è sconfitta. Non è nemmeno, semplicemente, saggezza.
È il riconoscimento che il sapere vero non sta nel continuare a salire.
Sta nel saper scendere.
L’ultimo gesto
Il 19 settembre 1917 Giacomo Barzellotti muore a Piancastagnaio.
Un filosofo dimenticato in un borgo marginale.
Nessun funerale di Stato. Nessuna commemorazione accademica. Nessun discorso ufficiale.
Solo la terra che riprende ciò che è suo.
Ma in quel ritorno finale, più eloquente di qualsiasi trattato, c’è un’intelligenza che nessun libro avrebbe potuto esprimere.
Dopo una vita trascorsa a salire — Firenze, Pavia, Napoli, Roma — Barzellotti sceglie di scendere.
Torna nel punto d’origine. Torna alla terra. Torna per aprire, finalmente, la scorza.
E in quel silenzio, che è l’unico linguaggio rimasto, sembra dirci:
Il vero sapere non è sapere tutto.
È saper tornare.
Tornare alle domande che avevi messo da parte.
Tornare ai luoghi che ti hanno formato e che hai tradito.
Tornare alla terra prima che sia troppo tardi.
Tornare per far cadere, finalmente, il riccio.
E lasciare che qualcun altro — forse — raccolga il frutto.
(1- continua)