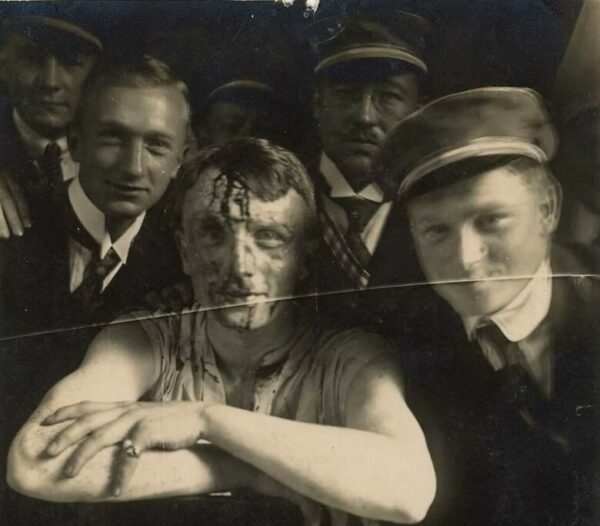La Toscana del Sud non finisce a Colle
14 Novembre 2025
CHE SIGNIFICA TORNARE OGGI (PER NOI, QUI)
14 Novembre 2025Il Santa Maria e la sua ombra. Quando l’arte diventa decorazione dell’identità
Venticinque opere della pittrice romena Teodora Axente compongono la mostra Metamorfosi del Sacro, allestita al sesto piano del Santa Maria della Scala. Curata da Riccardo Freddo e Michela Eremita, da un’idea di Cristiano Leone, l’esposizione nasce con l’intento dichiarato di riportare al Santa Maria le opere che l’artista ha concepito proprio in questo spazio. Eppure, più che un dialogo con il luogo, ciò che emerge è una nuova tappa del processo di normalizzazione estetica che sembra ormai caratterizzare le scelte del complesso museale senese.
Axente, una delle voci più note della cosiddetta scuola di Cluj, appartiene a quella generazione di pittori che, dagli anni Duemila, hanno trasformato la figurazione post-socialista in linguaggio di successo internazionale: elegante, introspettivo, ambivalente ma perfettamente compatibile con i circuiti del mercato. In questa mostra, però, di quell’ambiguità resta poco. Il sacro diventa simbolo estetico, il trauma memoria levigata, il corpo figura contemplativa. Tutto è bello, equilibrato, rassicurante.
Laddove la pittura di Cluj nasceva da una tensione tra storia e immaginazione, qui il sacro si riduce a superficie. Il velo della Vergine, il chiodo della Croce, le reliquie da Costantinopoli: elementi che, nelle intenzioni, dovrebbero evocare mistero e trascendenza, ma che finiscono per comporre un sacro anestetizzato, privo di contraddizioni, dove la spiritualità si trasforma in estetica. Le finestre e le architetture del Santa Maria, riprese nei dipinti come in un gioco di specchi, diventano semplici motivi decorativi, mentre la penombra della sala ne amplifica la distanza dal reale.
Se davvero, come sostengono i curatori, l’artista ha tratto ispirazione dall’atmosfera del Santa Maria, allora la mostra dice qualcosa di inquietante: forse è il museo stesso ad aver trasmesso la propria ombra, la propria immagine spenta e autoreferenziale. Le Metamorfosi del Sacro diventano così lo specchio di una metamorfosi più ampia, quella del Santa Maria della Scala, che da luogo di cura, accoglienza e memoria condivisa sembra trasformarsi in un contenitore di estetiche globali, prive di radicamento e di rischio.
Come già nel caso di Hashimoto, anche qui domina una concezione decorativa dell’arte, in cui il rapporto tra opera e spazio è risolto attraverso l’effetto, non attraverso il pensiero. Tutto deve piacere, tutto deve rassicurare. Nessuna frizione, nessuna ferita, nessuna domanda sul senso del sacro, della cura o della metamorfosi.
Ma il Santa Maria della Scala non è un semplice edificio. È uno degli elementi identitari di Siena, un luogo che per secoli ha rappresentato l’idea stessa di comunità, di solidarietà, di conoscenza. Ridurlo a scenografia per mostre eleganti e inoffensive significa disinnescare la sua forza simbolica, cancellare la sua memoria viva.
In questa deriva estetizzante si riflette la crisi più ampia della politica culturale senese: l’incapacità di distinguere tra cultura e spettacolo, tra riflessione e intrattenimento. Se il Santa Maria smette di essere laboratorio e si accontenta di essere galleria, Siena rischia di perdere uno dei propri cuori identitari, trasformando la cultura in semplice ornamento.
Oggi più che mai, servirebbe un’arte capace di mettere in discussione il luogo che la ospita, non di rifletterne l’immagine levigata. Perché quando l’arte smette di interrogare e si limita a decorare, anche la città che la accoglie comincia lentamente a somigliare alla sua ombra.