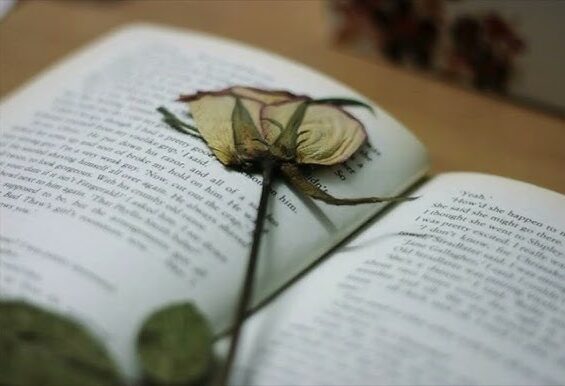Si apre con una musica dal sound vanzianiano vacanziero, anni Ottanta e romano, la sfilata delle cartoline arbasiniane, spedite da ogni parte del mondo ad amici e amiche, pretesto ed occasione per un rap o un saluto.
Parte dagli angoli di una letteratura vastissima, Michele Masneri che con la complicità di Antongiulio Panizzi, ha portato il mese scorso a quella che fu la Festa del Cinema di Roma (ora autodefinitasi dai suoi stessi manifesti Rome Film Fest, come fosse una Rotterdam qualunque) e adesso su Raitre, il documentario Stile Alberto, tratto dal suo omonimo baedeker pubblicato da Quodlibet nel 2021, a pochi mesi dalla dipartita del grande vogherese o forse sarebbe meglio dire iriènse vista la discesa romana che ne tracciò poi la carriera letteraria e mondana.
Arbasino dunque come ispiratore di stile, forma e contenuto, ma anche inevitabilmente assoluta ossessione che Michele Masneri, presente in scena in qualità d’intervistatore e interlocutore di intellettuali, di principesse e aristocrazie varie, di amiche e amici di Arbasino, prova a dissimulare con un contenimento degno del miglior David Attenborough.
L’indagine
Già perché quella portata a termine da Masneri è una vera esplorazione nel mondo arbasiniano che pur non essendoci più se non in forma di tracce e superstiti permane con indefessa allegria a differenza di quel Novecento glorioso che va da Italo Calvino a Pier Paolo Pasolini, da Goffredo Parise a Paolo Volponi da Alberto Moravia a Elsa Morante che ancora pesa sulle coscienze dei pochi boomer e millennial consapevoli con enormi dosi di malinconia e nostalgia spesso fuori luogo.
Qui è tutta un’avventura che parte dalle stanze semi buie della meravigliosa abitazione di Giovanni Agosti, amico, storico, critico e non da ultimo vero scrittore di quello che può anche essere definito come il più grande romanzo degli ultimi dieci anni, un’opera degna di Fratelli d’Italia – ben inteso, ultima versione – di Arbasino, ovvero La Gae pubblicato quest’anno da Electa sotto le mentite spoglie di un catalogo di mostra dedicato a Gae Aulenti.
Agosti perlustra armato di torcia gli scaffali infiniti della sua biblioteca archivio in una versione da caverna di Platone della biblioteca di Umberto Eco. Là dove il semiologo alessandrino si aggirava con passo svelto e sicuro seguito dalla camera di Davide Ferrario, qui nella sua casa milanese, Agosti indaga come d’innanzi ad un delitto ancora tutto da chiarire, tra carte, scatoloni, lampadari veneziani e un elefante al centro della stanza. Lo storico dell’arte ricerca i famosi (favolosi) fax che Arbasino spediva ai suoi amici più cari, ormai però cancellati dalla chimica di una carta termica senza senso del tempo.
Stile Alberto prova a capire e a indagare così se un’ossessione può divenire un’occasione di stile, se una forma probabilmente di mancanza, di vuoto, di assenza possa divenire uno spazio possibile di festa e allegria. Si ritorna così a Voghera, nella casa di campagna della famiglia Arbasino acquistata dal nonno Gioacchino e proprio in una giornata di pioggia incessante – molto lombarda – compare fuori dall’uscio, coperto da una cerata a mantella e cappello (come in un sogno felliniano) Alberto stesso, salvo poi chiarire subito allo spettatore troppo stralunato, d’essere in verità Mario, fratello di Alberto, dotato sì della medesima erre arrotata, ma anche di una tensione nevrotica meno incessante, quasi a definire una distanza tra il fratello calato a Roma e il lombardo rimasto tale.
Tra la Lombardia e Roma
Da Voghera Alberto Arbasino è certamente fuggito, così come da una tristezza nebbiosa e umida e da un moralismo, sicuramente temperato dall’illuminismo lombardo, ma pur sempre cattolicamente ombroso e colpevolizzante. Fuggito in cerca di cultura, di quel cosmopolitismo raggiungibile oltre Chiasso, ma anche oltre Tevere, tra artisti, aristocratici ed eminenze vaticane, ovvero il milieu della mondanità romana.
Tutto questo però Arbasino lo deve anche a quell’economia lombarda che sotto le insegne della farmacia Arbasino («Se avessi avuto io una farmacia!» esclama ironico Giorgio Montefoschi) gli ha permesso di viaggiare e di dribblare in ultimo sia la carriera diplomatica come quella accademica, rimanendo così battitore libero, privo di gruppi e conventicole, ma capace di scendere in pista ad ogni ballo: a teatro come in televisione, su qualche terrazza romana così come in libreria, al cinema come nelle fredde notti parigine al caldo di una zuppa popolare in quello che fu il mercato di Les Halles.
Le case meravigliose come astronavi di marziani su Roma o come castelli delabrè dalle pareti affrescate e dagli infissi invecchiati costellano Stile Alberto quasi ad indicare una possibilità diversa dalla nenia romana delle buche e del traffico perenne e anche dal disfacimento culturale dei barbari sempre alle porte. Una possibilità di festa non perenne, ma quanto meno sempre possibile, nonostante gli anni, gli amici persi e l’eleganza sempre più lontana dall’essere tale.
Arbasino dunque come provinciale come chiunque che non sia nato a Roma, forse annoiato durante i party nelle ville sull’Appia antica – come suggerisce Masolino D’Amico – o forse in cerca di un’appartenenza e di un’approvazione che il mondo culturale in realtà a lungo ha stentato a riconoscergli, sia negando il suo valore, quasi mai tradotto all’estero, sia preferendo ridurlo ad una macchietta pronto uso. Anche qui varrà la regola del nipotino, così come Arbasino coniò per i nipotini di Gadda a cui lui per altro apparteneva, e che ora vale per i nipotini suoi: dallo stesso Michele Masneri a Pier Giovanni Adamo, il primo ad organizzare dopo la sua scomparsa, Arbasino, e poi due giornate di studi in suo onore all’università di Padova.
Pienamente novecentesco
Il documentario ottimamente accolto in sala a Roma, presenta così il profilo di un intellettuale pienamente novecentesco sia nelle sue desuetudini proustiane, sia nelle sue abitudini fin de siècle che lo portavano negli States via piroscafo, sia in una comprensione del contemporaneo capace di proiettarlo oltre il secolo con una qualità di visione e con un’interpretazione dei fatti sempre priva di schematismi vetusti. Uno sguardo educato e più ancora liberato là dove c’è sempre spazio per divani lunghissimi e ospitali, ma mai per le tristissime statuette di Capodimonte messe al bando al pari delle vecchie ideologie.
Stile Arbasino si chiude mentre una festa che si apre alla Furibonda di Marisela Federici, ma anche con un’immagine rapida dalla tomba a Voghera di Arbasino dove appare un’inedita fotoceramica, un Arbasino in bianco e nero, senza cravatta e con uno stile lombardissimo, un addio a Roma e a quella piazza del Popolo che sembra essere il destino di tutti i non romani che a Roma hanno amato vivere.
Il documentario va in onda il 15 novembre su Raitre in quella che un tempo si definiva seconda serata e che ora potrebbe portare gli spettatori ad una mezzanotte inoltrata, dieci giorni dopo per la cura di Giovanni Agosti torna in libreria l’edizione di Fratelli d’Italia uscita da Feltrinelli nel 1963, peccato solo che in copertina non ci sia più il disegno del Vittoriano su fondo blu.