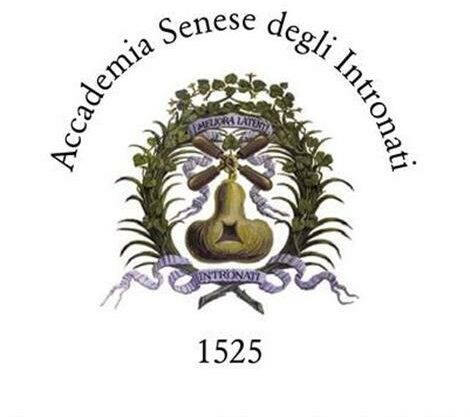Dr Dre – Nuthin’ But A “G” Thang
6 Aprile 2025
Piancastagnaio, alla Rocca Aldobrandesca con Antonio Prete
6 Aprile 2025di Roberto Barzanti
Celebrare cinquecento anni di un’esistenza piena di ostacoli e di interruzioni, talvolta silenziata dal potere, non è cosa da nulla. L’Accademia degli Intronati che nacque a Siena mezzo millennio fa — le ricerche d’archivio danno certa la data 1525 — merita l’intenso calendario di riflessioni e spettacoli annunciato nei giorni scorsi. Come presidente — Archintronato! — sono contento di festeggiare questo atteso compleanno. Il patrimonio culturale da sottrarre all’oblio non coincide solo con opere d’arte, quadri e sculture. Ha da far valere suoi diritti pure la letteratura, trascurata o dimenticata del tutto: teatrale o trattatistica, finalizzata spesso a enumerare norme di galateo e instillare attaccamento civico. Sappiamo quanto sia stato policentrico e geograficamente dislocato il sorgere di differenti modalità organizzative e di innovative esperienze: un panorama di lingue e caratteri da non cancellare.
Nel 1525, dunque, sei rampolli di nobiliari casate, sex viri nobiles , dice Mino Celsi, l’Asciutto, decisero di aggregarsi assumendo il nome di Intronati per alludere allo stordimento che provavano in anni tumultuosi e alla scelta di astrarsi, sedendo in trono, lontani dal clamore delle lotte politiche per dedicarsi alla letteratura, a dialoghi filosofeggianti e a brillanti conversari. Nell’esplodere del fenomeno accademia Siena detenne nel Cinquecento, stando ai calcoli più recenti, 38 Accademie, ma in totale andando oltre il XVI secolo ne sono state individuate ben 97. Roma nel Cinquecento ne contava solo 19. L’Accademia degli Intronati si ispirò ad un modello umanistico riprendendo e correggendo elementi della tipologia classicheggiante in voga nel Quattrocento. Fu la prima al mondo, fra quelle ancora in attività, a dotarsi di un’impresa: una zucca per conservare il sale con sopra due pestelli in guisa di croce di sant’Andrea: la zucca è una pianta umile, che tende però all’alto e il frutto è usato per conservare e proteggere dall’umidità una sostanza quanto mai preziosa, il sale triturato dai pestelli. Si dette un motto, meliora latent (le cose migliori stanno nascoste) e imperative leggi: Deum colere, Studere, Gaudere, Neminem laedere, Nemini credere, De mundo non curare. Traducendo alla buona: Onorare Dio, studiare, godere, non nuocere ad alcuno, non credere a nessuno, non curarsi degli affari del mondo. I primi tre emanano obbligante solennità. Gli altri tre sono intinti di quel dilagante pirronnismo (dal filosofo greco Pirrone), o scetticismo, che consigliava prudenza e riservatezza, dubbi e imperturbabilità. L’impresa rimandava ad un’umile rusticità ed esaltava «un sapere senza rischi di complicazioni politiche — ha osservato Amedeo Quondam purtroppo non più tra noi — ed ecclesiastiche». Il governo era esercitato «a guisa di repubblica — secondo G.B. Alberti — con modo aristocratico».
Da principio l’attività di maggior spicco degli Intronati fu la produzione teatrale, che ebbe eccezionale risonanza nel teatro europeo moderno. La rappresentazione sulla scena mischiava schemi classici e allusioni al presente. In queste isole gli spiriti più aperti sognavano una concordia universale: «Questo general mondo tutto essere una città — secondo qualcuno — e noi a quella guisa possiamo non isconvenevolmente forse dire un’accademia d’huomini insieme e di dei» (1569). La commedia più conosciuta è Gl’ingannati , presa a modello da Shakespeare per La dodicesima notte . Tra gli Intronati incontriamo personaggi di rilievo. Basterà evocarne qualcuno per capire la laica compresenza di idee diverse, se non opposte. Furono ascritti agli Intronati eretici combattivi quali Mino Celsi (1514- 1576), e Fausto Sozzini (1539-1604), il Frastagliato, propugnatori della tolleranza religiosa nelle drammatiche controversie della Riforma.
Ma Intronati furono anche due papi: Marcello Cervini (1501-1555, il Rigido) fu papa Marcello II e Fabio Chigi (1599-1667, il Guardingo) divenne Alessandro VII, continuò la sua giovanile passione per la poesia latina e fu campione di un generoso mecenatismo artistico. Un capitolo di accademica furia in tema di lingua vide schierarsi Claudio Tolomei (1492-1556, il Sottile) a favore di una viva lingua toscana contro l’esclusiva del fiorentino o di un libresco italiano. Girolamo Gigli (1660-1722, l’Economico) sbandierò contro la Crusca il Vocabolario cateriniano rivendicando l’apporto del lessico della santa nella difficoltosa istituzione di una lingua parlata da popolo e dotti. Altro campo in cui gli Intronati si distinsero fu l’accoglienza accordata alle donne. Li rimproverò Traiano Boccalini per aver ammesso Vittoria Colonna e altre: «la vera poetica delle donne — tuonò — era l’ago & il fuso». Come se non bastasse nacque, in collegamento con gli Intronati, una parallela Accademia delle Assicurate (1645-1715), tutta al femminile: «le nostre spiritosissime Assicurate» le chiamò in un moto d’affetto il Gigli. Antonio Vignali (1500-1559, l’Arsiccio), tra i fondatori dell’Accademia, scrisse la Cazzaria (1526 circa). Fu pubblicata a stampa nel 1531 a Venezia. Si trattava di un burlesco dialogo costruito su alcune questiones che riguardavano le parti basse dell’uomo e della donna («Perché il cazzo si chiami materia», «perché la potta è chiamata natura» ecc.). Tanto sfrenatamente priapesco, da far impallidire Carlo Emilio Gadda. A prova dell’anticonformismo intronatico val la pena rammentare che tra gli ascritti figura perfino Voltaire (François-Marie Arouet), chiamato nel sodalizio nel 1746. È restata la lettera di ringraziamento: Voltaire esprime riconoscenza: le «continue malatie», aggravandosi, gli avevano impedito di «fare il viaggio di Toscana», e di «salutare questa madre di tutte le arti e scienze» e rendere omaggio alla «celebratissima academia». Dopo alti e bassi, interruzioni e silenzi, nel 1942 rinasce la denominazione di Reale Accademia degli Intronati. Che richiamiamo in scena per onorare un lascito straordinario, e per immaginare la capacità di stare nel mondo con equilibrata curiosità e umana intelligenza.
https://corrierefiorentino.corriere.it/