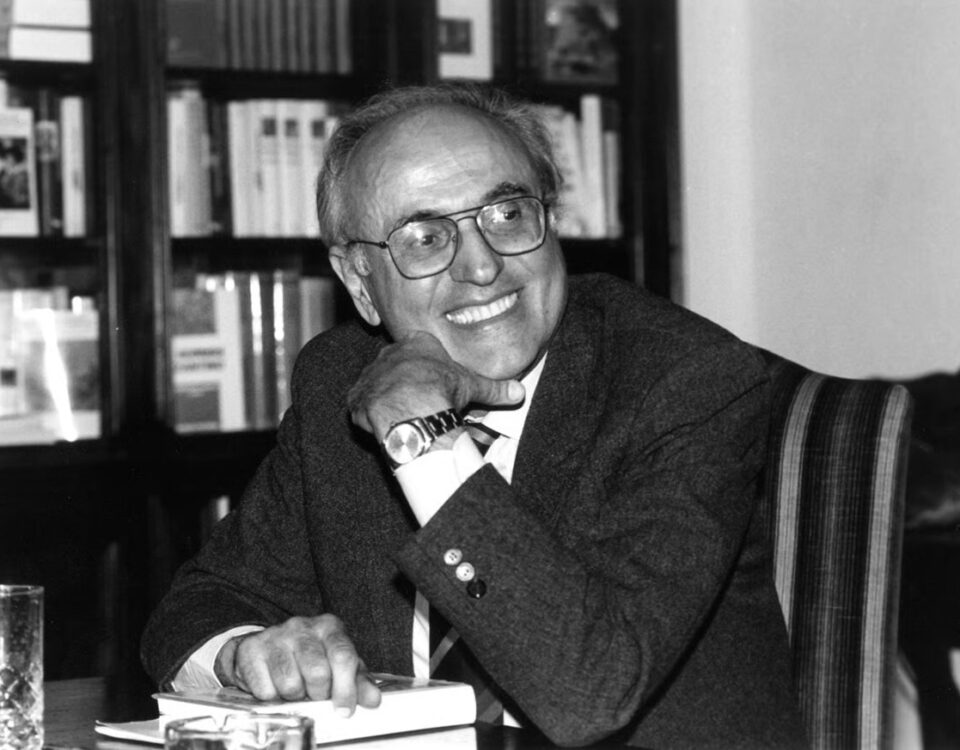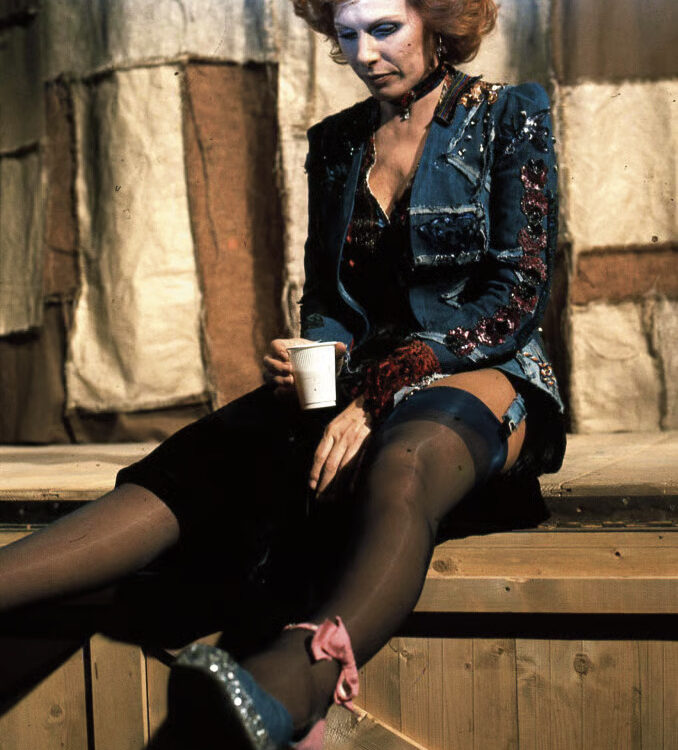Stevie Wonder- Signed, Sealed, Delivered, I’m Yours
4 Novembre 2025
DIGEST STRATEGICO – Mercoledì 5 novembre 2025
5 Novembre 2025
(osservazioni personali e ipotesi interpretative da verificare)
Il recente restauro della Tebaide attribuita a Lippo Vanni, riemersa nel complesso del Santa Maria della Scala, mi ha indotto a riflettere su una possibile funzione assistenziale particolare di questo ambiente, forse collegata – almeno in origine – alla tradizione antoniana. La scoperta del ciclo pittorico, avvenuta nel 1999 durante i lavori di recupero condotti da Guido Canali e resa pienamente visibile grazie al sostegno della Fondazione Vaseppi tra il 2021 e il 2024, apre in effetti nuove prospettive interpretative.
La Tebaide, dipinta a monocromo in ocra rossa e raffigurante i Santi Padri eremiti nel deserto egiziano, è un soggetto non comune in un contesto ospedaliero. Si tratta del luogo in cui operò Sant’Antonio Abate, padre del monachesimo cristiano e figura centrale dell’Ordine Ospedaliero Antoniano. L’iconografia di eremiti che coltivano l’orto, curano malati, attraversano fiumi o meditano in solitudine potrebbe rimandare, più che a un generico riferimento ascetico, a un preciso universo devozionale e terapeutico.
Un ulteriore elemento che mi ha colpito è la presenza di un’immagine di Sant’Antonio Abate con i suoi attributi canonici nell’area dell’ex pronto soccorso: il maiale con la campanella, il bastone a tau, il piccolo campanello che gli Antoniani usavano durante le questue. Questi simboli rimandano inequivocabilmente all’Ordine che si occupava della cura del cosiddetto “fuoco di Sant’Antonio”, l’ergotismo causato dall’ingestione di segale contaminata dal fungo Claviceps purpurea. È un dato certo che la malattia, particolarmente diffusa tra i ceti più poveri dell’Europa medievale, colpisse anche le campagne toscane, dove la segale era coltivata nei terreni più poveri e destinata alla panificazione.
La connessione tra la diffusione della segale, la comparsa dell’ergotismo e la presenza di un grande ospedale lungo la Via Francigena come il Santa Maria della Scala mi ha spinto a formulare un’ipotesi: è possibile che all’interno del complesso sia esistita, almeno per un periodo, una sezione antoniana specializzata nella cura di questa patologia? Gli Antoniani, come noto, applicavano un trattamento articolato che prevedeva l’eliminazione del pane di segale, l’uso di unguenti a base di grasso di maiale e l’impiego di liquidi benedetti passati sulle reliquie del santo. Il privilegio concesso da Urbano II nel 1095 – che consentiva ai loro maiali di circolare liberamente nei centri abitati, riconoscibili dal campanellino al collo – aveva un significato non solo simbolico ma anche economico, poiché garantiva ai monaci una fonte costante di materia prima per le preparazioni terapeutiche.
Immaginare un nucleo antoniano al Santa Maria della Scala significa collocare l’ospedale senese all’interno di una rete di cura europea, attenta sia alle necessità materiali dei pellegrini sia alle grandi emergenze sanitarie medievali. La posizione strategica del complesso, la sua dotazione economica, la spiritualità penitenziale dei Disciplinati che vi operavano e la ricorrenza iconografica di Sant’Antonio potrebbero costituire indizi – deboli ma suggestivi – di una presenza organizzata o di una collaborazione con l’ordine.
La convergenza di elementi iconografici, geografici e storico-assistenziali merita, a mio avviso, un approfondimento. L’analisi archivistica potrebbe riservare sorprese, magari rivelando legami indiretti – donazioni, reliquie, dedicazioni o pratiche terapeutiche – che colleghino Siena alla rete antoniana. In ogni caso, anche se l’ipotesi dovesse essere confutata, l’indagine contribuirebbe a comprendere meglio la complessità assistenziale e spirituale del Santa Maria della Scala, luogo dove la cura del corpo e quella dell’anima si intrecciarono per secoli in forme molteplici.
Un’eventuale conferma di questa ipotesi non cambierebbe solo la lettura iconografica della Tebaide, ma arricchirebbe la storia dell’ospedale senese di un capitolo affascinante, legato alla grande tradizione europea della medicina monastica. Un capitolo ancora da scrivere, che invita alla ricerca più che alla conclusione.
Pierluigi Piccini