
QUEGLI ALLEGRI RAGAZZI DELLA DDR
28 Settembre 2025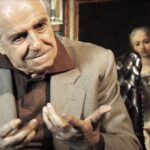
La moralità figurativa di Ferdinando Bologna
28 Settembre 2025MUSICA
Oggi per un pubblico Under35, debutta alla Scala “Anna A.” di Silvia Colasanti Ispirata alla poetessa russa, è la prima opera di una compositrice nel teatro milanese Un debutto tutto al femminile, con Anna Skryleva sul podio e la regia di Giulia Giammona. Protagoniste il soprano Laura Peresivana e l’attrice Elena Ghiaurov
La curiosità è vedere l’effetto che fa. L’effetto che fa la prima opera di una donna compositrice al Teatro alla Scala. «A me sinceramente non fa nessun effetto. Mi hanno chiamata, ho presentato un progetto e ho cercato di farlo al meglio» dice Silvia Colasanti. Però è suo il primato. Oggi – debutto alle 11 poi una lunghissima serie di repliche in orari scolastici o per famiglie, ma perché non osare fino in fondo e relegare invece questa prima volta al cartellone, seppur interessante, degli spettacoli per gli Under35? Oggi prima assoluta della sua Anna A. opera ispirata alla vita della poetessa russa (nata vicino a Odessa, oggi Ucraina, nel 1889) Anna Achmatova, bersaglio della censura del regime comunista – il primo marito fucilato da Stalin, il secondo marito e il figlio internati nei gulag. Libretto di Paolo Nori. Una donna sul podio, Anna Skryleva, una donna a firmare la regia, Giulia Giammona. Orchestra e solisti dell’Accademia del Teatro alla Scala. Per raccontare la storia della poetessa russa, «una donna sempre libera, che non ha mai lasciato la sua terra, perché gli artisti combattono i totalitarismi e lo fanno con la loro arte… la poesia di Anna, la musica di Sostakovic» racconta Silvia Colasanti, romana, classe 1975, «nata l’8 marzo». Non un caso, forse. «Certo, questa prima volta di una compositrice al Piermarini – racconta – ha un valore simbolico, per le lotte che sono state fatte dalle donne prima di me».
Comunque, Silvia Colasanti, fa effetto sapere che oggi per la prima volta alla Scala va in scena l’opera di una compositrice donna… « Razionalmente lo capisco, fa titolo, ma non lo vivo in modo particolare, sono dentro al processo creativo, al mio lavoro quotidiano e trovo normale che i compositori siano sia uomini che donne. Certo, posso dire che spero naturalmente di non essere l’ultima».
Perché Anna Achmatova?
«Perché è una poetessa. Molti dei miei lavori sono nati dalla collaborazione con voci poetiche come quelle di Mariangela Gualtieri, Maria Grazia Calandrone, Patrizia Cavalli. Ho lavorato anche su Ovidio. Per un musicista la parola in musica è sempre poetica. Ho sempre avuto una grande passione per la poesia e per la letteratura, specialmente per quella russa. E sono sempre stata affascinata dalla figura di Anna. Avevo contattato Paolo Nori ancora prima dello scoppio della guerra in Ucraina per proporgli di lavorare su Achmatova. Ed è stato un incontro profetico perché non sapevo che stava scrivendo un libro proprio su di lei».
Ha realizzato una biografia in musica della poetessa?
«Il centro dell’opera è il suo Requiem, un testo che segna l’ingresso della storia e della politica nella poesia di Anna, poesia che prima era solo intima. Ho scelto alcuni momenti della sua vita legati alla censura, alle violenze subite dai mariti e dal figlio. In scena c’è l’Anna morente del 1966 – alla quale dà volto un’attrice, Elena Ghiaurov – che ricorda brandelli del suo passato – l’Anna dei ricordi è il soprano Laura Lolita Peresivana. Ma c’è anche una terza Anna, in orchestra, il violino solista che canta, incessantemente per tutta la durata della partitura. La voce della libertà. Perché questo è il tema che percorre Anna A. facendo della poetessa una figura senza tempo, come i tanti artisti che hanno lottato con l’arte che ha una forza capace di sopravvivere a qualsiasi regime. Parliamo di Russia e penso a Šostakovic che cito nella mia opera con l’incipit della sua Leningrado, raccontando l’assedio della città».
Fatti, date precise… personaggi storici nel libretto, da Marina Cvetaeva a Michail Bulgakov a Boris Pasternak.
«Certo, perché la storia di Anna non è inventata, come spesso capita all’opera, ma è una vicenda realmente accaduta che, messa in musica, assume un grande valore simbolico. Per me l’arte, e dunque la musica, deve fare quello che ha sempre fatto, portare un messaggio universale fuori dai luoghi e fuori dei tempi. In Anna A. non siamo solo in Russia, non siamo solo nel Novecento, siamo anche lì, ma per raccontare una storia di sempre. La censura non riesce a reprimere la forza dell’arte. Penso alle poesie di Anna imparate a memoria dall’amica Lidija e ritrovate su un libretto con pagine fatte di corteccia in un gulag. La poesia ha camminato da sola».
Un’opera per ragazzi o un’opera per tutti la sua Anna A.? Il suo modo di scrivere cambia a seconda del pubblico al quale si rivolge?
« Anna A. è un’opera per tutti. Sicuramente se scrivo per i bambini ho un certo approccio. Qui, invece, il pubblico è quello degli under 35 e dunque il mio modo di scrivere per loro è identico a quello pensato per un pubblico universale. Quando scrivo lo faccio per tutti. Oggi c’è una complessità del linguaggio che è fortemente stratificato e per comprenderlo a fondo devi avere sulle spalle la storia. Io, scrivendo musica, devo veicolare questa complessità con la chiarezza. E devo farlo con un linguaggio che attinge alla sfera del sentire perché il sentimento fa scavare più a fondo. Sentire è complesso, ma nello stesso tempo anche semplice. Nel mio lavoro cerco di tenere insieme questi due estremi».
E come lo traduce in musica?
«In Anna A. si capisce che siamo in Russia perché ho voluto evocare quel mondo e il mio amore per quella musica, come nel coro delle Madri. Non c’è però folklore, non ci sono citazioni fini a se stesse. C’è una fisarmonica in orchestra, si ascoltano ritmi di danza, c’è, presentissima, la polka».
Per questo debutto un team tutto al femminile. Ma oggi c’è ancora bisogno di affermare il ruolo delle donne?
«Io lo vivo come il mio lavoro. Lo faccio e cerco di farlo bene. Dall’esterno capisco che questo faccia effetto. Anche perché quello dei compositori d’opera è un campo prettamente maschile. Il mio ruolo non è portare avanti il mio essere donna, ma il mio ruolo di musicista e farlo al meglio».
Cosa rappresenta nel suo percorso di compositrice il teatro musicale?
« È il luogo dove mi sento più a casa. Certo, ho fatto lavori cameristici, mi piace la musica sinfonica sempre con organici ampi, ma la mia predilezione è sempre per l’opera perché è lo spettacolo più completo. Collabori con tante persone, c’è il lavoro sulla drammaturgia e ogni personaggio incarna sempre una parte di te. Anche per questo il compositore deve avere uno sguardo di comprensione e compassione su tutti i personaggi».
Ora è direttrice artistica del Festival della Valle d’Itria di Martina Franca. Quanto occorre essere musicisti e quanto manager per dirigere un’istituzione musicale?
«Nella stessa misura in cui occorre esserlo scrivendo un’opera. Quando inizi il lavoro su una nuova partitura devi essere prima di tutto una pianificatrice perché un’opera ha un suo schema ben preciso, le idee devono essere organizzate dentro un disegno unico. Non sono momenti isolati, ma devono essere armonizzati. Così nel disegnare il cartellone di un festival. Non basta un’idea perché questa deve entrare in un contesto reale, con i mezzi che hai. E sappiamo che quelli economici sono sempre più limitati. Ma proprio questi limiti spesso diventano risorse».




