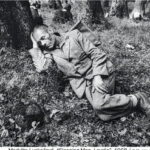Il rapporto con la Russia e il “caso Gergiev”. Trump e l’opera L’eredità del passato e i progetti per le nuove generazioni Intervista al direttore d’orchestra dall’agenda fittissima
di
Gregorio Moppi
Non è vero che la musica classica non fa politica. O perlomeno è evidente che a certi politici, in determinati momenti storici, interessa appropriarsene. E il podio di un direttore d’orchestra può diventare un osservatorio privilegiato di queste dinamiche, del cattivo e del buono presenti nella società. Per chi sta su quel podio non vale trincerarsi dietro una presunta innocenza dell’arte, e non esistono che due opzioni: resistere alla pressione del potere o farsene complici. Lo sa bene Gianandrea Noseda, che a inizioDuemila, come direttore ospite principale del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, si è trovato ad assistere al consolidarsi del dominio sulla vita musicale russa di Valery Gergiev, che oggi l’Occidente ostracizza accusandolo di complicità ideologica e finanziaria con Putin. E, più ancora, se ne rende conto adesso, all’ottavo anno da direttore della National Symphony di Washington, l’orchestra ospitata nel Kennedy Center, il complesso di sale teatrali sulla cui programmazione il trumpismo sta tentando di mettere il becco così da orientarla verso il suprematismo Maga.
Maestro, Trump è anche presidente del Kennedy Center.
Quanto sta condizionando le attività e le scelte di un’orchestra che è “nazionale”?
«Suoniamo un repertorio sinfonico, il che può parere di scarso interesse a chi vuole porre il proprio marchio ideologico sull’arte. Sarebbe diverso se facessimo opera, dove c’è la parola e si raccontano storie».
La musica strumentale è priva di significati?
«Ne ha, solo che non appaiono immediatamente accessibili. La musica esprime il linguaggio delle emozioni, è questo il suo significatoprimario. Bisogna lasciarla parlare specialmente quando i leader politici urlano, poiché è un’arte che aiuta a riflettere sulle eredità che ci hanno lasciato i grandi».
Trump pretende che il Kennedy Center torni a essere “hot again”, ossia popolare e non sinistroide.
Che vorrà dire?
«Chissà. Le sue affermazioni sono spesso ondivaghe. E io, diventando vecchio, scelgo di seguire la filosofia di Andre Agassi, secondo cui è vano angosciarsi per quanto è fuori dal nostro controllo. Quindi ciò su cui lavoro è che l’orchestra, in vista del suo centenario, nel 2031, giri maggiormente per ilPaese, abbia pubblici numerosi, diversificati, e che faccia sentire tutti ben accolti ai suoi concerti, bianchi, afroamericani, latini, asiatici. Ecco il compito vero di un’orchestra “nazionale”».
Cinque mesi fa il vicepresidente Vance è stato fischiato.
«Non so se fosse soltanto dissenso politico. Il pubblico era nervoso perché Vance, per ragioni di sicurezza, è arrivato in sala con mezz’ora di ritardo, facendo slittare l’inizio del concerto mentre già l’orchestra era seduta sul palcoscenico. Il minuto di fischi e la tensione palpabilissima sono svaniti quando il primo violino e iosiamo entrati in scena».
In passato ha frequentato a lungo la Russia già dominata da Gergiev, despota di genio. Come vi siete conosciuti?
«Nel 1993, poco più che trentenne, ho seguito i corsi di direzione all’Accademia Chigiana di Siena. Li teneva Ilya Musin, un ometto artisticamente gigante. Gergiev ne era pupillo e assistente: ci insegnava a modellare con l’orchestra il suono che avevamo in testa. Tempo dopo mi ha invitato al Mariinskij , forse perché intendeva aggiornare il modo di preporre l’opera italiana che fino all’epoca di Gorbaciov era sempre stata data in russo e senza tener conto della nostra tradizione esecutiva. Mi sono trovato a collaborare con cantanti straordinari come Anna Netrebko e Ildar Abdrazakov».
Gergiev era già potente?
«Molto. La Russia ha sempre avuto il mito dell’uomo forte, glorificato finché non cade. Si pensi alBoris Godunov di Puškin e Musorgskij.
Anche in teatro l’autoritarismo, unito a una preparazione solida, fa sì che le masse artistiche ti seguano senza se e senza ma, perché i musicisti russi si immergono in ogni esecuzione con un senso di ineluttabilità, come fosse l’ultima azione della loro vita».
Che giudizio dà della posizione politica di Gergiev?
«Ognuno si assume la responsabilità delle proprie scelte.
Comunque il giudizio morale che si può aver di lui non inficia il valoredell’artista».
Da quattro anni dirige l’Opera di Zurigo, dove c’è un un sovrintendente di 48 anni: da noi sarebbe considerato un bimbo…
«È Matthias Schulz, lì non per occupare un posto di potere ma, con il suo entusiasmo, per servire un teatro in cui punta a far succedere cose importanti. Sa che, se farà bene, gli si apriranno porte di altre grandi istituzioni».
Perché in una sperduta cittadina della Georgia lei si occupa di un’orchestra giovanile?
«È una risposta alla nostra epoca di respingimenti, bombe e muri che causano lacerazioni insanabili. A Tsinandali invece, dove ai primi di settembre ci sarà la settima edizione del mio festival, nell’orchestra che ho messo su suonano turchi e armeni, ucraini e russi, kazaki, turkmeni, azeri, scordandosi di pregiudizi e odio culturale respirati in famiglia».
Dopo un decennio al Regio di Torino, adesso in Italia collabora soprattutto con la Filarmonica della Scala. Nemo propheta?
«Lavoro anche con Santa Cecilia e Maggio fiorentino. Comunque sì, il 90 per cento della mia attività è all’estero. Però sento responsabilità e trepidazione quando sono alla Filarmonica. È l’orchestra della mia città, alla quale, certo, non devo dimostrare nulla, e tuttavia mi impegno ogni volta a farle vedere che sono un buon figlio del suo modo integro di far musica».