
Il governo si assolve: «Colpa degli scafisti». Sintonia Meloni-Ue
8 Marzo 2023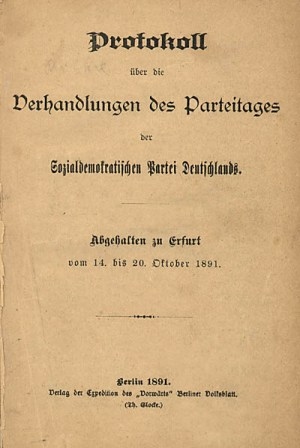
Il riformismo senza sinistra si chiama neo-liberismo
8 Marzo 2023Non è affatto usuale, all’interno dell’esteso canone letterario sulla peste che va da Tucidide al «Decameron Project», antologia pubblicata dal New York Times nell’estate pandemica di tre anni fa, trovare menzione del De mortalitate di Tascio Cecilio Cipriano, vescovo di Cartagine martirizzato da Valeriano nel 258 d.C., fra i più autorevoli esponenti della chiesa dei primi secoli. Non saranno soltanto gli antichisti, pertanto, a poter approfittare della nuova traduzione commentata del trattato (Cipriano di Cartagine, L’epidemia ovvero La condizione mortale, pp. 192, € 13,00) pubblicata da La Vita Felice per le cure di Fabio Gasti, professore di Letteratura latina tardo antica presso l’Università di Pavia e non nuovo alla sfida di avvicinare ai lettori opere poco o punto note della latinità tarda, come la Medea di Draconzio o l’Itinerarium Padi di Ennodio.
Come ha mostrato da ultimo Kyle Harper nel recente Il destino di Roma. Clima, epidemie e la fine di un impero (Einaudi 2019), l’epidemia di vaiolo (o forse ebola) che flagellò l’impero fra il 249 e il 262 d.C., arrivando a uccidere 5.000 persone al giorno nella sola Roma, e che è nota in storiografia proprio col nome di «peste di Cipriano», rappresentò un letale moltiplicatore della crisi politica, militare, sociale, economica e climatica del III secolo, che – a dispetto delle edulcorazioni di certa recente storiografia ultra continuista – mise per la prima volta a serio rischio la stessa esistenza della compagine imperiale. Se lo scenario pandemico rappresenta l’immediato riferimento dell’opuscolo – forse esito della rielaborazione di un’omelia –, esso non esaurisce tuttavia l’orizzonte pastorale di Cipriano, che si cimenta in una profonda meditazione storico-teologica sul contagio: particolarmente opportuna, in questo senso, la decisione di Gasti di valorizzare sin dal titolo del volume i due significati del termine latino mortalitas, cioè «la morìa» – dunque, per metonimia, l’epidemia stessa – e «la condizione mortale».
Alla comunità cristiana di Cartagine, già attraversata da complessi conflitti dottrinali, Cipriano si rivolge con intento essenzialmente protrettico e consolatorio; ma l’innesto dei tradizionali motivi del genere nella nuova cornice provvidenzialistica, pavesata da un robusto corredo di exempla biblici (Giobbe e Tobi, naturalmente, ma anche gli apostoli e i martiri), in realtà ribalta l’usuale topica consolatoria, dando origine a una paradossale anti-consolatio: le sofferenze causate dalla malattia vanno abbracciate con gioia, in quanto consentono di saggiare la saldezza della fede, e i defunti non devono essere pianti ma festeggiati, poiché ormai liberi dalla prigione del secolo.
Nell’introduzione al trattato Gasti è attento a evidenziare il retroterra filosofico e dottrinale del pensiero di Cipriano e la matrice retorica del suo stile, che incarna la quintessenza della prosa d’arte cristiana dei primi secoli. La placida eloquenza del vescovo rifugge gli esasperati colores di Tertulliano e opta invece per l’apparente inornatezza dello stile mediano, preferendo ai concettismi brachilogici più ampie campiture sintattiche, con serie binarie o ternarie che – lo rilevava già Norden – appaiono spesso rette dal parallelismo con omeoteleuto.
Al commento occorrerà invece rivolgersi per l’individuazione delle singole tessere mutuate dagli autori antichi, che sono numerose ma talvolta come mimetizzate all’interno dell’orditura biblica; memorabile è almeno la definizione della morte come passaggio (Non est exitus iste sed transitus), che corregge in asserzione l’alternativa socratica codificata da Seneca nel celebre motto dell’Epistola 65 (Mors quid est? Aut finis aut transitus), mentre alcune pennellate lucreziane arricchiscono le descrizioni della sintomatologia della peste e della senescenza del secolo. Si tratta di un motivo caro a Cipriano, che nell’Ad Demetrianum fornisce una delle descrizioni più impressionanti del tramonto di un mondo infiacchito e privo ormai di «quel vigore e quella forza sui quali prima poggiava». A differenza dei suoi contemporanei pagani, impegnati a elaborare sistemi di periodizzazione in cui la vecchiezza dell’impero è riscattata da più o meno improbabili ringiovanimenti, il vescovo non esita però a riconoscere in questo vacillare i turbamenti degli ultimi giorni.
È questa la prospettiva escatologica – e a tratti francamente apocalittica – che innerva l’intero trattato e diviene protagonista dell’invocazione conclusiva: i cristiani sono chiamati a fare esodo da questo mondo, «che ormai sta crollando sotto la spinta delle tempeste dei mali che l’assalgono». È, in fondo, la proiezione ultramondana della figura della diserzione, in cui si manifesta un pensiero dell’alterità tipico del Cristianesimo delle persecuzioni, a sessant’anni dall’editto di Milano. Ed è così che, in un inaspettato squarcio rudeliano, la pestilenza può diventare un «vento favorevole» che accelera la fine del vecchio mondo e saluta l’approdo dei giusti nel Regno.
https://ilmanifesto.it/sezioni/alias-domenica




