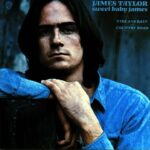
James Taylor – Fire and Rain
4 Settembre 2025
Siena: Anatomia di una crisi annunciata. Il fallimento di un modello turistico
4 Settembre 2025La provincia di Siena tra crisi industriale e nuove sfide: note a margine delle riflessioni di D’Ercole (CGIL)
Sono considerazioni a margine di quanto osservato da D’Ercole della CGIL di Siena. La provincia rappresenta un microcosmo emblematico della Toscana industriale: per lungo tempo fondata sul terziario alto – banche, università, turismo – aveva conosciuto negli ultimi decenni uno sviluppo manifatturiero diffuso, specie in Valdelsa e Val di Chiana. Oggi questo equilibrio si è spezzato e il rischio è quello di un ritorno forzato a un modello pre-industriale, in un contesto in cui però anche il terziario non ha più la solidità di un tempo. La riduzione del Monte dei Paschi, le difficoltà dell’università, l’instabilità del turismo producono un impoverimento complessivo della struttura economica senese.
La crisi non colpisce in modo casuale. A soffrire sono soprattutto le aziende a media intensità tecnologica, schiacciate tra la concorrenza dei paesi a basso costo e l’impossibilità di competere con i poli dell’alta tecnologia. È la versione territoriale della cosiddetta “trappola del reddito medio”: Siena non è abbastanza economica per competere sui prezzi, né abbastanza specializzata per giocare la partita dell’innovazione avanzata. Così si apre un vuoto produttivo, dove restano solo nicchie artigianali di pregio o filiere marginali, incapaci di assorbire in modo significativo manodopera e competenze.
I 26.000 lavoratori in cassa integrazione non sono solo un dato statistico: incarnano un patrimonio di saperi che rischia di disperdersi. Una volta che questa “memoria industriale” si spezza, ricostruirla diventa immensamente più difficile. È il nodo cruciale della reindustrializzazione: non si tratta soltanto di attrarre nuove imprese, ma di preservare e trasformare il capitale umano già presente.
C’è poi la questione dell’autonomia decisionale. Molte aziende del territorio sono filiali di gruppi nazionali o multinazionali che decidono altrove, spesso seguendo logiche finanziarie estranee al contesto locale. È una forma di colonizzazione economica che priva Siena della capacità di incidere sulle proprie traiettorie produttive.
Dentro questo quadro si colloca anche la variabile Monte dei Paschi. La banca sembra avviata su un percorso di risanamento, con bilanci più solidi e una reputazione in parte recuperata. Ma la domanda è se – e come – questa ripresa si tradurrà in effetti concreti per la città e la Toscana. I centri decisionali oscillano ormai tra Milano e Roma, e le strategie non hanno più il radicamento territoriale che caratterizzava l’istituto nel Novecento. Il rischio è che il Monte diventi una banca come le altre, utile agli equilibri della finanza nazionale ma neutrale rispetto al tessuto economico e culturale senese. Anche in questo caso ritorna il tema della dipendenza da decisioni esterne.
La vicenda della Beko, poi si inserisce precisamente in questo contesto. Parlare di reindustrializzazione dopo la crisi non può significare solo sostituire un’impresa con un’altra: sarebbe un’operazione destinata a riprodurre le stesse fragilità. Occorre invece immaginare un progetto che parta dal patrimonio di competenze presenti sul territorio, costruisca nuove filiere produttive capaci di radicarsi localmente e favorisca il dialogo con università e centri di ricerca. La crisi Beko mostra come il problema non sia episodico, ma strutturale: o si imbocca la strada di una reindustrializzazione che tenga conto della “trappola del reddito medio” e della dipendenza da centri decisionali esterni, oppure Siena rischia di restare schiacciata tra un terziario impoverito e un’industria fragile.
Le istituzioni locali e regionali si trovano così in una posizione ambigua. Hanno il compito di gestire le crisi, ma non possiedono gli strumenti reali per intervenire su dinamiche globali. La Regione può convocare tavoli, il Comune accompagnare i lavoratori, ma l’efficacia rimane limitata. Questa impotenza rischia di diventare un alibi per l’inazione, quando invece servirebbero strategie nuove: politiche industriali mirate, incubatori locali di innovazione, un legame più forte tra università, ricerca e manifattura.





