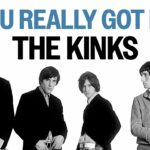
The Kinks – You Really Got Me
7 Ottobre 2025
Il delitto della tassista di Castellina: ventotto anni di indagini e nessun colpevole
7 Ottobre 2025L’intervista al Ministro della Cultura Alessandro Giuli pubblicata di recente offre uno spaccato emblematico di un approccio alla cultura che privilegia l’evocazione identitaria rispetto alla concretezza progettuale. Dietro un linguaggio colto e riferimenti storici prestigiosi, emergono contraddizioni evidenti e una preoccupante vaghezza programmatica.
La cultura “libera” che deve essere “di destra”
La contraddizione più stridente appare già nelle prime risposte. Giuli afferma con sicurezza che “le arti sono il contrario del luogo comune, sono agoni di libertà di pensiero”, per poi immediatamente rivendicare la necessità di far esprimere “una classe dirigente di destra, giovane, competente, meritevole, anche in campo culturale”.
Se il merito parla da sé, come lui stesso conclude, perché serve questa premessa politica? L’ossimoro è evidente: o la cultura è libera e il merito è l’unico criterio, oppure si ammette che esistono logiche di appartenenza politica. La formula “poi a parlare sarà il merito” suona come un’assoluzione preventiva: qualunque nomina potrà essere giustificata con l’appartenenza politica, liquidando le critiche come “strumentalizzazioni”.
L’identità come fine, non come mezzo
L’intervista è costellata di riferimenti all’identità nazionale, al “genio del luogo”, alla “gens antiquissima Italiae”. L’Umbria diventa “omphalos”, ombelico dell’Italia antica, terra che “ha il sacro nel proprio destino”. Tutto molto suggestivo, certo. Ma cosa significa concretamente?
La cultura viene trattata come un patrimonio da custodire e celebrare, non come un organismo vivo da far crescere. Manca completamente una visione della cultura come strumento per creare lavoro qualificato, stimolare creatività contemporanea, educare le nuove generazioni, rendere i musei accessibili a tutti. La tutela diventa l’obiettivo, quando dovrebbe essere solo la premessa.
I numeri che non convincono
Quando si passa dalle evocazioni ai numeri, le cose non migliorano. Il Piano Olivetti avrebbe “oltre 58 milioni di euro” per “periferie e aree svantaggiate”. Sembra tanto, finché non si pensa che dovrebbero coprire l’intera Italia. Quanti progetti concreti? Con quali criteri di selezione? Con quali risultati misurabili? Nessuna risposta.
Per la “Terza pagina” dei giornali cartacei: 10 milioni di euro. È la soluzione alla crisi dell’editoria? Un cerotto su un’emorragia. Perché privilegiare un formato in declino invece di ripensare radicalmente l’informazione culturale nell’era digitale?
Per i borghi: 420 milioni del PNRR divisi in 21 progetti pilota. Circa 20 milioni per regione per “evitare la fuga dei giovani” e “trasformarli da luoghi della memoria in attrattori di lavoro”. È realistico pensare che questa cifra, spalmata su decine di borghi, possa invertire tendenze demografiche ed economiche strutturali? Senza dati su occupazione creata, servizi effettivamente implementati, giovani effettivamente trattenuti, sono solo promesse.
Le evasioni strategiche
Alcune risposte brillano per la loro capacità di eludere le domande concrete.
Sui magazzini dei musei: la domanda era chiara – cosa fare per valorizzare i tesori nascosti nei depositi? Giuli parla dei Bronzi portati a Berlino, del museo a San Casciano, della filosofia “dalla periferia all’impero delle periferie”. Zero parole sui depositi, sulle opere che giacciono inaccessibili.
Sulla biga etrusca di Monteleone: dopo oltre un secolo al Metropolitan, Giuli parla di “dialogo serrato e costruttivo”, di “nuove evidenze presentate”, ma ammette che è “una questione non facile da sciogliere, che richiede ancora molto lavoro”. Traduzione: nulla di fatto. Il linguaggio diplomatico maschera l’assenza di progressi concreti.
Sul Tax Credit: si cita una “riforma” senza spiegare in cosa consista, quali problemi del sistema precedente affronti, che impatto abbia avuto sul settore. È una riforma solo perché la chiamiamo così?
Quello che manca: il presente e il futuro
L’intervista è intrisa di passato – Romano, Etrusco, Umbro, Francescano – ma il presente e il futuro della cultura italiana sono quasi assenti.
Dove sono le politiche per:
- Gli artisti contemporanei che faticano a vivere del proprio lavoro?
- I teatri indipendenti che chiudono?
- L’accessibilità economica ai musei per le fasce più deboli?
- La digitalizzazione del patrimonio?
- L’educazione artistica nelle scuole, sistematicamente tagliata?
- Il sostegno alla creatività under 35?
- La parità di genere nelle direzioni museali e nelle commissioni?
Di tutto questo, silenzio. Come se la cultura italiana si esaurisse nella conservazione del passato glorioso e nella rivendicazione identitaria.
La diplomazia culturale: strumento o autocelebrazione?
Giuli parla della diplomazia culturale “in coerenza col Piano Mattei” verso i paesi del Mediterraneo. Nobile proposito. Ma in cosa consiste? Prestiti di opere? Mostre itineranti? Collaborazioni con istituzioni estere? Formazione? Scambi? L’assenza di dettagli fa sospettare che si tratti più di una formula politica che di un programma strutturato.
Conclusione: la retorica non è politica culturale
Questa intervista rappresenta plasticamente un approccio alla cultura che confonde la forma con la sostanza. Un linguaggio colto e altisonante, riferimenti storici prestigiosi, evocazioni identitarie sostituiscono l’analisi dei problemi concreti del settore e la presentazione di soluzioni misurabili.
La cultura italiana ha bisogno di politiche, non di retorica. Ha bisogno di investimenti strutturali, non di elemosine. Ha bisogno di una visione che guardi al futuro, non solo al passato. Ha bisogno di trasparenza sui criteri di selezione, sui risultati ottenuti, sugli errori commessi.
Soprattutto, ha bisogno di smettere di essere trattata come un patrimonio inerte da celebrare e iniziare a essere considerata come un ecosistema vivente da far fiorire. Perché la cultura non è solo identità: è anche innovazione, sperimentazione, critica, libertà di pensiero. Quelle stesse “agoni di libertà” che Giuli evoca nelle parole, ma che le sue politiche sembrano troppo spesso dimenticare nei fatti.




