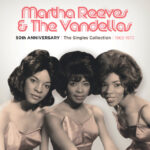La Maddalena, Giuditta e Oloferne, i pulpiti in San Lorenzo oppure il Crocifisso in Santa Croce sono tracce idelebili della sua forza espressiva che ha segnato il Quattrocento. Molti pensano che sia stato il più grande di tutti, anche Michelangelo temeva il confronto. A Firenze la quasi totalità delle sue opere
di SERGIO RISALITI
A Firenze si conservano la quasi totalità delle opere di Donato di Niccolò di Betto Bardi ( 1386- 1466), conosciuto come Donatello. Solo Beato Angelico, Botticelli e Michelangelo vantano lo stesso record. Altrettanto non possiamo dire di Giotto o Leonardo. Ci starebbe una card speciale per visitare tutti i luoghi in cui risplende il suo genio artistico. E vi assicuro che non sarebbe sufficiente una settimana. Il primo giorno potremmo recarci al Museo Nazionale del Bargello per ammirare le sue opere giovanili come il David in marmo e quello in bronzo, il San Giorgio e Athys, per poi salire l’indomani in Palazzo Vecchio dove si trova la Giuditta con Oloferne, uno dei suoi ultimi capolavori anch’essa in bronzo. Nei giorni a seguire ci sposteremmo in San Lorenzo e poi in Santa Croce e qui scopriremmo il San Ludovico di Tolosa (in origine in una delle nicchie di Orsanmichele), l’elegantissima Annunciazione e il drammaticissimo Crocifisso ligneo. La nostra maratona proseguirebbe poi al Museo dell’Opera del Duomo, dove Donatello la fa da padrone, in Battistero e Cattedrale, per magari terminare al Museo Stefano Bardini, dove a sorprenderci sarà la Madonna dei Cordai, frutto di libera sperimentazione su materiali diversi. Al suo tempo Donatello ebbe un ruolo assoluto nella scultura monumentale; ce lo ricordano una serie di copie posizionate negli spazi pubblici come quelle del Marzocco e della già citata Giuditta in Piazza Signoria, o quelle dei profeti, tra i quali il Profeta Imberbe ( con il volto forse di Brunelleschi) e il celebre Abacuc — meglio conosciuto come lo Zuccone, al quale Donatello, si racconta, chiedeva di parlare: “ Favella, favella, che ti venga il cacasangue!” — oggi installati nelle nicchie del campanile di Giotto dove a suo tempo vivevano gli originali, conservati oramai al museo dell’Opera del Duomo.
Ma chi era questo gigante del quattrocento? In molti ritengono che sia stato il più grande di tutti.Perfino Michelangelo temeva il confronto con Donato e quando gli veniva chiesto un parere sulle opere del suo antagonista, rispondeva che, guardandole da vicino, se ne scoprivano molti difetti. Ma quei difetti sono apparsi nei secoli successivi dei pregi, una somma di qualità espressive cui Donatello sottometteva ogni scelta formale. A lui premeva la possibilità di comunicare sentimenti, emozioni, caratteri incontrati nella realtà, tra le case e le strade, per poi innalzare il tutto a significato universale. Prendete ad esempio uno delle sue più ammirate creazioni, la Maddalena, esposta nel bellissimo Museo dell’Opera del Duomo. Se quest’opera venisse presentata in una sala vuota del MoMa di New York o della Tate di Londra si lascerebbe alle spalle ogni scultura contemporanea e milioni di visitatori ne resterebbero scioccati. Mi chiedo sempre se Donatello abbia preso a modello una alienata o unavecchia prostituta abbandonata da tutti nella miseria e nella solitudine, con i denti radi, ammantata dalla sua stopposa criniera lunga fino ai piedi, arsa dal digiuno, svuotata dal rimorso. Camille Paglia, autorevole storica dell’arte americana, la descrive in questi termini: « Ha gli occhi sgranati e incavati nelle orbite, e la bocca è aperta, a causa della demenza o del trauma. I muscoli del naso sono tesi e ritratti, come se stesse soffocando i singhiozzi o fosse respinta da un cattivo odore, lo stesso “ puzzo di mortalità” che affligge anche Amleto. Il cranio, come un memento mori, emerge dalle guance infossate. Il digiuno le ha consumato le curve femminili… Maria è una paria, un’intoccabile che prova e suscita disgusto. È stata ridotta a un’esistenza animalesca, come appare dal piede che afferra il margine della roccia come gli artigli di un orso » . Merita soffermarsi su quel volto stremato, tutto pelle eossa, e quel corpo come un arbusto rinsecchito. Dove è finita la beltà della donna rinascimentale? Per intendersi quella di certe Madonne di gusto lirico e raffinato come quelle dei Della Robbia o di Desiderio da Settignano? Nel suo mutismo spettrale, la Maddalena incarna la repulsione per il corpo femminile disfatto dall’età. È veramente un memento mori, vuole rammentarci ancora oggi che la bellezza sfiorisce e che la sensualità in arte non serve per avvicinarsi a Dio.
Una furia espressiva travolse il vecchio Donatello. Prova ne sono i due pulpiti in San Lorenzo elaborati dallo scultore dopo il 1461, quando l’artista era ormai stanco e malato. Gli restava come amico Cosimo il Vecchio, per cui aveva lavorato molte volte nel passato. Scrive Vasari: « Servitore et amico della casa de’ Medici, visse lieto e senza pensieri tutto il restante della sua vita, ancora che conduttosi ad 83 anni, si trovasse tanto parletico che e’ non potesse più lavorare in maniera alcuna, e si conducesse a starsi nel letto continovamente, in una povera casetta che aveva nella via del Cocomero, vicino alle monache di San Niccolò. Dove peggiorando di giorno in giorno, e consumandosi a poco a poco, si morì il dì 13 di dicembre 1466 » . Il Pulpito della Passione e quello della Resurrezione rappresentano il testamento artistico e spirituale di Donatello, ancorché siano stati rinettati da Bertoldo di Giovanni e Bartolomeo Bellano. Qui Donatello raggiunse un livello di trasgressione formale e concettuale senza precedenti. Mentre Gesù prega e suda sangue nell’orto degli Ulivi, i discepoli dormono « immersi in una specie di ottuso abbandono animale » ; sono figure di dormienti esausti, « trascinati nell’abisso dell’incoscienza come da un peso mortale… volti accecati e deformati dal sonno, bocche semichiuse, teste reclinate che l’ombra sembra inghiottire per sempre » , come ha scritto Antonio Paolucci. Nella Resurrezione, Gesù Cristo non appare come il vincitore della morte, quanto piuttosto nella posa e nelle vesti stracciate di un derelitto, di un sopravvissuto, « appena uscito da un campo di concentramento » ( J. Pope- Hennessy). In altre scene prevalgono moti ondosi e convulsi di personaggi ora drammatici ora grotteschi, mirabolanti costruzioni prospettiche, irruzione di figure atletiche di una bellezza greve, barbara, strisciate di luce e violenti affossamenti di ombre profonde; e poi grumi di materia simili a carne macinata e superfici scavate con ferite e scarnificazioni. Il Martirio di San Lorenzo, datato 15 giugno 1465, è di un’avanguardia senza tempo. La figura del santo tra le fiamme è raffigurata come già de- strutturata. Le braccia sono moncherini, il tronco dell’uomo si sta sgretolando, la faccia è resa mostruosa dalla furia del fuoco che si mangia la carne. Siamo a un passo dall’informe. La materia è trattata in modo da infrangere la rassomiglianza figurativa a favore dell’effetto espressivo. Secoli dopo, la violenza più oscura e terribile occuperà il posto della grazia e dell’armonia in arte. Verranno allora i dipinti di Goya e di Géricault, gli “ urli” di Munch, le opere brutali di Bacon, le tele bruciate di Burri. E pensare che Donatello, vent’anni prima, aveva immaginato la bellezza più seducente nelle fattezze di un David appena adolescente. Il corpo è androgino, pare quello di un ragazzino di borgata come quelli adorati da Pasolini. La grazia qui è duplice: è quella delle forme ( si notino i fianchi, il petto e il ventre, la schiena, i glutei e i polpacci) ed è pure quella infusa da Dio nel cuore del piccolo pastorello che pare riaversi dopo il furore, posare lo sguardo in basso quasi turbato dall’orrido trofeo, la testa mozzata di Golia. Se in Michelangelo la bellezza fisica è riflesso di una matrice divina, figlia di un sogno, immaginazione ideale, ecco che in Donatello è, al pari della deformità, della bruttezza, qualcosa che si trova per strada, palcoscenico di virtù e di bassezze, del bene e del male, della dolcezza e della brutalità. Secondo Carlo Del Bravo, in Donatello si rispecchia una concezione plotiniana secondo cui l’armonia universale comprende anche il brutto, grossolani contadini, goffe e incompiute nature, violenzae disfacimento. Una prova di amorosa compassione per ogni aspetto e forma di vita.
Guardate il Crocifisso ligneo conservato in Santa Croce. La storia di quest’opera — realizzata forse nel 1430 per i francescani di quella basilica — ci viene narrata nelle Vite del Vasari: « Fece con straordinaria fatica un crucifisso di legno, il quale quando ebbe finito, parendogli aver fatto una cosa rarissima, lo mostrò a Filippo di ser Brunellesco suo amicissimo, per averne il parere suo » . Brunelleschi rispose che « gli pareva che egli avesse messo in croce un contadino e non un corpo simile a Gesù Cristo » . Infatti Il corpo dell’Unigenito si mostra senza nulla di miracoloso, anzi è « privo di un decoro umano » e perfino dello « splendore celeste » , come argomenta Tertulliano. Ma è proprio questa umanità aggravata da sofferenza e deformità di contadino e condannato a morte a rendere manifesto il progetto divino sull’umanità, quello della redenzione. Il Crocifisso di Donatello è il Dio vivente che opera da “ contadino” e che semina il bene; è l’artigiano della salvezza che forgia l’uomo nuovo attraverso l’esperienza del dolore e della morte, della fatica e del sudore. Potremmo affermare che la critica di Brunelleschi verte dunque su questo: per l’architetto e ingegnere il linguaggio dell’amico scultore era fin troppo popolare, antitetico al suo idealismo matematico. Per Donato la rivelazione del progetto divino (oggi diremmo il senso dell’esserci) è storicamente calata nella storia, e la storia è lotta di classe, di uomini che faticano e soffrono per mutare il tracciato e indirizzare la società verso il bene e la giustizia.
Giorgio Vasari conclude il ritratto di Donatello facendoci sapere che l’artista «era liberalissimo, amorevole e cortese, e per gl’amici migliore che per sé medesimo » , che mai stimò danari « tenendo quegli in una sporta con una fune al palco appiccati, onde ogni suo lavorante et amico pigliava il suo bisogno, senza dirgli nulla » . Sul letto di morte sorprese i suoi parenti cui non lasciò nulla, neppure un podere di sua proprietà. « Io non posso compiacervi, parenti miei, perché io voglio, e così mi pare ragionevole, lasciarlo al contadino che l’ha sempre lavorato e vi ha durato fatica; e non a voi, che senza avergli mai fatto utile nessuno, ne altro che pensar d’averlo, vorreste con questa vostra visita che io ve lo lasciassi; andate, che siate benedetti » . Come a dire che più della fede servono le opere.