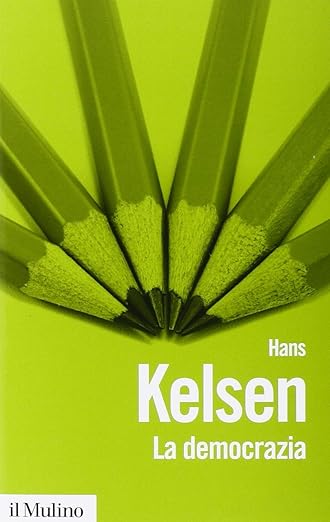Digest Strategico, 18 novembre 2025
18 Novembre 2025
L’ILLUSIONE DELLA MANOVELLA
18 Novembre 2025
«La notte è piccola per noi» oggi risuona come un ritornello leggero, ma dentro quella frase si nascondeva un modo di stare al mondo: attraversare il buio insieme, senza mai smarrire il passo dell’altra. La scelta finale di Alice ed Ellen Kessler — da accogliere senza giudizi, perché tocca zone che non appartengono a nessuno di noi — è solo il compimento coerente di una fedeltà che ha preceduto e superato la fama, la televisione, la memoria stessa del pubblico.
Non erano semplicemente simili. Erano contigue: due lati di un’identità che non aveva voglia di farsi dividere. Vivevano in appartamenti separati ma comunicanti, come se la vita avesse voluto insistere su un confine simbolico che loro, con naturalezza, attraversavano ogni giorno. Il famoso sincronismo delle loro esibizioni non era un esercizio di stile: era la manifestazione esteriore di un ritmo interiore, nato prima del palcoscenico e rimasto sempre lì, intatto.
Quando apparvero nei televisori degli italiani, lo stupore non derivava dai costumi o dalla coreografia. Era la sensazione, quasi istintiva, che quelle due presenze sfidassero l’idea stessa di identità individuale. Ricordavano la figura mitica dell’androgino platonico: un essere unico, spezzato in due, che passa la vita a cercare la propria metà. Le Kessler non hanno dovuto cercarla. L’avevano accanto, e forse proprio per questo la distinzione tra “io” e “noi” è rimasta incerta, inafferrabile.
L’ultimo gesto — le ceneri unite, l’idea di ricomporsi — non è romanticismo. È un atto di coerenza ontologica: ciò che la nascita aveva separato, la morte lo restituisce alla sua forma primigenia.
Non stupisce che Loretta e Daniela Goggi, sorelle legatissime e spesso paragonate a loro, abbiano reagito con sgomento e ammirazione. Perché certi legami estremi pongono domande scomode: dove finisce l’amore e dove inizia la dipendenza? E siamo sicuri che esista davvero una linea chiara? Le Goggi lo dicono senza retorica: ci sono rapporti che non sono solo consanguineità o affetto, ma una sorta di destino condiviso. Un patto esistenziale che non si sceglie una volta per tutte, ma si rinnova ogni giorno.
In un’epoca che celebra l’individualità come cifra assoluta della libertà, le Kessler hanno rappresentato una possibilità diversa: che la costruzione di sé possa avvenire anche in coppia, e che l’identità non sia sempre una solitudine, ma talvolta una risonanza. La loro storia — brillante, disciplinata, sempre rispettosa del pubblico e del proprio mestiere — ha avuto come filo segreto questa unità profonda, che oggi si mostra per ciò che è sempre stata: inscindibile.
La loro morte non insegna nulla in senso diretto. Non propone modelli, non chiede imitazione. Ma lascia una domanda che pesa più di qualsiasi commemorazione: è possibile essere davvero uno, senza essere almeno in parte due?
Forse l’unica risposta è questa: alcune vite hanno senso soltanto nella forma doppia in cui sono venute al mondo. E quando il viaggio finisce, ritornano alla loro unità originaria. Due passi in perfetta sintonia, fino all’ultimo tratto di notte.
Una storia che, nell’istante in cui si chiude, torna intera.