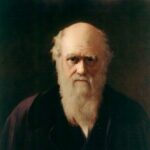Il primo ad accorgersene fu Lev Trotzkij, dietro le lenti ovali e la montatura leggera degli occhiali con cui scrutava la rivoluzione. Era in corso una riunione del Politbjuro nel pomeriggio bolscevico del Cremlino, stava parlando Kamenev quando Lenin si alzò per consegnare a qualcuno tra i compagni un biglietto ripiegato con una domanda, come faceva spesso, tentando di svolgere due lavori in uno. Solo che mentre era in piedi, col braccio destro proteso, vacillò per un breve momento, sospeso, come se stesse compiendo un mezzo giro su se stesso: un istante nel nulla, prima di riprendere immediatamente il controllo.

quando alzò lo sguardo, Trotzkij rimase colpito dall’espressione del volto: «Era completamente cambiata», come se in quell’attimo Vladimir Ilic avesse colto un avvertimento del vuoto, e lo smarrimento nel buio gli fosse rimasto nel fondo degli occhi. Aveva intravisto il varco tra il potere e la fine: e forse non era nemmeno il primo segnale. Inquieto per quell’attimo che in silenzio aveva violato il segreto più intimo del Cremlino, Lev Davidovic non disse nulla ma recuperò nella memoria un’immagine notturna del primo congresso del Komintern nel 1919, che adesso diventava un allarme: Ilic seduto esausto, «lo sguardo stanco, la voce irregolare a sbalzi, e il sorriso di uomo malato».
La rivoluzione non lo sapeva, rassicurata dalla presenza costante del suo Capo nel Cremlino, tranquillizzata dal suo sforzo continuo di volontà, confortata da una capacità di lavoro ostinata, inseguendo affannosamente il tempo che continuava a sfuggire. Voleva vedere tutto, controllare l’impossibile, essere informato di ogni cosa.
Scriveva, dettava, leggeva, presiedeva le riunioni, riceveva gli ospiti, preparava a penna la traccia dei discorsi. I bolscevichi lo vedevano concentrato, attento, pignolo, identico a se stesso, con gli stessi gesti di sempre e tutto il futuro davanti. Anzi, il futuro ideologizzandosi stava diventando avvenire, anche grazie alla repressione violenta della Ceka, cui ora un decreto concedeva mano libera nel terrore bolscevico, col potere di giustiziare i cospiratori controrivoluzionari e di avviare la deportazione nei lager, i campi di concentramento che presto diventeranno il Gulag sovietico.
La storia era stata prima smossa, poi messa sotto controllo, e adesso il tempo sembrava scorrere solo in una direzione, guidato e sorvegliato dal nuovo Dio terribile, il partito. E invece proprio il Capo di quel partito portava dentro di sé in silenzio tutti i segni di un logoramento imprevisto, che ogni giorno tornava ad annunciarsi come una conferma, e sembrava avvicinarsi sempre più al punto di rottura.
Insonnia, prima di tutto, maledetta ogni notte quando arrivava puntuale a negargli il riposo; quel mal di testa continuo, non un’emicrania ma una tenaglia, una cappa; la parola che s’inciampava all’improvviso, qualche volta, sporgendolo nel vuoto durante un discorso; soprattutto la spossatezza alla fine della giornata, quando gli capitava di cenare solo con una tazza di latte camminando nella cucina, dopo che era rimasto seduto fin dal mattino, una riunione dopo l’altra.
Qualche volta Nadezda gli sentiva il polso, quando lo trovava pallido, affilato, quasi trasparente, o al contrario col volto stordito da un rossore improvviso. Ma lui misurava gli altri indicatori di quel malessere che lo circondava, e che stava imparando a conoscere proprio dagli annunci: una nuova irritabilità, gli scatti nervosi improvvisi, gli sbalzi continui d’umore, forse persino un principio di depressione e lo sfinimento di una stanchezza inconcepibile quando correva sui pattini a Cracovia, camminava nei boschi in Svizzera, pedalava la domenica in Francia, remava nelle curve ampie del Volga, dove il gran fiume rallentava placido.

Scoprì di colpo una sua sconosciuta debolezza psicologica: non parlava a nessuno della sua salute, come se l’emicrania potesse tradursi in politica, minacciando di indebolire la sua leadership. Ecco la novità, aveva un nemico in più, dentro se stesso. Covando il male che dissimulava, capì che era geloso del potere e più ancora del ruolo indiscusso che la rivoluzione gli aveva attribuito, che le Guardie Rosse proteggevano, ma che il suo corpo avvertiva di non poter reggere con quei ritmi, quella pressione, quella fatica. Aveva paura di perdere il controllo appena conquistato dei Soviet, del partito, del Komintern, del governo, della Russia, una piramide che convergeva sulla sua figura.
Il corpo: Nadezda ricordava la vitalità dei primi anni, quando Ilic passeggiava nella campagna finché non trovava un pagliaio dove stendersi a leggere. O la sveglia col buio, lui già pronto coi pantaloni di cuoio e il cane Genca che fremeva per andare sulle isole siberiane a caccia delle lepri bianche col pelo invernale, oppure l’alba con gli stivali di feltro a vedere i pesci sotto il ghiaccio limpido del fiume gelato.

O ancora Lenin giovane e pieno d’energia nel marzo 1900 quando finì la deportazione nel villaggio di Susenkoe, e viaggiarono in slitta di giorno e anche di notte sotto la luna: lui a un certo punto si tolse addirittura la docha, il mantello di lana e pelliccia, perché nell’eccitazione della libertà gli sembrava di non sentire più il freddo, mentre lanciava i cavalli a briglia sciolta dentro il secolo nuovo.
Come un esorcismo bolscevico Marija, la sorella, ricordava continuamente che Vladimir Ilic in gioventù era un uomo robusto, raramente malato ad eccezione di quei due anni — il 1892 e il 1893 — in cui dovette fronteggiare prima la febbre tifoidea e poi la malaria. Per il resto, vita sana, favorita dalla pignoleria delle abitudini (pranzo e cena sempre all’ora fissa) e da un vitto casalingo, dove non mancava la carne, magari fritta.
Quando diventò sovversivo a San Pietroburgo, saltarono tutte le regole e anche le manie, cominciò un’esistenza irregolare, pasti compresi. Arrivò subito la gastrite, che lo avrebbe accompagnato fino alla fine. La lontananza dalla Russia, la sensazione di essere costretto a vivere al buio «in uno stagno paludoso», i congressi in esilio, le discussioni, le liti, le scissioni e l’impotenza: tutto agiva sui nervi, sul morale, sul mal di stomaco, col risultato dell’insonnia, della perdita di peso, dell’emicrania, tanto che la madre Marija Aleksandrovna si allarmò nell’ultimo incontro in Svezia, abbracciando quell’uomo macilento, invecchiato da giovane.
Lenin stava imparando ad ascoltare il suo corpo, anzi a scrutarlo, quasi spiandolo. Proprio lui che lo considerava un semplice strumento rivoluzionario, un meccanismo da tenere in esercizio esattamente per questo fine, come aveva fatto ogni giorno con la ginnastica quand’era finito in prigione. Questa consegna integrale del corpo alla causa arrivava persino alle soglie dello spossessamento, quasi che i bolscevichi dovessero rendere conto della manutenzione del loro fisico al partito, padrone supremo non solo dei destini collettivi, ma anche della macchina corporale della persona, come un bene materiale concesso soltanto in usufrutto all’individuo, perché la vera missione è metafisica.

La malattia diventava dunque ideologia, e l’inabilità veniva giudicata come un’incuria, la convalescenza quasi una colpa perché sottraeva energia all’azione politica. Se un compagno si lamentava per un malessere, Lenin rispondeva tra l’ironia e il rimprovero: «Ringraziate di non finire sotto processo per aver trascurato un bene dello Stato, cioè voi stesso». Ma Vladimir Ilic usava quel medesimo tono anche in famiglia.
Quando nel 1919 venne a sapere da Molotov che Nadezda aveva avuto un attacco di cuore le inviò una sorta di richiamo politico ufficiale, da capo-partito più che da marito: «Ti sei affaticata troppo. Devi attenerti rigorosamente alle regole e rispettare assolutamente gli ordini, altrimenti non sarai in grado di lavorare il prossimo inverno. Non dimenticarlo».
E il partito decideva anche le misure mediche, la pausa per le cure, il periodo di riposo, il tempo della riabilitazione, la “licenza” per recuperare le forze. Nemmeno i membri del Comitato Centrale, neanche i leader del Politbjuro potevano decidere autonomamente di assentarsi dal lavoro rivoluzionario. Trotzkij nella primavera del 1920 su pressione dei medici ottiene dalla segreteria del Comitato Centrale un permesso di due mesi, per riprendere le energie prosciugate dagli anni passati correndo per più di centomila chilometri tra il fronte di guerra e la retrovia, sul suo treno di presidente del Consiglio di Guerra Rivoluzionario: visitando l’Armata, arringando i disertori per convertirli alla rivoluzione, dettando i manifesti alla tipografia di bordo che stampava un giornale e viaggiava con lui, insieme con la stazione radiomobile, una sala da gioco, la rimessa per l’ambulanza e una biblioteca itinerante.
All’Orgbjuro, la centrale organizzativa del partito, scrive anche Lenin l’8 luglio del 1921 spinto dai dottori, chiedendo il permesso per un mese di licenza da trascorrere nel riposo della dacia di Gorkij. Nel cammino della rivoluzione irrompe “baliesn”, la malattia, come sarà chiamata per due anni e mezzo prima nei sussurri e poi nei calcoli del vertice bolscevico che adesso è ipnotizzato dalla notizia. Lenin è malato, al punto da doversi fermare. Esce dal Cremlino, passa nelle mani dei medici. È altrove. Ha bisogno di cure. Dunque non è invulnerabile. E poi?
Un’ombra passò sull’anno quarto dalla presa bolscevica del potere. Vladimir Ilic l’aveva immaginata, e aveva cercato di esorcizzare il male nascondendolo. Ma lo aveva solo spostato nel tempo, celandolo dietro la sua immagine scolpita, modellata, fotografata, dipinta dovunque come il simbolo del nuovo potere sovietico, spodestando i ritratti dello Zar esiliati nelle icone superstiti: Lenin col colbacco mentre si sporge da una tribuna, proteso in avanti su un palco, circondato dalle bandiere rosse, col braccio destro sollevato in alto e l’indice puntato, col berretto a visiera e la mano sinistra che afferra il bordo della giacca, con lo sguardo abbassato sulla Pravda.
Ma ora, dopo il fisico, la malattia attaccava il lavoro: Vladimir Ilic non riusciva più a concentrarsi, a rianimarsi dalla stanchezza che sembrava perenne. Doveva arrendersi, se voleva continuare a combattere. Sapeva che i pettegolezzi erano inevitabili, non poteva fermarli, l’unica difesa era una gestione molto riservata della sua infermità: che peraltro non aveva un nome ufficiale dunque restava impronunciabile come un’eresia, circondata dal mistero del potere. Certo, a Ilic venivano in mente tutti i travagli e tutti gli affanni incontrati sulla strada della rivoluzione vittoriosa, le resistenze dei cosacchi, la carestia, la battaglia coi Bianchi, la contraddizione vivente della Nep, il milione di disoccupati, i prezzi di frutta e verdura cresciuti quasi del 60 per cento rispetto al 1913, i primi contrasti dentro il Politbjuro: ecco il catalogo dei tormenti.
Ma non solo. Quell’attentato social-rivoluzionario, con la pallottola avvelenata penetrata nel corpo fino al collo come un messaggero del male e Nadezda disperata quando lo spogliavano, pieno di sangue. E ancor più nell’intimo, l’altra ferita per la morte di Inessa Armand, la rivoluzionaria francese dagli occhi verdi che aveva vissuto accanto a Lenin e alla moglie a Berna, a Cracovia, a Parigi, aveva vagabondato con loro la domenica nei boschi, aveva viaggiato nello stesso scompartimento sul “treno blindato” che li riconduceva in Russia allo scoppio della rivoluzione, per poi seguire a Mosca il governo: ottenendo una casa in via Neglinaja, vicino al Cremlino e dunque a Ilic, con l’installazione immediata di uno dei primi telefoni automatici della capitale, senza più dover passare dal centralino per ogni chiamata, soprattutto per quella che più le stava a cuore.
L’unica donna tra i rivoluzionari a cui Lenin dava del “tu”, riservando il “voi” a tutti gli altri. Probabilmente l’unica donna che amò, mentre Nadezda era la compagna — in tutti i sensi — della sua vita. Un rapporto politico, intellettuale e sentimentale che finì solo con il viaggio di Inessa nel Caucaso nel 1920, l’assalto del colera, la morte solitaria e i funerali celebrati a Mosca con due cavalli neri che trasportavano la bara, mentre Angelica Balabanoff osservava da due passi la disperazione muta di Lenin: «Non ho mai assistito a uno strazio simile e non ho mai visto un essere così completamente assorbito dal dolore, dallo sforzo di tenerlo per sé, di sottrarlo all’attenzione altrui che avrebbe potuto diminuirne l’intensità. Non solo il volto, ma tutta la sua figura esprimeva una tale angoscia che non osai salutarlo neppure con un semplice cenno. Era evidente che voleva essere solo col suo cordoglio. Sembrava più piccolo, il berretto gli copriva il volto, gli occhi parevano annegati nelle lacrime trattenute a stento». Il giorno dopo le ceneri di Inessa Armand trovarono posto sulla piazza Rossa, accanto alle mura del Cremlino. Davanti, i gigli bianchi «per la compagna Inessa» e la firma di Vladimir Ilic Lenin.
La malattia, e l’abbandono di Inessa, consegnarono integralmente Lenin alle cure di Nadezda Krupskaja. Parlava coi medici, li convocava, seguiva attentamente le prescrizioni per le medicine e soprattutto vigilava sul riposo di Ilic, sulle ore da passare all’aria aperta, a Gorkij, dove lui poteva scrivere e lei studiava l’italiano. Con loro Marija Ilinichna Uljanova, la sorella minore di Lenin, che aveva con lui un legame molto forte e lo assistette fino alla fine. Caduto il velo della dissimulazione, in quei giorni d’estate a Gorkij Lenin dichiarava apertamente la sua inabilità. «Sono malato, non posso ricevere». «Sono infermo e stupido». «Sono stanco, me ne sto andando». «Sono così stremato che non posso far niente per salvarmi la vita».
Erano i segni del malumore tracciati dalla malattia, con l’impronta del pessimismo, il solco della depressione. L’unica volta che aveva pensato realmente alla morte, nei giorni dell’insurrezione a San Pietroburgo, si era preoccupato prima di tutto di salvare i suoi appunti, come se il lavoro dovesse comunque sopravvivergli, scrivendo a Kamenev: «Strettamente entre nous, se mi fanno fuori per favore pubblicate il mio taccuino Il marxismo e lo Stato. Si trova a Stoccolma. Copertina blu».
Adesso è diviso tra l’obbligo del riposo e la guida del partito, l’ansia per la malattia e il governo del Paese: tutto da lontano, attraverso il telefono e le lettere. Solo il male gli è sempre più vicino, addosso. A fine anno ha l’impressione di girare a vuoto nel lavoro, senza concludere nulla, e il 7 dicembre il Comitato Centrale lo congeda nuovamente, ma questa volta con l’ordine di non ricevere a Gorkij lettere, documenti, rapporti politici. Il biglietto che scrive ai membri del Bjuro è sconsolato, quasi smarrito, comunque impotente: «Parto oggi. Malgrado la diminuzione del lavoro e l’aumento del riposo, temo che non potrò presentarmi né alla Conferenza del partito, né al Congresso dei Soviet. L’insonnia è cresciuta negli ultimi giorni in modo diabolico».
Peggiora, nonostante le camminate nei boschi, le giornate all’aria aperta, il cibo controllato. Il 2 febbraio il Politbjuro gli prolunga il riposo in campagna fino all’XI congresso del partito, alla fine di marzo. Comincia a vivere la tragedia della dissociazione tra il corpo ribelle e il cervello, che segue passo passo l’agenda del governo, indirizza la politica estera, suggerisce articoli, saggi, polemiche, decreti, lettere: Lenin è come spaccato a metà, e i medici non gli danno soddisfazione, non trovano rimedi perché il male è subdolo, nascosto. Almeno ufficialmente.
Si fanno ipotesi segrete, un’equipe di ricercatori è spedita ad Astrakan per indagare sulla storia medica del padre di Ilic morto alla sua stessa età, si risale ai nonni cercando negli avi le tracce di un batterio, un vizio congenito, una debolezza ereditaria. La malattia è già diventata un’assenza, quel vuoto è un caso politico, la politica scopre i dubbi della rivoluzione sul suo futuro, e tutto si consegna al segreto di Stato che confisca diagnosi, analisi e terapie nel tabernacolo del Bjuro.
Lui intanto radunava le forze per presentarsi al congresso del partito: il 27 marzo riuscì a salire alla tribuna per aprirlo, il 2 aprile tornò per chiuderlo. I 687 delegati videro Ilic per l’ultima volta a un solenne appuntamento congressuale, con la catena dell’orologio da panciotto avvolta intorno al dito, per ricordargli la malattia mentre lui garantiva che «il movimento comunista in tutto il mondo va crescendo con fermezza, in ampiezza e in profondità».
Ma i bolscevichi venuti da tutto il Paese non potevano sapere che c’era un retropalco sanitario del congresso, con due illustri clinici tedeschi — il professor Felix Klemperer, internista berlinese e docente a Strasburgo, specialista in tubercolosi polmonare, e il dottor Otfrid Foerster, neurologo a Breslavia — portati in volo a Mosca proprio in quelle ore per un consulto risolutivo sulla malattia di Lenin.
Vengono accolti direttamente dal Commissario del popolo per la Salute Pubblica, Nikolaij Semashko, che li fa accompagnare nell’appartamento di Lenin dai suoi due assistenti, il dottor Rozanov e la dottoressa Marecka. Visita completa, controllo delle analisi, lungo interrogatorio al Capo del Cremlino. Lo scopo era conoscere e capire, ma anche tranquillizzare.
E infatti appena rientrato in Germania Klemperer fece una diagnosi benevola al New York Times: «Lenin può contare su una costituzione fisica robusta e su una forte energia, che recentemente è diminuita. Visitandolo gli abbiamo riscontrato una lieve nevrastenia, per eccesso di lavoro. Nessun segno di disturbi più seri, tanto che non è stata necessaria nessuna prescrizione medica, salvo il consiglio di concedersi una vacanza, prendendosi cura di sé». Ogni parola di conferma del male è bilanciata da un aggettivo prestante, fisico, fiducioso e confortante.
Nell’incertezza delle cause, nell’indeterminatezza della diagnosi, si estrae dal corpo di Ilic il proiettile del vecchio attentato con la sua minaccia al curaro. Ma la situazione non migliora, anzi: il 26 maggio 1922 Lenin appena si alza dal letto vacilla e deve aggrapparsi all’armadio per non cadere, ha conati di vomito, forti dolori allo stomaco. Soprattutto parla con fatica, biascicando, non riesce a muovere la gamba e il braccio destri.
La sorella Marija fa scattare l’emergenza, accorrono il Commissario Semasko, il dottor Rozanov, il fratello di Ilic, Dmitrij. Si tratta di ictus, il primo, causato dall’arteriosclerosi cerebrale. «In realtà — dirà più tardi Lenin, quando riuscirà a farsi capire — questo è un segnale d’allarme, il primo avvertimento della morte».

Stalin va a trovarlo, e lui si lamenta perché non gli permettono di leggere i giornali nel timore che le notizie politiche possano inquietarlo, ma all’inizio di agosto quando ritorna a Gorkij, Stalin lo trova «circondato da una montagna di libri e giornali. È il nostro vecchio Lenin che ti fissa con il solito sguardo scaltro, con un occhio mezzo chiuso». Ha fretta di rientrare, concorda il programma: «Torno il 2 ottobre. Il 3 riunione dalle 5 alle 9, con un quarto d’ora d’intervallo per il tè. Avvertite tutti: è vietato fumare».
Come se fosse riemerso dal buio, il 13 novembre Lenin decide di mostrarsi alla tribuna del IV Congresso della Terza Internazionale, dove parla in tedesco. Nella sala del trono, con il Capo del Cremlino tornato al suo posto sotto gli occhi del comunismo mondiale, sembra che l’iconografia bolscevica riesca a imporsi sulla malattia, sovrastandola. Ma chi lo conosce bene misura il peso della fatica di Vladimir Ilic per sembrare Lenin ad ogni costo, con quel discorso che ha lo stesso giro retorico e la postura di sempre, ma meno anima e più affanno, come se Ilic inseguisse testardamente il se stesso smarrito, senza riuscire a raggiungerlo.
«Quelli che lo vedevano per la prima volta ripetevano “è sempre lui, Lenin”. Ma a noi questa illusione non era permessa — confida Alfred Rosmer, membro del Bjuro dell’Internazionale — Non era più il Lenin di una volta, ma un uomo duramente provato dalla paralisi. Il suo aspetto era come congelato, la sua andatura quella di un automa, la sua abituale e semplice eloquenza era mutata in un eloquio esitante, e qualche volta gli mancavano le parole». Un’ora intera in piedi alla tribuna, con la voce più stridula del solito, e negli ultimi quindici minuti, mentre sul palco faceva il bilancio della partita in corso da cinque anni tra la rivoluzione e la Russia, Ilic controllava continuamente l’orologio che segnava il tempo dell’altra sua partita, quella mortale con il male.
Passò due giorni a Gorkij a metà dicembre ’22 a scrivere il discorso per il X Congresso panrusso del Soviet, dove voleva illustrare la Costituzione della nuova Urss, l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, appena nata. Il 12 rientrò a Mosca in ufficio, dove lo aspettavano riunioni fino a sera. Non poteva saperlo, ma era il suo ultimo giorno di lavoro, l’ultima notte al Cremlino. Il mattino dopo il male esce dall’ambiguità dell’autoinganno con due trombosi cerebrali che lanciano il secondo allarme. Due giorni, e si aggiunge la paralisi di un braccio e una gamba, questa volta a sinistra.
Ora il riposo deve essere assoluto, i medici disconnettono tutti i fili che collegano Lenin alla politica, disattivano attorno a lui tutti gli strumenti di governo, lo isolano con se stesso. Per Vladimir Ilic è come vivere sospeso nel vuoto: la sua mente ragiona, elabora, reagisce, propone; ma senza i giornali, i libri, gli incontri e le lettere lui non può alimentare le idee, non riesce a scambiare, non ha modo di intervenire. In quel vuoto la realtà si sottrae, gli sfugge, può pensarla ma non riesce ad abitarla.
Prova a inseguirla. Adesso può dettare, per pochi minuti ogni volta, ma si innervosisce, non è abituato, vorrebbe scrivere, vedere le sue parole prendere forma, rileggerle, cancellarle, correggerle. Non sopporta la presenza silenziosa della stenografa in poltrona che lo fissa mentre lui cerca di completare una frase nella mente, preferisce la distanza e sceglie di dettare al telefono. Il dramma privato si è ricongiunto al dramma pubblico, l’angoscia personale è diventata un elemento politico. Per questo bisogna costruire un racconto ufficiale del vuoto di potere, va inventata una teoria della crisi, una dottrina che inglobi, giustifichi e esorcizzi la malattia, visto che non è più possibile nasconderla.
Si comincia a ideologizzare la figura di Lenin, staccandola lentamente dalla vicenda quotidiana. Così il quadro di comando è presidiato, mentre Ilic — monumentalizzato in vita — si accorge in realtà di essere sempre più solo di fronte al male. Ogni giorno più irritabile, misura la lontananza tra tutto ciò che vorrebbe fare e quel poco che il corpo gli concede di sperimentare. In quello spazio impotente è prigioniero dei suoi pensieri che inevitabilmente cominciano a dubitare dei medici e delle cure, quindi si spingono a sfiorare il sentimento della fine, e ogni volta generano in lui una speciale ansia, figlia del senso di colpa per la grande incompiuta.
Cedere al pessimismo, scivolando verso il nulla come esito logico, è una tentazione ormai quotidiana ma è anche una scorciatoia, quasi una fuga. Deve trovare un appiglio qualunque, a cui appoggiarsi per riemergere. Poi un mattino la porta della stanza dove Vladimir Ilic riposa si apre senza preavviso, perché il comandante Pakaln, Capo delle guardie della sua sicurezza, gli ha portato Aidu, il cane che Nadezda ha fatto arrivare da Gorkij. Sente il muso umido che lo cerca e si appoggia alla coperta, lo interpella. Poco per volta la mano paralizzata tenta con una fatica avvilente di muoversi, inseguendo il meccanismo perduto che compone il gesto semplice e grandioso di una carezza.