
Etgar Keret: “La fine della guerra sarà solo un’illusione, in Israele ora regna la follia”
6 Ottobre 2025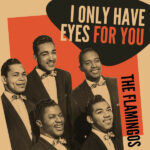
The Flamingos – I Only Have Eyes For You
6 Ottobre 2025
Dopo anni di scosse globali, l’Italia entra nel 2025 senza crollare ma anche senza ripartire davvero. L’economia resiste, i conti pubblici restano apparentemente in equilibrio, ma sotto la superficie si muove un Paese che cresce poco, si indebita molto e fatica a ritrovare fiducia.
Il prodotto interno lordo aumenterà quest’anno di circa lo 0,6 per cento, secondo le stime dell’Istat e della Banca d’Italia. È un numero piccolo, ma significativo: abbastanza per evitare la recessione, troppo poco per cambiare direzione. L’Italia cresce meno della media europea e continua a vivere di inerzia, sospinta da qualche settore che regge – turismo, edilizia, servizi – ma senza un vero motore di sviluppo. La produttività è ferma, gli investimenti privati restano modesti, e la domanda interna non riparte.
L’inflazione, dopo l’impennata del biennio post-pandemico, si è stabilizzata intorno all’uno e mezzo per cento. Ma la calma dei prezzi non basta a migliorare la vita delle persone, perché i salari sono fermi e il potere d’acquisto resta inferiore rispetto a dieci anni fa. Molti lavorano di più per guadagnare lo stesso, e chi vive con contratti precari o stipendi bassi sente di non avere margini. La società risparmia per paura del futuro, consuma meno e contribuisce così, involontariamente, a mantenere il Paese in una crescita piatta.
Sul fronte dei conti pubblici, il governo ha mantenuto un deficit attorno al tre per cento del PIL, in linea con le regole europee. Le entrate complessive per il 2025 ammontano a circa settecentotrenta miliardi di euro, provenienti in gran parte da imposte e contributi. Ma le uscite restano più alte, e la struttura del bilancio continua a riflettere i vincoli del passato. Pensioni, sanità e stipendi pubblici assorbono la maggior parte delle risorse, mentre il servizio del debito – cioè gli interessi e i rimborsi dei titoli di Stato – richiede da solo circa trecentottantatré miliardi di euro. In pratica, più della metà delle entrate serve a pagare debiti accumulati negli anni.
Il debito pubblico ha ormai superato i tremila miliardi di euro, il secondo più alto d’Europa dopo la Grecia. Ogni anno lo Stato deve emettere nuovi titoli per rifinanziare quelli in scadenza, in un ciclo continuo che lascia poco spazio alla spesa produttiva. Se i tassi d’interesse della Banca centrale europea restano alti, anche il costo del debito cresce, e con esso la fragilità del bilancio. Il risultato è un equilibrio precario, fondato su una disciplina contabile più che su un reale slancio economico.
Intanto, nel Paese reale, le piccole e medie imprese – ossatura dell’economia italiana – continuano a sopravvivere tra burocrazia, costi energetici elevati e difficoltà di accesso al credito. Gli investimenti in ricerca e innovazione restano tra i più bassi d’Europa, e i divari territoriali si allargano: il Nord regge, il Sud rallenta, le aree interne si spopolano.
Molte speranze restano legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma la sua attuazione procede a singhiozzo. I fondi ci sono, ma spesso non vengono spesi in modo efficace. Resta il rischio che il PNRR si trasformi in una pioggia di risorse temporanee, senza effetti strutturali. Non è una questione di quantità, ma di qualità: non basta spendere, bisogna sapere perché e per cosa si spende.
L’Italia del 2025, dunque, resiste ma non avanza. Mantiene i conti sotto controllo, ma non riesce a creare le condizioni di un nuovo ciclo di crescita. È un Paese che galleggia: non affonda, ma non costruisce il futuro. Per cambiare passo servono scelte profonde, di lungo periodo – istruzione, innovazione, giustizia fiscale, riduzione delle disuguaglianze – e una politica che guardi oltre l’emergenza e la propaganda.
Fino a quel momento, continueremo a vivere in questo equilibrio incerto, tra la nostalgia del passato e l’incapacità di immaginare il domani.




