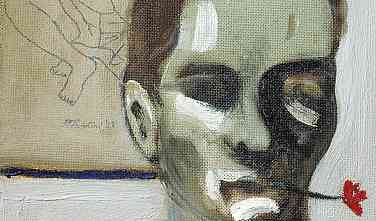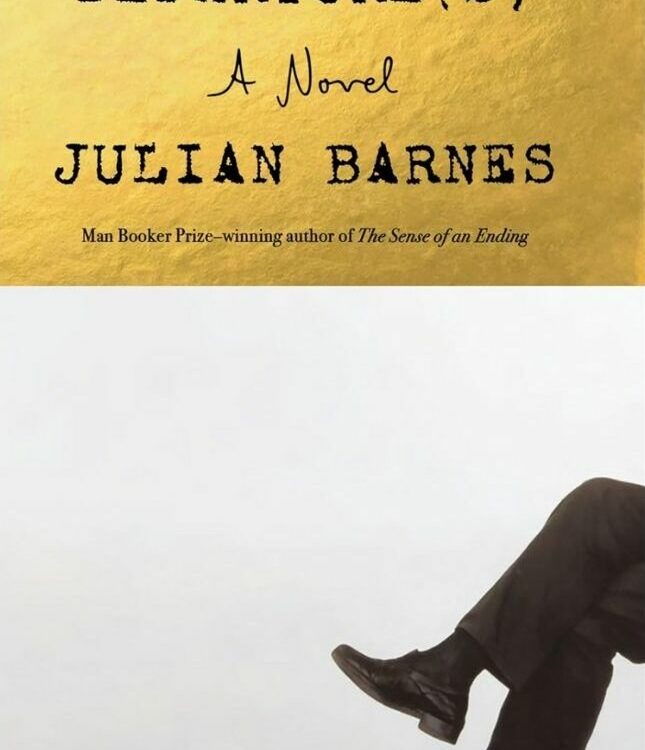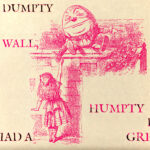
Ogni scrittore è un inventore di linguaggi
2 Novembre 2025
Artissima: il Giappone in un sorso. Ecco perché il suo stile ci piace tanto
2 Novembre 2025Separare le prove materiali dal racconto: ecco l’insegnamento di civiltà (uno dei tanti) che il poeta lascia a mezzo secolo dalla morte
di emanuele trevi
Era abbastanza ovvio che l’anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini avrebbe generato una nuova inondazione di saggi critici e indagini biografiche, ristampe, mostre e rassegne d’ogni tipo. Meno prevedibile era l’interesse che sta suscitando la raccolta intitolata Pasolini e il «Corriere della Sera» 1960-1975, curata perla Fondazione Corriere della Sera con grandissima perizia da Gianluigi Simonetti, che è stato allievo di Walter Siti e ne ha ereditato un’invidiabile capacità di affrontare questo scrittore così spinoso da interpretare con il necessario equilibrio di adesione e distanza. La sorpresa di questa nuova edizione, come ha osservato Paolo Di Stefano che l’ha prontamente recensita sul «Corriere» del 14 settembre, consiste proprio, paradossalmente, nella sua solo apparente inutilità.
Ma come, non era stato lo stesso Pasolini, con gli Scritti corsari e le Lettere luterane, a fare di quegli articoli scritti in un arco di tempo che va dal gennaio del 1973 all’autunno del 1975, opportunamente rivisti e spesso scorciati, due libri tra i suoi più letti e commentati, in Italia come in tutto il mondo? Anche il secondo di quei libri, pur uscito postumo nel 1976, corrisponde esattamente a un piano predisposto dall’autore. Si tratta peraltro di due capolavori difficilmente discutibili della prosa italiana del Novecento. L’arte di trasformare un articolo di giornale nel capitolo di un libro che non sembri raccogliticcio e occasionale è molto complessa. Ne sono stati maestri scrittori anche lontanissimi da Pasolini, come Emilio Cecchi e Pietro Citati, ma nessuno, credo, ha mai raggiunto i risultati degli Scritti e delle Lettere. E allora, se dalla pagina del giornale a quella del libro c’è un evidente progresso, dovuto a un lavoro di lima svolto con maestria, che senso ha percorrere a ritroso la sacrosanta volontà d’autore, ripristinando le versioni originali?
Eppure, basta iniziare a leggere questo libro per capire che l’operazione di Simonetti è tutt’altro che inutilmente antiquaria. Il lettore si troverà di fronte, iniziando il libro, al famigerato articolo polemico sui capelli lunghi, interpretati in qualità di segno linguistico, e considerati niente di meno che l’emblema, il geroglifico della decadenza di un intero mondo e della catastrofe rappresentata dalla civiltà dei consumi (il «genocidio culturale», insomma). Ebbene, c’è da ammettere che rileggere quelle pagine così famose nella versione originale, e con il loro bravo titolo redazionale, è un modo infallibile per misurarne la forza d’impatto sulla società italiana di quel periodo, quando un articolo di giornale — e soprattutto un articolo del «Corriere»! — aveva un potere di plasmazione della cosiddetta opinione pubblica oggi quasi inconcepibile.
Ripristinando le originarie condizioni di leggibilità di quegli articoli, e dotandoli di spiegazioni su questo o quel punto della cronaca politica e culturale italiana, Simonetti ha creato insomma un bizzarro effetto ottico, facendo di pagine ormai famosissime, spesso addirittura presenti nelle antologie scolastiche e citate più o meno a proposito, un insieme di testi che ha il deciso sapore dell’inedito (al netto di una manciata di inediti veri e propri, sepolti nell’archivio del giornale, che arricchiscono oggettivamente il volume). Ne emerge bene la capacità del Pasolini elzevirista di assorbire l’occasione quotidiana, che è come la calce di ogni giornalismo, nell’edificio complesso, vertiginosamente imprevedibile, metamorfico del suo pensiero negli ultimi anni.
Chi ha studiato Petrolio e Salò, ovvero i due capolavori terminali, sa bene quanto le collaborazioni al «Corriere» e ad altri periodici (primo fra tutti il settimanale «Tempo»), non siano affatto laterali e occasionali rispetto ai grandi progetti artistici. Al contrario, gli Scritti corsari e le Lettere luterane (ma anche quella splendida raccolta di recensioni che è Descrizioni di descrizioni) sono tasselli fondamentali della visione, veicolano anch’essi, come un cavo sottoposto a una tensione elettrica quasi distruttiva, la potenza della sua visione soggettiva, da grande scrittore.
Quando Piero Ottone invitò Pasolini a collaborare al «Corriere» (quasi contemporaneamente era nata l’idea di Petrolio), ebbe certamente una delle intuizioni più brillanti della storia dei giornali del dopoguerra, ma non poteva immaginare la reazione a catena che avrebbe innescato non solo nei lettori, ma nell’autore stesso. Si deve considerare anche un dato incontestabile: la memoria di uno scrittore non riguarda mai l’opera nella sua totalità, e il novanta per cento (a dir poco) di ciò che effettivamente si ricorda del pensiero di Pasolini al di fuori della cerchia degli studiosi deriva proprio da questi articoli e dai loro bersagli: dai capelli lunghi all’aborto, dal nuovo «fascismo» incarnato nel modello consumistico a un famoso e blasfemo slogan della pubblicità di una marca di jeans… E come un lettore dei primi anni Settanta, anche quello di oggi potrà provare un legittimo sgomento di fronte a molte pagine di questa raccolta.
Non era certo l’intenzione di Simonetti, ma ripristinare l’antica veste giornalistica di questi scritti ne mostra anche certi limiti che mi sembrano evidenti. La ragione è semplice: anche se le idee e le parole che le esprimono rimangono identiche, la «realtà» evocata in un grande organismo letterario quale è la costellazione degli ultimi libri di Pasolini non può coincidere esattamente con la «realtà» commentata sulla prima pagina del più importante quotidiano italiano. Nel primo caso, l’arbitrio supremo e insindacabile della percezione soggettiva, anche dove possa apparire ingiusto, è pur sempre un potentissimo e affilato strumento di conoscenza; nel secondo caso, isolato dal processo artistico che lo presuppone, finisce per suonare in maniera un po’ stridula, come una specie di autoritario prendere-o-lasciare.
Prendiamo l’articolo più celebre di tutta la raccolta, quello del 14 novembre 1974 che Pasolini, inserendolo nell’indice degli Scritti corsari, intitolò Il romanzo delle stragi. Il titolo originale, quello apparso sulla prima pagina del giornale, era invece Che cos’è questo golpe?. Retoricamente, è un pezzo efficacissimo, fondato sulla ripetizione di una semplice premessa: «Io so», alla quale però si sovrappone, verso la metà dell’articolo, una gravissima limitazione: «Ma non ho le prove». Ebbene, io credo che Pasolini, sostituendo il titolo redazionale, abbia compiuto un gesto di grande civiltà, e quasi una piccola «abiura», volendo utilizzare il suo lessico. Perché l’unico ordine di senso accettabile di un sapere svincolato dall’obbligo di mostrare le «prove» è appunto quello del «romanzo», inteso nel suo senso più largo possibile, come sinonimo della letteratura, e della sua possibilità di produrre un discorso sul mondo che sostituisca credibilmente la visione individuale, se non l’idiosincrasia, all’obbligo morale di documentare ciò che si racconta come verità. Fuori dal «romanzo», al contrario, oggi più che mai è necessario ricordarlo, il sapere privo di prove è ripugnante.
Correggendo quel titolo, Pasolini diede un esempio luminoso della sua lealtà verso i lettori; purtroppo, molti suoi odierni seguaci, che amano ridurre i suoi scritti a una serie di citazioni buone per tutti e per nessuno, trascurano molte di queste minuzie rivelatrici. La realtà è che non tutti sono in grado, come era Pasolini, di mantenersi in equilibrio sugli incerti e rischiosi confini che separano le forme linguistiche, i loro contesti e i loro significati.