
Le aiuole mistiche del Carmelo
11 Maggio 2025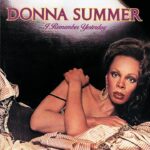
DONNA SUMMER I feel love
11 Maggio 2025Dall’Australia al Canada, fino all’Europa mediterranea. In maniera non coordinata, ma inesorabile, nei luoghi più colpiti da eventi climatici estremi, le compagnie assicurative hanno iniziato a sfilarsi. Altrove, il banco forse è già saltato. In California, i premi per garantire la copertura di una casa sono raddoppiati. In Florida, interi codici postali sono scomparsi. Non per problemi di criminalità o implosioni del mercato immobiliare. Ma per colpa di incendi, alluvioni, ondate di calore. Una volta parlavamo di cambiamento climatico come di una tempesta all’orizzonte. Oggi è semplicemente il tempo meterologico. La crisi climatica è il nostro presente e quotidiano. E con lei dobbiamo guardare in faccia una verità scomoda: mitigare non basta più. La CO2 che abbiamo già immesso nell’atmosfera rende inevitabile che certi impatti saranno comunque realtà. Eppure, molti di noi, nel campo della progettazione e delle politiche urbane, ci comportiamo come se niente fosse cambiato. Come se bastasse riprodurre i piani urbanistici del secolo scorso, tirando così la corda fino all’estremo.
A Venezia, alla Biennale Architettura, aperta fino al 23 novembre, vogliamo allora provare a dire qualcosa di diverso. È ora che l’architettura la smetta di progettare come se la crisi climatica fosse una possibilità ancora da scongiurare, e inizi invece ad agire all’interno della crisi stessa. Chiamando a raccolta tutti i tipi di intelligenza a nostra disposizione: naturale, artificiale, collettiva. Questo vuol dire spostare il centro dell’attenzione – finora centrato sulla mitigazione – verso quelle che chiamerei strategie di adattamento. Dobbiamo ricalibrare la nostra azione. Non soltanto decarbonizzare, ma costruire in modo che città ed edifici sappiano reggere anche in condizioni di forte stress. Non sarebbe la prima volta. Quando il colera colpì Londra nell’Ottocento, ingegneri e architetti rivoluzionarono le infrastrutture locali. Quando Parigi affogava nello smog, pochi anni fa, arrivarono regolamenti e provvedimenti sulla mobilità che hanno saputo abbattere le emissioni. La domanda non è se le città possano adattarsi, ma se riescano a farlo in tempo.
L’anno scorso è stato il più caldo mai registrato. A Delhi si spaccava l’asfalto. A Phoenix ci si ustionava toccando le maniglie delle porte. A Milano le notti non rinfrescavano mai. Il sistema è in surriscaldamento, ma la risposta spaziale è ancora tiepida. Qualche settimana prima della Biennale Architettura, oltre 350 architetti, scienziati e figure pubbliche hanno firmato un manifesto. Tra loro, il premier spagnolo Pedro Sánchez e lo scienziato tedesco Hans Joachim Schellnhuber, una delle massime autorità nel campo della climatologia. Il loro messaggio è chiaro: l’adattamento non è un appendice del rapporto sulla sostenibilità. È il rapporto stesso. La biologia questo lo sa già. I coralli si adattano chimicamente quando le acque si scaldano. Le piante alpine anticipano la fioritura. Le zone umide si spostano. In altre parole, adattarsi non corrisponde a una resa: è quello che la vita fa quando è sottoposta a pressioni.
Le città, certo, sono più lente. Il cemento non si sposta. Ma può cambiare più in fretta del nostro DNA, se lo vogliamo. Per fare questo, l’architettura deve acquisire un carattere nuovo: la capacità di rispondere con rapidità al mutamento delle condizioni esterne. Abbiamo bisogno di edifici che respirino. Di materiali che assorbano e rilascino energia. Spazi pubblici che assorbano l’acqua, ombreggino le persone, rallentino le ondate di calore. E poi codici urbanistici, impianti idraulici, politiche del suolo: sono elementi progettuali anche quelli. E vanno ripensati. Insieme ai sistemi di insegnamento per chi si avvia alla professione. Il problema è che tante città sono nate su presupposti ormai superati: crescita infinita, clima stabile, energia a basso costo. Il risultato? Una forma urbana troppo rigida per piegarsi, troppo fragile per resistere. Serve cambiare la logica del modo in cui si fa architettura.
Per comportarci in modo più simile alla natura, dobbiamo avvicinarci di più alla scienza. Il premio Nobel per l’economia Herbert Simon diceva: «La scienza descrive le cose come sono. Il design immagina come dovrebbero essere». I risultati migliori nascono quando questi due mondi si incrociano: nei laboratori, nei boschi, nelle sale espositive. Molto di tutto questo sarà proprio visibile alla Biennale Architettura. I modelli di rischio termico di Sonia Seneviratne, scienziata climatica che insegna all’ETH di Zurigo, stanno ispirando le distribuzioni all’interno dei vari spazi dell’Arsenale. Molte installazioni dimostrano che cosa significhi rendere l’adattamento una priorità. Dalla mostra alla città, quello che ci servono sono luoghi di sperimentazione: spazi dove la progettazione può permettersi di fallire, in modo produttivo. Dove il prototipo è la regola. Programmi come “Reinventing Cities” del network C40 potrebbero evolvere verso l’adattamento. Venezia stessa è uno spazio ideale per l’innovazione. Le barriere del MOSE oggi la proteggono, ma non lo faranno per sempre. La crescita delle temperature e della pressione turistica unite al collasso della popolazione la rendono uno dei luoghi più fragili del pianeta: un autentico banco di prova per il nostro futuro. Certo, l’architettura da sola non può risolvere tutto. Ma può porre le domande giuste. E chiedere aiuto ad altre discipline. Dove andare a intervenire? Quali priorità mettere al centro? Quali sistemi rafforzare? Quali rischi ridurre, e per chi? Adattarsi non deve essere la fine delle nostre ambizioni. Ma l’inizio di una presa di responsabilità. Il pianeta è cambiato – saremo in grado di farlo anche noi?





