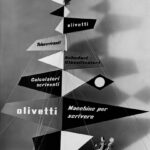«la Germania Est (Ddr) aveva un odore intenso di abrasivo, cera per pavimenti e trementina», scrive Angela Merkel nelle prime pagine delle sue memorie. Tutt’altra cosa rispetto al «profumo d’Occidente» che esalava dai pacchi dono con sapone e caffè che arrivavano dai parenti della Germania Ovest. La famiglia di Angela Merkel viveva infatti in una località dell’Est, prima Quitzow, poi Templin, 80 chilometri a nord di Berlino, dopo essersi trasferita colà da Amburgo, dove la primogenita aveva fatto in tempo a nascere, al seguito del padre, pastore protestante idealista.
Nonostante quell’odore ce l’abbia ancora nel naso, Merkel intitola la parte dedicata ai suoi primi anni, Un’infanzia felice. Un’infanzia nella natura, dedita ai giochi e alle scorribande all’aperto, alla raccolta dei mirtilli rivenduti per qualche soldo quando non usati per farne marmellate, in una famiglia calda e accogliente. La madre soprattutto, in grado di comprendere lei, il fratello e la sorella minori, ognuno nella sua specificità. Ma la madre era anche quella che invitava i bambini alla cautela nell’esprimersi in pubblico, tanto che per la piccola Angela la scuola (comunista) e la famiglia (cristiana evangelica, tutt’ora Merkel si dichiara credente) erano due mondi con regole diverse: uno ispirato alla prudenza, l’altro alla sincerità. Due mondi facenti parte della vita di Angela Merkel: i suoi secondi 35 anni nella Germania federale unificata, gli anni della libertà e della democrazia dopo che i primi 35 erano stati gli anni della dittatura e della sorveglianza; una condizione che molti conoscono se non altro dal film Le vite degli altri.
Ho letto il libro da una angolatura particolare, essendo vissuta a lungo nella Germania Ovest vicino alla Germania Est. Lì ogni sabato a mezzogiorno suonava la sirena, per ricordare – si diceva – che i Russi avrebbero potuto invadere in ogni momento il «mondo libero». Libertà è la storia generale del mondo, dell’Europa e della Germania, imperniata sulla storia individuale di una persona. Una giovane donna di un Paese governato dalla dittatura che diventa deputata, ministra e infine cancelliera di un Paese libero e democratico, per sedici anni consecutivi senza una sbavatura, uno scandalo, una crisi di governo. Alla fine di quattro mandati la stessa persona capisce che è l’ora di smettere – glielo segnala anche il suo corpo – che deve cogliere il kairos, il momento giusto per compiere l’azione giusta.
Per decine e centinaia di pagine scorrono i ricordi della vita politica di Angela Merkel, con qualche lampo sulla sua vita privata: l’elezione al Bundestag, il primo ministero federale (Donne e gioventù), il secondo (Ambiente, protezione della natura e sicurezza dei reattori), insieme a tutto l’ambiente partitico che ha scelto, o da cui è stata scelta, la Cdu, l’Unione cristiano democratica nella quale era confluito il piccolo partito Risveglio democratico, il Da, in cui aveva militato nel crepuscolo della Ddr. Merkel compie scelte politiche, in quanto capo del governo, seguendo i propri principi, enunciati qua e là nel testo. Se li si raccoglie insieme si ottiene un mazzo variopinto, come i blazer colorati che la cancelliera ama indossare, reazione al grigiore della Ddr e all’orrenda uniforme della Fdj che le tocca mettere a Mosca e a Jaroslaw durante il viaggio premio per la sua eccellente conoscenza della lingua russa.
Nelle sue scelte Merkel si ispira, dice di ispirarsi, ai principi che sono intoccabili come lo è la dignità umana (Articolo 1 della Costituzione tedesca). Ne fanno parte la libera costituzione, l’ordine economico sociale di mercato, la tolleranza, la sovranità del popolo, la sicurezza, la libertà. Naturalmente si può obiettare che sono tutte belle parole e basta, e che alcuni concetti sono tra di loro incompatibili quando li si pone in alternativa: gli ultimi due soprattutto, libertà e sicurezza, giacché è noto come facilmente la prima venga immolata sull’altare della seconda, in una gioconda corsa di gara a chi lo fa con maggior zelo, governati o governanti. E anche se sono solo parole, almeno sono belle e condivisibili, certo più che competizione, nazionalismo, sovranismo, prima noi, restringimenti, misure deterrenti e simili. Meglio sentir parlare Merkel di pluralità e pluralismo che valutare la politica in termini di guadagni e perdite dalla prospettiva di un imprenditore edilizio quale era Trump prima di dedicarsi alla politica.
Nella seconda vita di Merkel c’è una nuova cesura: il prima e il dopo della sua reazione all’arrivo di centinaia di migliaia di profughi, per lo più siriani, nell’agosto del 2015. Stavano in autostrada, respinti dall’Ungheria di Orban; lei pronuncia la ormai celebre frase «Wir schaffen das», ce la facciamo, permettendo loro l’ingresso in Germania attraverso l’Austria (che a buon conto ne prese la metà). A ripetere in pubblico quelle tre parolette glielo aveva suggerito la coautrice del libro, Beate Baumann, sua preziosissima segretaria-collaboratrice-assistente, la cui presenza pervade tutto il volume in maniera discreta ma determinante. Merkel assume la giovane donna nel 1992, dopo essersi fratturata la gamba sinistra in due punti per un banale incidente (che è anche il motivo per cui da quel momento in poi indossò sempre i pantaloni).
Beate Baumann si associa al team dei collaboratori e non lo lascerà più. Ma quella frase di accoglienza espressa da Merkel, e raccolta e rilanciata da Baumann, viene oggi respinta dalla sua stessa famiglia politica, la Cdu-Csu. Merkel invece sapeva, e lo ripete nelle sue memorie, che «nessuno lascia la propria patria con leggerezza, nemmeno coloro che lo fanno esclusivamente per mancanza di prospettive economiche e sociali, senza alcuna possibilità di essere riconosciuti come richiedenti asilo in Germania».
Angela Merkel
Libertà. Memorie 1954-2021
Traduzione di Chicca Galli
e Roberta Zuppet
Rizzoli, pagg. 736, € 25