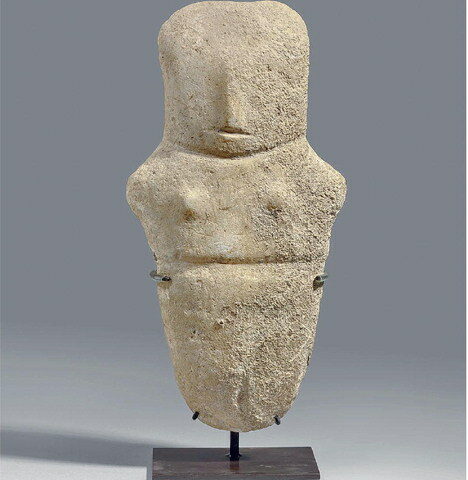La coppia è liquida
24 Agosto 2025
Veronese, la diagonale rivolta all’atmosfera
24 Agosto 2025
Il grande storico comparatista è oggetto in Italia di una inattesa renaissance editoriale Il suo lavoro ha suscitato polemiche e divisioni ma resta imprescindibile per lo studio del fenomeno religioso
«Georges Dumézil ci ha lasciato una cinquantina di libri e circa duecentocinquanta articoli; nella sua ricerca si avvicinò ai settori più diversi del mondo indoeuropeo e dei popoli che lo costituivano: lingue e dialetti, storia, società, miti, epica, letterature, economia, guerra, pantheon e religioni» consentendogli di «fornirci una chiave di accesso alle civiltà e alle religioni dell’India, dell’Iran, dell’Anatolia, del mondo celtico, di Roma, della Grecia e della Germania, e di riscoprire numerose culture scomparse». Così il cardinale Julien Ries (1920-2013), storico e antropologo delle religioni, affresca l’immane lavoro di uno dei maggiori studiosi del secolo passato in Georges Dumézil e lo studio comparato delle religioni (Il Cerchio, pagine 60, euro 12,00).
Dumézil, insieme a Mircea Eliade, Henry Corbin, Louis Massignon, è stato uno dei grandi esploratori del pensiero umano del Novecento. Nato a Parigi nel 1898 e lì spentosi nel 1986, Dumézil, che padroneggiava una trentina tra lingue e dia-letti, fu storico, linguista, orientalista e soprattutto l’innovatore di un metodo che avrebbe cambiato radicalmente l’approccio agli studi religiosi comparati. Superando l’impostazione ottocentesca dei suoi maestri, Dumézil ha reso la comparazione tra testi, miti e testimonianze di popoli distanti fra loro, dall’India vedica alla Roma arcaica, dall’Iran ai mondi celtico e germanico, un metodo di ricerca.
Passando da un confronto superficiale basato su semplici concordanze etimologiche e consonanze tra nomi e parole, lo studioso d’Oltralpe è passato all’individuazione di omologie strutturali presenti nelle mitologie indagate, a testimonianza della presenza di tracce di una cultura originaria comune. «Il comparatista, per contro, dispone di un mezzo di valutazione obiettiva, consistente nel ritrovare delle coincidenze (e dei gruppi di coincidenze, piuttosto che delle coincidenze isolate) tra due società di comune origine. Se ritroveremo, inserita in un equilibrio specificamente indiano e in un equilibrio, ad esempio, specificamente romano, una stessa serie, sufficientemente originale, di elementi in relazione omologa, potremo dire che questi elementi hanno una certa probabilità di essere antichi, ereditati dalla preistoria comune; e più il gruppo degli elementi considerati sarà complesso e delicato, più la probabilità sarà forte; se poi un terzo equilibrio specificamente, ad esempio, scandinavo o irlandese, presenterà lo stesso gruppo di elementi singolari, la probabilità comincerà ad avvicinarsi di molto alla certezza» precisa lo stesso Dumézil in Jupiter, Mars, Quirinus (pagine 328, euro 39,00), anche questo da poco ripubblicato da Il Cerchio dopo che Einaudi l’aveva reso disponibile al pubblico italiano nel 1955, nella celebre “Collana viola” diretta da Cesare Pavese ed Ernesto de Martino.
Il cuore del pensiero di Dumézil risiede nella scoperta, balenata dopo anni di studio nel 1938, che le antiche società indoeuropee erano organizzate e rappresentate, sia nei loro riti sia nei miti, secondo una struttura tripartita. Al vertice starebbe la funzione sovrana magico- sacrale e giuridica, poi la funzione guerriera, seguita alla fine dalla funzione produttiva, economica e di fecondità. Secondo lo studioso francese, questa visione trifunzionale non necessariamente conformava la società, ma pervadeva il pantheon divino e la narrazione mitica. Tuttavia, in alcuni casi, anche l’organizzazione sociale ne risentiva gli effetti. Vale per le caste dell’India antica ma retaggi se ne intravedono pure nell’articolazione in clero, nobiltà e terzo stato nella società dell’Europa medioevale. Georges Duby docet. Tale struttura, che va ben oltre una semplice osservazione storico-sociale, si rivela una vera e propria ideologia sottesa alle civiltà di origine indoeuropea. « È una concezione dell’universo, del mondo divino e del mondo degli uomini – annota Ries – che ha guidato questi popoli fin dai tempi più antichi, permettendo loro di mantenere l’equilibrio e di superare le tensioni». E questo in virtù dello schema tria funzionale certo ma anche gerarchico, in cui l’esercizio della funzione guerriera è sempre subordinato all’amministrazione del sacro e del diritto.
Questo aspetto emerge in maniera evidente in Orazio e i Curiazi (pagine 186, euro 16,00) dato alle stampe, per la prima volta in lingua italiana, dalle Edizioni mediterranee e affiancato da un ampio saggio introduttivo di Alessandro Campi, che si sofferma anche sulle polemiche che talvolta, e più in Italia che altrove, hanno accompagnato il lavoro di Dumézil. Prendendo in esame «i miti che giustificano le pratiche della seconda classe, quella dei guerrieri», lo studioso comparatista mette in luce, in questo lavoro del 1942, come i riti di iniziazione guerriera si siano trasformati nel corso del tempo a Roma pur mantenendo tratti confrontabili con le vicende dell’irlandese Cûchulainn o il Batradz dei Narti, tramandato dagli Osseti del Caucaso ancora nei primi decenni Novecento.
Anche Loki (pagine 340, euro 20,00), da poco pubblicato in italiano da Massari editore, illustra il metodo di lavoro adottato da Dumézil. Uscito per la prima volta nel 1948 e poi rimaneggiato con una terza edizione nel 1986, poco prima della scomparsa dello studioso delle religioni, il volume dedicato alla religione scandinava si dimostra un cantiere aperto, come in realtà tutti i lavori dello studioso. Anche qui lo sforzo condotto dall’autore è sempre lo stesso. Cercare le caratteristiche comuni tra la figura divina di Loki, conosciuto ancora negli anni Ottanta dai condico, tadini di Norvegia e Islanda, e Syrdon, protagonista dell’epica osseta per capire se esse derivino da un prestito tra culture lontane o invece siano espressione di un’origine comune. Alla fine Dumézil è consapevole di non poter sciogliere la questione e dichiarerà in una celebre intervista a Didier Eribon che «pur supponendo che io abbia totalmente torto i miei Indoeuropei saranno come le geometrie di Riemann e di Lobacevskij: costruzioni fuori del reale. Non sarà poi tanto male. Basterà cambiarmi di posto negli scaffali delle biblioteche: passerò nella sezione ‘romanzi».
Reali o no gli Indoeuropei, a Dumézil si deve la capacità di aver scovato, dietro l’apparente molteplicità delle religioni, strutture profonde comuni, arricchendo lo studio del sacro nella storia umana. E il suo pensiero, riscoperto anche grazie a questa inattesa renaissance editoriale italiana, rimane seducente benché divisivo e rappresenta un riferimento imprescindibile per chiumque affronti lo studio delle religioni.