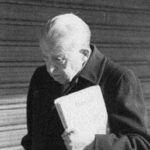
La Caduta del Fortino: Come Mediobanca ha Perso la Sua Anima
6 Settembre 2025
Vittorio Grilli e l’ombra dell’Antonveneta
6 Settembre 2025
Questa analisi ignora volutamente ogni lettura ideologica e si concentra sui risvolti tecnici, mettendo in evidenza anche il ruolo che la politica inevitabilmente esercita sull’economia e sulla finanza.
L’acquisizione di Mediobanca da parte del Monte dei Paschi non è un’operazione neutra. Unire una banca fragile come MPS, segnata da una lunga storia di difficoltà (si pensi al caso Antonveneta del 2007, costato oltre 9 miliardi), con un istituto come Mediobanca, specializzato nell’investment banking, significa concentrare vulnerabilità diverse nello stesso perimetro, amplificando le criticità anziché ridurle. La governance, in queste condizioni, diventa un terreno instabile: due culture bancarie lontane, una legata al credito tradizionale e l’altra alle logiche della finanza sofisticata, difficilmente convivono senza frizioni. La storia delle fusioni bancarie è piena di tentativi falliti per incompatibilità profonde (come dimostrano i casi Crédit Agricole–Credit Lyonnais o Deutsche Bank–Postbank).
A rendere tutto più complesso è il ruolo della politica, che cerca di costruire un presunto “terzo polo” bancario nazionale. Ma i numeri raccontano un’altra storia: questo terzo polo è un topolino rispetto ai grandi del settore. Nel primo semestre 2025, Mediobanca ha registrato circa 660 milioni di utile netto (con previsioni al 2026 di 1,4 miliardi e 4 miliardi di ricavi complessivi), mentre Monte dei Paschi ha ottenuto nel secondo trimestre 2025 un utile di 479 milioni (contro attese di 349 milioni), con ricavi a 1,05 miliardi e un CET1 del 19,6%. In altri trimestri ha superato i 400 milioni di utile (413 milioni nel primo trimestre 2025, +24% sul 2024), trainato dalla crescita delle commissioni (+21%). Numeri positivi, ma ben lontani dai colossi: Unicredit, ad esempio, ha registrato oltre 9,3 miliardi di utile netto nel solo 2024, mentre Intesa Sanpaolo nello stesso anno ha superato i 7,7 miliardi.
Di fronte a questi dati, il cosiddetto “terzo polo” appare nettamente ridimensionato: mettere insieme MPS e Mediobanca significa sommare bilanci che restano comunque molto distanti dalla scala dei primi due gruppi bancari italiani (Unicredit e Intesa) e ancora di più rispetto ai grandi attori europei (BNP Paribas ha superato i 10 miliardi di utile, Deutsche Bank i 5,2 miliardi).
Quando la politica entra nelle scelte economiche, il capitale non segue più criteri di sostenibilità e redditività, ma logiche di consenso e convenienza territoriale (ad esempio il sostegno al credito agevolato in aree elettoralmente sensibili). I cicli della politica, scanditi da elezioni e crisi di governo, non coincidono con i tempi lunghi dell’economia e della finanza. Ne derivano decisioni affrettate (per mostrare risultati prima di un voto) o, al contrario, rinvii dannosi (per evitare tensioni sociali). A pagarne il prezzo è la crescita complessiva, frenata da allocazioni distorte, crediti concessi senza basi solide e un aumento delle sofferenze bancarie.
Sul fronte della governance, il quadro non è migliore. Manager divisi tra obiettivi economici e pressioni politiche, nomine dettate da equilibri di potere più che da competenze (come accaduto in passato nelle Fondazioni bancarie), processi decisionali rallentati e leadership indebolita. In questo contesto diventa difficile trattenere i migliori talenti e garantire strategie chiare.
Gli investitori hanno già manifestato diffidenza: i mercati non vedono sinergie evidenti e temono la diluizione del valore degli asset. L’operazione appare costruita con accordi riservati tra pochi grandi azionisti (senza un processo competitivo aperto), alimentando sfiducia.
I rischi sistemici sono molteplici. Se MPS percepisce un sostegno politico garantito, il moral hazard diventa inevitabile: maggiore propensione al rischio, con la certezza che eventuali costi verranno socializzati (come già accaduto nei salvataggi bancari italiani del 2017). Intanto, mentre in Europa si costruiscono campioni bancari transnazionali (si pensi a BNP Paribas o Santander), in Italia rischiamo di creare un gigante domestico inefficiente, incapace di reggere la competizione globale. Non vanno sottovalutati nemmeno i conflitti di interesse: una banca legata al governo dovrà giudicare e finanziare investimenti in settori strategici (energia, telecomunicazioni, difesa) e acquistare titoli di Stato da cui dipende la stessa politica.
Il conto finale potrebbe rivelarsi salato: risorse pubbliche che avrebbero potuto essere usate altrove (per rafforzare la sanità territoriale, sostenere scuola e università, investire nelle infrastrutture viarie o ferroviarie, accelerare la transizione energetica), un sistema bancario reso più fragile nel medio periodo, la fiducia degli investitori internazionali compromessa. Non si tratta dunque di un’operazione di normale mercato, ma di un esperimento ad alto rischio che tocca la stabilità, la competitività e la credibilità dell’Italia. Proprio per questo non può essere calato dall’alto, senza dibattito pubblico né valutazioni approfondite. Perché a pagare, in ultima analisi, saranno imprese, risparmiatori e contribuenti.





