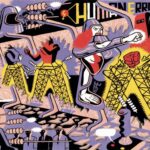Tra le foto che preferisco di Ocean Vuong, ce n’è una in cui lui guarda «con totale esasperazione, disgusto, e quella che sembra un’insormontabile sensazione di fallimento» le bozze della sua prima raccolta di poesie, Cielo notturno con fori d’uscita, sparse sul tappeto del soggiorno.
Non poteva saperlo ma quel libro, uscito nel 2016, avrebbe cambiato tutto e il figlio di una povera esule vietnamita – bambino con gli occhialoni che avrebbe imparato a leggere tardi, accettato ogni tipo di lavoro per mantenersi e lottato contro le dipendenze – si sarebbe trasformato in uno dei più quotati scrittori americani con milioni di adoratori, una cattedra all’NYU e una MacArthur Fellowship, detto anche il «premio dei geni».
Mentre L’imperatore della gioia, il suo secondo romanzo, arriva in Italia, la prima cosa che gli chiedo è se, dopo oltre 10 anni e tutto il successo, la paura di non essere abbastanza è la stessa provata di fronte a quelle prime bozze. «Sempre», mi risponde, «ma oggi so una cosa che allora non sapevo: se lavori costantemente ogni giorno, alla fine il lavoro sarà fatto. L’esperienza conta, ma non può insegnarti nulla sul libro che devi ancora scrivere. Al contrario del cardiochirurgo, che anche se ogni cuore è diverso sa già dove tagliare e dove cucire, il romanziere ogni volta deve reimparare tutto da capo».
Il nuovo libro che, come tutti gli altri, ha scritto a mano su dei quaderni – «a volte penso di avere il cervello nelle mani, più che nella testa» – ruota attorno alla relazione tra il giovane Hai, una specie di alter ego di Vuong, e Grazina, un’anziana lituana che lo salva dal suicidio e lo prende a vivere con sé. L’imperatore della gioia, che con le sue lunghe frasi, le descrizioni e le subordinate assomiglia più all’Ottocento che a Tiktok (un gesto consapevole e liberatorio da parte dell’autore), è un romanzo che parla di vuoto, cioè l’America dei fast food come quello in cui il protagonista trova lavoro, e di fantasmi, perché anche qui, ancora una volta, Vuong discioglie dei pezzi della propria vita.
Grazina è esistita veramente. Ce ne può parlare?
«Ho vissuto con lei per due anni e mezzo ed è stata un’esperienza fondamentale nella mia vita. La possibilità che due persone diverse come noi, provenienti da continenti lontanissimi, potessero incontrarsi è un’esperienza tipicamente americana. Ma è anche vero che i traumi e i flashback che lei aveva sulla Seconda Guerra Mondiale erano molto simili a quelli di mia nonna sul Vietnam. Tra noi due c’è stato uno scambio: io non avevo un posto in cui stare, lei non voleva lasciare la sua casa, ma aveva bisogno di qualcuno che la aiutasse. Aveva vissuto tutta la sua vita americana nella casa che lei e suo marito avevano comprato e di cui andava orgogliosa. È allora che ho iniziato a capire che non ero tanto interessato al sogno americano, quanto agli americani che avevano dei sogni».
Che cosa ha imparato dai colleghi del fast food?
«Non sono mai stato in guerra, ma credo sia un po’ come ritrovarsi a combattere insieme. Sono convinto che gran parte della storia umana si sia costruita sulle famiglie che ci facciamo sul posto di lavoro. I miei colleghi erano repubblicani e conservatori. Il mio capo un cristiano evangelico. Avevamo opinioni molto diverse, ma dovevamo comunque dipendere l’uno dall’altro per portare a termine il lavoro. Col tempo, le nostre ideologie hanno iniziato a depotenziarsi, una cosa per me sorprendente e preziosa. Oggi, anche a causa della tecnologia, stiamo perdendo questi legami, e mi chiedo se non sia in parte per questo che l’America si è così polarizzata».
Questa “gentilezza senza speranza”, come lei la chiama, esiste solo tra le classi più povere?
«Sì, perché spesso nasce dalla sofferenza, dal sapere che prima o poi potresti essere tu ad avere bisogno di aiuto. Non voglio idealizzare i poveri alla Victor Hugo ma da transfuga di classe, nato povero e ora professore invitato a parlare in ville, case di politici e amministratori delegati, ho notato che sono quasi sempre le persone che hanno poco a dare tanto, perché sanno quanto sia necessario ricevere».
Esiste ancora il sogno americano?
«Nessuno parla di quanto il “sogno americano” sia qualcosa di molto costoso. Il motivo per cui oggi lei sta parlando con uno scrittore è che io ho potuto usufruire di tutta una serie di programmi di welfare che l’attuale amministrazione Trump sta pian piano smantellando».
Lei ha detto che il «trumpismo» esisteva molto prima di Trump.
«Commettiamo un grave errore se continuiamo a dare per scontato che Trump sia un’anomalia. Un altro errore è dargli dell’idiota, perché questo gli ha permesso di acquisire sempre più potere: la sua amministrazione lo ha capito e sta usando quell’umorismo per mettere in atto il fascismo. Penso che di questo sia colpevole anche la sinistra che quando umilia Trump dandogli del pagliaccio umilia allo stesso tempo anche le persone, spesso lavoratori poveri di varie etnie che lo hanno votato e che, così, simpatizzano ancora di più con lui. È fondamentale invece prenderlo molto sul serio, perché è tutt’altro che un pagliaccio inoffensivo».
Il romanzo parte nel 2009 all’inizio dell’era Obama, da cui lei è si è sentito molto deluso.
«Da un lato sì, come molti altri giovani. Dall’altro, è stata probabilmente la nostra ingenuità a portarci alla delusione. Col tempo ho capito che quel ruolo ha una specie di capacità mistica di trasformarti in un funzionario delle élite. Quell’amministrazione mi ha fatto crescere molto in fretta: ho imparato che, a prescindere da chi ci sia alla Casa Bianca, a soffrire saranno sempre i lavoratori poveri».
Poco prima di morire sua madre le ha confessato che nella prossima vita avrebbe voluto essere una scrittrice, come lei. Come l’ha fatta sentire?
«Mi ha distrutto. Ho ammirato mia madre per tutta la vita e mai avrei pensato che anche lei potesse ammirare me. A riempirmi di dolore è avere saputo di quel desiderio quando ormai non c’era più tempo: lei non ha mai ricevuto un’istruzione, non ha mai nemmeno imparato a leggere».
Ha detto che insegnare è l’«onore» della sua vita. Perché?
«La “classe”, il suo ethos, è un luogo di vera speranza, più di qualsiasi campagna politica, perché la sua funzione è quella di essere un laboratorio di meraviglia, dove il compito principale è l’illuminazione e il tentativo. In qualsiasi altro luogo, in fabbrica, al lavoro, se ci provi e commetti un errore vieni punito: l’aula invece è il luogo collettivo dell’apprendimento e della sfida. E quindi onorarlo e mantenere viva quella promessa è per me una meravigliosa opera sacra».