La crescita del Pil nominale tornerà ad essere inferiore a quella del costo del debito: in particolare, nel 2026, la prima sarà pari a 3,1 per cento e la seconda a 4,6. Con un simile quadro, la riduzione del rapporto debito/Pil richiederà una stretta, quindi, un avanzo primario (ossia la differenza tra le entrate e le uscite al netto degli interessi), ben maggiore di quella necessaria attualmente. Pertanto, iniziare a tagliare il debito oggi consentirebbe di intervenire meno domani. La terza condizione riguarda le regole europee. O meglio, le nuove regole europee. Come è noto, le norme che limitano i debiti e disavanzi degli Stati nazionali, contenute nel Patto di Stabilità e Crescita, sono sospese fino a dicembre. A partire dal mese di gennaio torneranno in vigore a meno che i leader europei non riescano a trovare un accordo. La Commissione europea ha predisposto una bozza di riforma in cui al centro c’è, proprio, il debito. L’obiettivo è quello di indurre chi continua a registrare stock di passivi elevati e in crescita – ad, oggi, solo l’Italia si trova in questa situazione – a diminuirli in base ad un percorso specifico delineato da Bruxelles. A questo scopo, viene introdotta – per la prima volta – una distinzione in termini di rischio tra i debiti dei Paesi europei. Il nuovo impianto, infatti, è basato sul degree of debt challenge, letteralmente grado di sfida del debito. Per chi presenta un grado “sostanziale” (come verrà definito non è chiaro), il rischio di apertura di una procedura d’infrazione sarà maggiore. Oltre a trattare gli Stati in maniera diversa, la riforma presenta diverse criticità e, per questo, andrebbe profondamente modificata. Come si è già scritto su questo giornale, il governo dovrebbe cercare alleati per proporre un impianto che preveda criteri noti ex ante e un percorso di aggiustamento definito, in prima battuta, dagli Stati membri. E’ chiaro che presentarsi al tavolo negoziale con un debito che non scende non aiuterà.
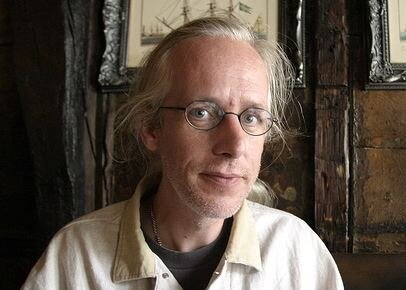
𝐖𝐢𝐥𝐝 𝐒𝐭𝐲𝐥𝐞 𝟒𝟎, 𝐜𝐮𝐫𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐌𝐜𝐂𝐨𝐫𝐦𝐢𝐜𝐤
26 Ottobre 2023
Stranieri, affittuari, coppie con molti figli I poveri in Italia superano i 5,6 milioni
26 Ottobre 2023di Veronica de Romanis
In base all’attuale Legge di Bilancio, il debito in rapporto al Pil è previsto scendere di mezzo punto percentuale nell’arco di un triennio: dal 140,1 del 2024 al 139,6 del 2026. Ciò significa che verranno tagliati meno di due miliardi l’anno. La cifra è modesta e, peraltro, condizionata al verificarsi di due eventi assai improbabili: una crescita all’1,2 per cento prevista per l’anno prossimo ricavi da privatizzazioni pari a 22 miliardi. L’entità del taglio aumenta – sebbene di poco – con il passare del tempo. Il ragionamento del governo è semplice: ridurre il debito nell’immediato non è opportuno ma l’impegno a farlo in futuro resta. A fronte di questa scelta, c’è da chiedersi quando arriverà il momento opportuno. Per la verità, questo momento è già arrivato, ed è ora: le condizioni per agire, infatti, ci sono tutte. In primo luogo, l’incertezza. Nell’attuale contesto, caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche, un elevato stock di debito che, perdipiù non scende, rappresenta un fattore di vulnerabilità. In secondo luogo, la dinamica. Negli ultimi anni, l’Italia ha registrato una crescita nominale (che include anche l’inflazione) superiore al costo del servizio del debito: nel 2022, la variazione del Pil nominale è stata del 6,8 per cento mentre quella della spesa per interessi del 4,3 e nel 2023 le percentuali sono state, rispettivamente, del 5,3 e del 3,8. Quando ciò avviene il rapporto debito/Pil cala naturalmente – a parità di tutto il resto -, perché il denominatore aumenta più del nominatore. Dall’anno prossimo, tuttavia, questa dinamica verrà meno.





