
La verità, vi prego sui Futuristi
11 Dicembre 2022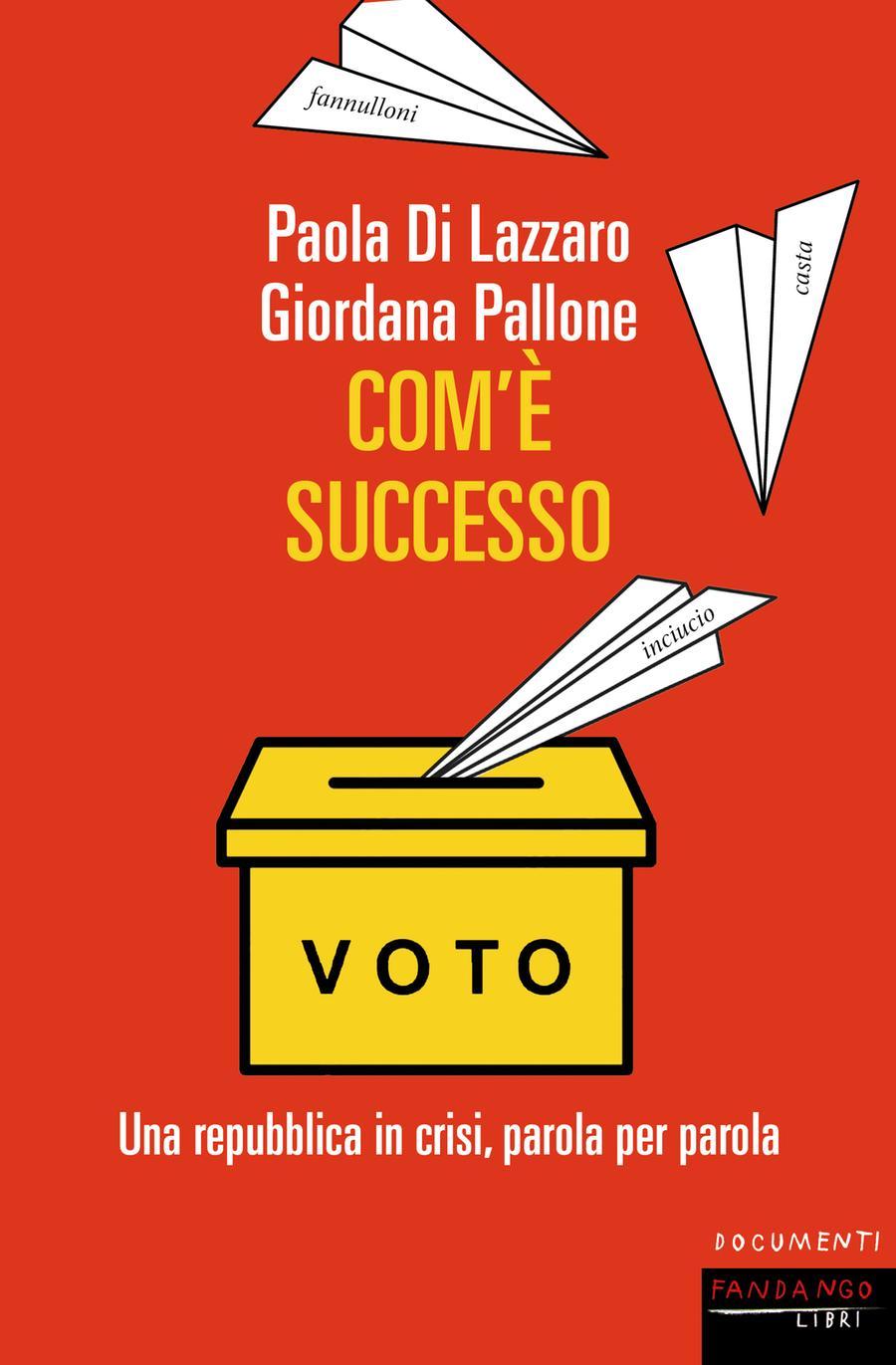
La lingua dei politici ora non è più semplice, ma semplificata
11 Dicembre 2022Tommaso Mozzati, MADRID
Che gala elegante quello organizzato al Thyssen-Bornemisza di Madrid per aprire, pur con qualche settimana d’anticipo, la ricorrenza tonda del prossimo anniversario picassiano, accordando nelle sale del più chic fra i musei della capitale una serie cospicua di dipinti del «gran malagueño» col defilé di molte, impeccabili mises servite da Mademoiselle Chanel all’incanto dei ruggenti anni venti: idea che sembra ispirata ai balli sulla Quinta vivificanti l’esistenza del Met ogni primo lunedì di maggio e che d’altra parte trova uno precedente immediato, poetico e metodologico, in un’ormai storica esposizione di quel tempio del glamour americano.
Nel lontano 1998 è stato infatti il Costume Institute, allora gestito da Richard Martin, a dedicare una rassegna pioniera al dialogo dell’avanguardia massimamente intransigente, il cubismo severo conteso nel primato di Braque e Picasso, con le frivolezze effimere della moda, verificando quanto nella cerchia stretta del tout-Paris la visione dei quadri antiprospettici e costruttivi proposti dallo spagnolo assieme a una banda per lo più francofona avesse favorito tendenze inedite in tema di audacie vestimentarie, sia nei guardaroba delle aggressive socialites che negli ateliers dei sarti d’ampio grido.
In quell’evento, vecchio già d’un quarto di secolo, la parte del leone se l’era però conquistata la figura ieratica di Madeleine Vionnet, segnando gli spazi espositivi dell’istituzione newyorkese coi tagli obliqui dei propri abiti, tradotti in balle di metraggio insolito e concepiti per liberare il corpo femminile dalle rigide strutture di busti o corsetti. Ce lo ricorda – memoria precisa e maliziosa della scena culturale di Manhattan – la testimonianza di Roberta Smith, occhialutissima firma del New York Times, che nella sua recensione a pochi giorni dal vernissage individuava il cuore del percorso in nove creazioni della stilista loiretana, la cui economia di mezzi – in accordo con lo sfarzo eclatante del risultato finale – sintetizzava agli occhi della critica e a favore del pubblico la visione di un modernismo incarnato, sospeso con sagacia fra sperimentazione e mondanità.
Certo, neppure Chanel poteva mancare dal panorama di Martin, che in catalogo riconosceva ai suoi modelli una «deliberata smaterializzazione», volta a infrangere la resistenza scultorea degli indumenti decimononici in favore piuttosto di bidimensionalità trasparenti, aperte all’«interno», disponibili cioè a mostrare le linee dei muscoli, esaltandone la mobilità improvvisa, gli scatti nervosi, magnificando l’elastica consistenza di un sano allenamento: ritratto cubista su stoffa (anziché su tela), verrebbe da pensare seguendo il pensiero del curatore, nelle orecchie le conclusioni acute condotte nel ’38 da un aureo libretto, dedicato per l’appunto a Picasso, opera dell’oracolo sacrale – sornione e austero – che a Parigi andava sotto il nome di Gertrude Stein.
Non apparirà dunque pleonastico che – forti di un simile precedente, erede a sua volta della lezione museografica dell’inossidabile Diana Vreeland – si torni a meditare sul modo in cui il vangelo avanguardista possa avere influenzato il magistero di un’altra grande interprete del Novecento, figlia illegittima di giovane contadina, debuttante in veste di cappellaia à la page e poi regina della Ville Lumière, di Deauville e di Biarritz grazie a manifesti fragili di minima sofisticazione, imbastiti per annunciare l’attualità sicura dell’«economico-costoso, della miseria ricca, della povertà incantatrice» (lo slogan è uscito dalla penna avvelenata di un parvenu di successo della fatta di Maurice Sachs).
Del resto Pablo e Coco furono amici, nel corso di vite longeve e produttive coincidenti con gran parte del secolo passato.
Basterebbe per attestarlo il ritratto del pittore, assieme amaro e affettuoso, consegnato dalla stilista alle note di Paul Morand, nel corso di una conversazione intrattenuta a Saint Moritz nel 1946, al principio dell’esilio svizzero che avrebbe costretto Mademoiselle lontana dalla Francia sino al decennio successivo. D’altronde, pure l’immenso lavoro storiografico ormai riconosciuto all’una e all’altra figura ha contribuito a rimpinguare la cronaca di un legame siffatto fra pettegolezzi persistenti, miti imperituri e dati incontrovertibili. Pare, ad esempio, che il loro incontro avvenisse in occasione del debutto parigino di Parade, complice la moglie impicciona dell’artista catalano José Maria Sert, Misia Godebska; non è chiaro però se, per la prima, Chanel condividesse un palco al Théâtre du Châtelet con altri protagonisti del bel mondo intellettuale, da Jean Cocteau a Erik Satie, da Paul Rosenberg a Michel Georges-Michel. L’archivio parigino del Musée Picasso conserva poi l’invito a una festa organizzata in Faubourg Saint Honoré per un altrettanto imprecisato «24 giugno», assieme alla foto della volitiva Coco scattata da Madame D’Ora attorno al 1927; è però dibattuta la presenza della donna alle prime nozze dell’artista, come non viene comprovata da corrispondente ricevuta d’acquisto la scelta per la cerimonia di un bianco abito Chanel da parte della moglie del pittore, la ballerina Olga Khokhlova, erede di un’elegante famiglia di San Pietroburgo.
Proprio sui gusti di Madame Picasso indaga una sezione della mostra madrilena: Olga fu infatti, sin dagli anni dieci, cliente fedele della maison, tanto a Parigi quanto sulla costa basca, e tramite i molti scatti che documentano la coppia in un ménage ancora felice è possibile distinguere dei capi di produzione certa, pur dentro alle testimonianze rarefatte riferibili alla fase d’avvio della casa sartoriale, quando la stilista sbarcava sulle pagine di «Les Élégances Parisiennes». Merito squisito di un simile focus è, fra l’altro, l’aver riconosciuto in un disegno a matita, fin qui ritenuto un ritratto di Marguerite Ida Loevi, l’ennesimo omaggio dell’artista all’ovale perfetto di Olga, pure sulla base di una scelta vestimentaria: l’abito indossato dall’effigiata è infatti lo stesso catturato in una foto casalinga, intesa per immortalare lo chic assoluto della danseuse russa nel suo completo da sposa, la festa conclusa da tempo.
Pablo e Coco si trovarono perfino a lavorare assieme, complice lo charme coinvolgente di Cocteau, fedele corrispondente del primo, affettuoso sostenitore della seconda. Sulla scia della partnership coi Balletti Russi, il poeta di Plaine-Chante avrebbe chiamato entrambi a partecipare a due diversi allestimenti, coinvolgendoli nella messa in scena de Le train bleu, voluta da Diaghilev, e nell’autonoma produzione dell’Antigone di Sofocle, tagliata e rivista per i frequentatori distratti dei teatri parigini. Gli spettacoli, ciascuno nel proprio ambito, dovettero rivelarsi dei successi immediati, confermando fra 1922 e 1924 l’allure mondana dei singoli collaboratori. Di certo, però, fu Chanel ad avvantaggiarsi soprattutto del plauso unanime. Se infatti Cocteau, sponsorizzando la tragedia, ne aveva giustificato il contributo col solito garbo paradossale – «non posso immaginarmi le figlie di Edipo mal vestite» –, le molte interviste concesse dal drammaturgo, così come la vicinanza col genio malagueño, dovettero sancirne lo statuto di «plus grande couturière de son époque».
A fronte di rapporti tanto densi, tutti ben documentati in percorso, la mostra di Madrid riesce però a dimostrare il dialogo formale fra una pochette del 1928 e un ritratto femminile del 1914, fra un cappotto con pelliccia del 1918 e una testa d’uomo di cinque anni prima? I confronti, a volte suggestivi, sono di fatto scelti con cura, spesso utili a sostenere la tesi sottesa al progetto: d’altronde niente meglio che la bottiglia originale dello Chanel n. 5 può far eco ai ragionevoli bodegones picassiani, nel dialogo vitale intrattenuto dal cubismo con le forme e le presenze della realtà quotidiana.
https://ilmanifesto.it/sezioni/alias-domenica




