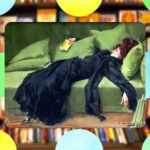Come un Dante Alighieri peregrinante alla ricerca di paradisi nascosti negli inferi, lo scrittore Pico Iyer ha occhio lucido e la valigia piena di saggezza e di studi. Lo dimostra, di nuovo, nel suo La vita a metà conosciuta. Viaggi in cerca del paradiso (Einaudi). In questa indagine laica ma spirituale, Iyer, che come il filosofo della Mirandola da cui prende il nome crede che l’uomo sia un microcosmo, capisce presto che «un vero paradiso ha senso solo dopo aver superato le nozioni di perfezione e aver preso le misure della fallibilità umana». Nel percorso tra Iran, Corea del Nord, Irlanda del Nord, Kashmir, Australia, Ladakh, Sri Lanka e Gerusalemme, il racconto nitido evoca con eleganza il magnetismo di luoghi considerati come paradisi, evitando gli eccessi emotivi che annebbiano lo sguardo. L’autore ci parla dalla casa di Los Angeles acquisita 60 anni fa dai genitori di origini indiane, nel cui giardino, passeggiando durante il lockdown, ha scoperto che il paradiso è davvero dietro l’angolo.
Cosa si intende per paradiso?
«Molti di noi credono che il paradiso sia un luogo fisico, ricoperto d’oro. Ma il buddismo ci ricorda che tutto è in costante cambiamento. Se siamo soli in una spiaggia soleggiata, ci sembra il paradiso. Poi cala la notte, arriva la pioggia, o si popola di gente: svanisce l’incanto. Ho visitato molti luoghi considerati come paradisi: Tahiti, Seychelles, Bali… Quello che per i visitatori è un paradiso, non lo è per chi ci lavora per creare comodità. Per loro magari il paradiso è a Venezia o a Santa Monica. Io cerco di eliminare le proiezioni e le illusioni sull’idea di paradiso».
Nelle ricerche emerge un netto collegamento tra i “paradisi” e il conflitto. Dove c’è il sacro c’è anche lo scontro. Colpa della religione?
«Direi colpa di come applichiamo la religione. Il paradiso potrebbe essere molte cose belle, ma cosa ne facciamo del paradiso, questo è il punto. Siamo così imperfetti… La mia inchiesta attraversa tante zone di guerra o di conflitto, dove il contrasto è tra le possibilità e ciò che ne facciamo. Per questo Gerusalemme è al cuore del libro. Non sono né cristiano, né ebreo, né musulmano, ma sento un richiamo magnetico verso questo luogo potente che è anche città del conflitto. Perché la tua interpretazione del paradiso è diversa dalla mia. Così nasce il contrasto estremo. Quel che la mente fa con la possibilità del paradiso è il problema. Ci è stata fatta una promessa, noi ne facciamo un bel pasticcio».
Forse perché carichiamo tutto con troppi pensieri?
«Sì, la religione riguarda lo spirito, non il pensiero. Se ti arrovelli nel pensiero, perdi l’utilità del silenzio. Se ti ingarbugli nelle parole, saranno sempre diverse dalle mie. Il Dalai Lama ha scritto La felicità al di là della religione perché ha visto quanti danni ha fatto la religione e ci propone di andare oltre».
Il Dalai Lama dice che il luogo conta: l’isolamento himalayano ha contribuito a sviluppare le capacità meditative nei tibetani. Crede che il paradiso si celi nella solitudine del silenzio, tema del suo prossimo libro? Come si fa a ottenerlo? È alla portata di tutti?
«L’unico paradiso nel quale credo è quello per tutti: dev’essere universalmente accessibile. Ecco il problema delle religioni. Si dice: questo paradiso non è per certuni, le porte si aprono solo a chi crede nella dottrina. Ma no: il paradiso dev’essere di tutti. Riuscire a trovare un paradiso dentro di noi è il primo passo. Ma dobbiamo riuscire a trovare il paradiso nella vita, tra complessità, sofferenze, conflitti. I monaci di tutte le confessioni fanno così. Il Dalai Lama ha sofferto più di chiunque altro io abbia conosciuto. Ha perso 13 fratelli, è in esilio da 66 anni, il governo di uno dei Paesi più potenti al mondo lo definisce “un diavolo.” Eppure non fa altro che emanare fiducia, con un sorriso contagioso e una risata continua. Dentro di sé sembra avere assoluta chiarezza e calma. Sembra aver trovato un paradiso. Perché il paradiso è un modo di vedere e di essere. Quando sei in allineamento con te stesso puoi trovare ciò di cui hai bisogno ovunque ti trovi».
«Non sono affatto preoccupato da questo. Penso che un luogo sacro abbia un suo carisma. È l’equivalente geografico di una persona. Decine di migliaia di persone possono raccogliersi attorno al Dalai Lama, ma nulla lo danneggia. Vive oltre le nostre proiezioni e intenzioni. E così per i luoghi speciali. Varanasi è un luogo rumoroso e incredibilmente caotico. Ma, come Gerusalemme o Lhasa, può affrontare tutti i cambiamenti politici o essere calpestato da non so quanti turisti: nessuno lo scalfirà».
La sacralità è più forte della nostra fame per essa?
«Giusto, questo è il tema del mio libro. Esiste un potere nel mondo più grande di noi. Oltre le parole».
A proposito di Varanasi, una città della morte che definisce città della gioia: è possibile che proprio dove non c’è paura della morte, perché è così vicina, si possa trovare più facilmente la gioia di vivere?
«Ho scritto questo libro durante la pandemia, quando convivere con l’idea della morte ci ha costretto a pensare a come vivere. Nonostante la tristezza e la sofferenza, noi sopravvissuti ci siamo sentiti più vivi. Abbiamo pensato a come investire di più senso la nostra esistenza. Durante il lockdown eravamo più vicini alle nostre famiglie e amici, alle cose a cui diamo più valore. Forse un po’ di tutto ciò è filtrato nel libro. Il fatto che nulla conta è proprio la ragione per cui tutto conta. La consapevolezza della morte aiuta a trovare una salvezza. Il paradiso non è stare da soli in quella spiaggia dorata alle Seychelles, ma nel mezzo di Varanasi. Trovare la gioia nel caos, capendo che nulla finisce e tutto cambia».
Come lei scrive: «i luoghi che cerchiamo di evitare sono più vicini a ciò che noi siamo davvero di quelli che cerchiamo di raggiungere a tutti i costi». Cita il monaco americano Thomas Merton che spiega che più cerchiamo di evitare la sofferenza, più soffriamo. Ma, allora, bisogna evitare il viaggio della ricerca spirituale, o essa è inevitabile per arrivare a comprendere davvero quanto sia inutile?
«Il paradiso trova noi. Non il contrario. Sappiamo che ciò che cerchiamo è diverso da quello che troviamo. La felicità ci coglie di sorpresa, come il paradiso. Non dobbiamo cercarlo, perché la nostra comprensione è limitata. Il paradiso è più ampio di come riusciamo a concepirlo. Un saggio giapponese mi disse: “nella tua sofferenza troverai il paradiso”, riferendosi alle persone crocefisse accanto a Cristo. Il paradiso non si trova nel piacere, che può essere un tranello, ma può essere nel cuore della sofferenza: una comprensione, quindi, della vera realtà».
E cioè, come lei scrive, «cercare di realizzare un sogno poco realistico è un insulto alla realtà, al sognatore e al sogno». Significa che dobbiamo impegnarci a cambiare la nostra percezione invece di metterci in viaggio alla ricerca di uno Shangri-la?
«Il viaggio è sempre donchisciottesco, non porta al paradiso. Bisogna schiarire la mente. Monaci e monache lo trovano stando fermi. Durante la pandemia, qui nella casa di mia madre, passeggiando per 20 minuti, mi guardavo attorno e mi dicevo: qui, dietro casa, è bello quanto Cape Town, Rio de Janeiro, Capri! Non avevo mai pensato di cercarlo qui, finché non ci sono stato costretto. Ciò di cui abbiamo bisogno è sempre qui, se solo avessimo gli occhi per vederlo».
Il libro
“La vita a metà conosciuta” di Pico Iyer, Einaudi. Traduzione di Duccio Sacchi, pagg. 192, euro 18,50